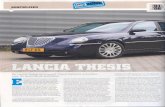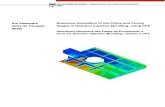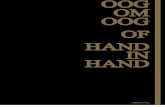thesis pieter
-
Upload
pieter-goffin -
Category
Documents
-
view
56 -
download
6
Transcript of thesis pieter

KU LEUVENFACULTEIT LETTEREN
BLIJDE INKOMSTSTRAAT 21 BUS 33013000 LEUVEN, BELGIË
Da notomia a zotischare
Indagini etimologiche sul lessico scientifico in un volgarizzamento astampa della Chirurgia di Guglielmo da Saliceto
Pieter Goffin
Masterproef aangeboden binnen de opleidingmaster in de Taal- en Letterkunde
Promotor prof. dr. Elwys De Stefani
Academiejaar 2014-2015
159 736 tekens

Abstract
This thesis is the report of an etymological research upon a selection of scientific vocabulary,encountered in an early 16th century vernacular version of William of Saliceto's Chirurgia. Thelexical items are being examined as to their local meaning in the text as well as to their formal andsemantic origin and their eventual further development in some northern varieties of Italian.
Particular attention is given to the degree to which the words that are used in this specific text arebeing used in later stages of the language. In order to analyse the usage of the words in context, atranscription of the fourth book of the treatise is included and discussed.
The reconstruction of the etymological development and lexicalisation of the words involves alexicographical research on Latin, Standard Italian and Italian Dialect dictionaries. Two othermethodological approaches – a corpus research within Google NGram Viewer and audio-recordedinterviews with dialect speakers – are touched upon. I'll argue that these approaches offer new andinteresting perspectives, but that the former method is still too little developed to obtain trustworthyresults and that the latter approach requires a more extended period of field work and datacollection. Hence, the tendencies that emerge from these inquiries will be confronted with theresults of the lexicographical analysis, which remains the most important focus in this paper.
Most of the selected vernacular lexical items, although being integrated in the scientific discourse(i.c. the field of anatomy) – which requires a certain degree of formal transparency and semanticconsistency – present regionally marked phonetic and morphological features and semanticrelationships that are not always consistent. I ascribe this to the explicitly stated pedagogical aim of the volgarizzamento, in which the scientificknowledge is transmitted by juxtaposing both Latin and vernacular expressions, so that a new,diversified and layered terminological framework can easily be acquired. This particular kind ofdealing with scientific lexicon makes the volgarizzamento an interesting genre to study, eitherwithin the evolution and development of the vernacular medical terminology, as with respect to thetechniques of scientific communication and popularisation.
i

Desidero innanzitutto ringraziare il relatore della tesi, il Professor Elwys De Stefani, per ilsostegno, i commenti perspicaci, i consigli preziosi. Un sincero ringraziamento anche a ChristopheWeets, Simon Van Roost e Andy Peetermans, che hanno seguito con entusiasmo le mie indagini. Leloro associazioni interessanti, i loro commenti critici e le successive discussioni appassionateportavano non di rado idee rinfrescanti. Inoltre ringrazio sentitamente Katrien Van Riet e MarcVercruysse per l'immancabile aiuto nei momenti cruciali per portare a buon fine questo lavoro.Ringrazio Jan, Annemie, Zahra e Emerald per la loro amicizia e gli incoraggiamenti. La tesi èdedicata a Sanne Mols, per essermi stata vicina durante ogni momento di questo periodo di lavoro.
ii

Indice0. Introduzione......................................................................................................................................31. Guglielmo vulgare in Cirugia...........................................................................................................4
1.1 Inquadramento storico...............................................................................................................41.1.1 Il physicus, il medicus e la posizione di Guglielmo da Saliceto........................................41.1.2 Percorsi di volgarizzamento...............................................................................................5
1.2 Inquadramento geografico.........................................................................................................62. Lingua comune e discorso specializzato: uno stato dell'arte............................................................7
2.1 Definizione e denominazioni.....................................................................................................72.2 La dimensione verticale: divulgare e tradurre...........................................................................8
2.2.1 Divulgare............................................................................................................................82.2.2 Tradurre..............................................................................................................................9
2.3 Divulgare e tradurre nel tardo medioevo e nel Rinascimento: la posizione intermedia dei volgarizzamenti................................................................................................................................92.4 I volgarizzamenti scientifici e la creazione di una terminologia.............................................10
2.4.1 Livello del discorso: l'introduzione di parole nuove........................................................102.4.2 La lessicogenesi o coniazione delle parole per dire la scienza........................................11
2.4.2.1 Aspetti morfologici...................................................................................................123.4.2.1.1 Neoformazione intralinguistica: derivazione, composizione e collocazione. . .12
a) derivazione..............................................................................................................12b) La composizione e le collocazioni..........................................................................13
2.4.1.2.2 lingue in contatto: prestiti.................................................................................132.4.2.2 Aspetti semantici......................................................................................................14
2.4.2.2.1 Neologia semantica intralinguistica..................................................................142.4.2.2.2 lingue in contatto: calchi...................................................................................14
2.5 Percorsi etimologici.................................................................................................................142.5.1 La paretimologia..............................................................................................................15
2.5.1.1 La rianalisi morfologica...........................................................................................152.5.2 La trasmissione di testi manoscritti: rimotivazione a partire dalla cacografia.................162.5.3 Ipercorrettismi..................................................................................................................16
2.6 Percorsi di stabilizzazione lessicale.........................................................................................172.6.1 Significati usuali e occasionali.........................................................................................172.6.2 La nozione di 'diagrammaticità'.......................................................................................172.6.3 Fattori geolinguistici........................................................................................................18
3. Metodo............................................................................................................................................183.1 Costituzione del corpus............................................................................................................18
3.1.1 Selezione del testo............................................................................................................183.1.1.1 Trascrizione di una versione vernacolare.................................................................18
3.1.1.1.1 Convenzioni di trascrizione..............................................................................193.1.1.1.2 Procedimento e problemi pratici.......................................................................19
3.1.1.2 Il Guglielmo vulgare come traduzione: uno sguardo al testo latino.........................203.1.2 Selezione dei termini........................................................................................................20
3.2 Tra etimologia e traduzione.....................................................................................................223.2.1 Il Guglielmo vulgare come punto di partenza..................................................................223.2.2 Dizionari etimologici e dialettali......................................................................................223.2.3 Altre fonti.........................................................................................................................22
3.3 Percorsi di lessicalizzazione....................................................................................................233.4 Prospettive di ricerca: sondaggi e rilievi orali.........................................................................23
1

4. Analisi.............................................................................................................................................254.1 Nothomia/notomia...................................................................................................................254.2 Bossolo, bussolo, pesse (de la gola)........................................................................................334.3 Didimo.....................................................................................................................................364.4 Gombedo..................................................................................................................................384.5 Malmenchion...........................................................................................................................394.6 Merisfagus, meri, canna del stomego......................................................................................414.7 Morene.....................................................................................................................................434.8 Osso de la lauda e ossi vernali.................................................................................................444.9 Petenegio, petencio, petenechio...............................................................................................464.10 Scaio, schaio, asela................................................................................................................524.11 Strangosare.............................................................................................................................544.12 Zotischare...............................................................................................................................564.13 Discussione dei risultati.........................................................................................................60
5. Conclusione....................................................................................................................................626. Bibliografia.....................................................................................................................................64
6.1 Documenti................................................................................................................................646.2 Articoli e libri...........................................................................................................................656.3 Dizionari e atlanti linguistici....................................................................................................686.4 Entrate in opere enciclopediche...............................................................................................706.5 Figure.......................................................................................................................................71
Appendice: Trascrizione dell'Anatomia.............................................................................................72
2

0. Introduzione
Nel presente lavoro discuteremo da un punto di vista diacronico una serie di voci che occorrono inun determinato ambito del discorso specializzato; quello dell'anatomia. Le parole esaminateprovengono da Guglielmo vulgare in Cirugia, un volgarizzamento cinquecentesco della Cirurgia,un trattato medico scritto in latino nel XIII secolo dal medico bolognese Guglielmo da Saliceto.
Uno studio precedente sul lessico scientifico nel Guglielmo volgare, eseguito da Altieri Biagi(1970), si caratterizza da un'impostazione sincronica. Vengono studiati il significato e lacircolazione delle voci in una data epoca. Anche se vengono presentate le concordanze fra il lessicovernacolare e quello latino, manca una vera e propria ricerca etimologica. La prospettiva diacronica che abbiamo scelto di adottare in questa sede, richiede una maggioreattenzione per il percorso retrospettivo, indagando l'origine delle voci (§2.5 percorsi etimologici),ma anche per il loro sviluppo e i loro contesti d'uso dopo una (prima) attestazione nel quattro-cinquecento (§2.6 percorsi di stabilizzazione lessicale). In questa ottica, il Gulgielmo vulgare funziona come una specie di serbatoio. Fornisce un campionedi voci che si usano nel discorso sull'anatomia in quella determinata epoca. Le voci sono stateselezionate in base al loro carattere “divergente” dall'etimo latino (§3.1.2 selezione dei termini). Ladivergenza può essere formale o semantica. Alcune delle voci selezionate si sono mantenute fino ai giorni nostri, altre sono cadute in disuso.Fattori che possono favorire o sfavorire la sopravvivenza di una voce sono la sua natura regionale osovraregionale (§3.6.3), la sua composizione “regolare” o meno (§2.6.2) e il significato che vieneespresso dalla voce nel contesto specifico del Guglielmo vulgare (§2.6.1).Nello scopo di includere quest'ultimo aspetto nella presente tesi, abbiamo realizzato una trascrizionedel quarto libro della Cirurgia (in annessi), che finora non era ancora disponibile.
Questa tesi si articola pertanto in cinque parti. Nel primo capitolo è previsto un inquadramentostorico e geografico della Chirurgia, il testo che costituisce il corpus del nostro lavoro.Il secondo capitolo comprende la parte teorica, in cui si discute la nozione di discorso specializzato(§2.1), il concetto di volgarizzamento (§2.3), che tiene una posizione di mezzo fra divulgazione etraduzione scientifica (§2.2) e il modo in cui la natura stessa del volgarizzamento ha delleimplicazioni per il discorso scientifico in generale (§2.4.1) e per il lessico in particolare (§2.4.2).Il terzo capitolo è dedicato alla descrizione della metodologia che abbiamo seguito. Primapresenteremo il metodo della trascrizione del testo vernacolare e i problemi riscontrati (§3.1).Giacché nell'analisi delle voci esse verranno confrontate con le voci latine corrispondenti tratte dauna ricostruzione ottocentesca della Cirurgia, faremo una breve riflessione sulle implicazionimetodologiche dell'uso della versione latina di cui ci serviamo come punto di riferimento (§3.1.1.2).Segue una presentazione del modus operandi della nostra analisi e delle fonti che abbiamoconsultato per stabilire il percorso etimologico (§3.2) e il percorso di lessicalizzazione delle vociselezionate (§3.3).In un quarto capitolo si procederà all'analisi delle voci (§4.1-12) e alla discussione dei risultati(§4.13). La trascrizione in annessi costituisce la quinta parte importante della tesi.
3

1. Guglielmo vulgare in Cirugia
1.1 Inquadramento storico
1.1.1 Il physicus, il medicus e la posizione di Guglielmo da Saliceto
La figura di Guglielmo da Saliceto (Saliceto 1210 – Piacenza 1277) s'inserisce nel quadro storicodell'insegnamento medico a Bologna nel XIII secolo. La formazione dei medici si svolgeva nellecase private di maestri-medici. Intorno a loro si formarono delle corporazioni (societates),consistenti di studenti (socii) e un maestro (magister medicus) (Agrimi & Crisciani 1994: 61-62). Ilcorso, dispensato oralmente, prevedeva insegnamenti teorici, ma anche una importante formazionepratica, in cui i soci dovevano osservare ed aiutare il loro maestro quando effettuava interventichirurgici.
La scuola più riconosciuta in quell'epoca fu quella di Orlando e Ugo Borgognoni. Arrivato aBologna intorno all'anno 1230, Saliceto avrebbe cominciato il suo percorso come socio di Ugo, cheè comunemente accettato come il fondatore della medicina a Bologna (Agrimi & Crisciani 1994:62-63). La sua formazione era pertanto basata tanto sulla doctrina quanto sull'usus. Su questoconnubio di teoria e prassi Saliceto fonderà il suo proprio metodo scientifico.
L'evoluzione del sapere nel campo della medicina, da poco tempo introdotta come materia nelcurriculum universitario, spinge Saliceto a presentare più sistematicamente e per iscritto leconoscenze – e competenze – che vuole trasmettere. Con la scelta di redigere dei trattati, adutilitatem studentium1, rompe la tradizione fondata esclusivamente sull'insegnamento orale dei suoiprecessori.
Le due opere più importanti di Saliceto sono la Cirurgia (12682) e la Summa curationis etconservationis (scritto probabilmente fra il 1268 ed il 12753). Il lettorato dei rispettivi testi eradiverso.
La Summa si presenta come un manuale che segue l'approccio scolastico, propagato dalle universitàsempre più importanti nell'epoca alto-medievale. Il testo si rivolge quindi ad un pubblico di medicirationales. Ciò si riflette nei frequenti riferimenti alle autorità greche, alludendo anche a trattatiaccessibili da poco tempo (Agrimi & Crisciani 1994: 64). La Cirurgia si orienta invece più verso prassi; si rivolge ai medici manuales o restauratores.Tuttavia, ciò non significa che mancherebbero riflessioni critiche e teoriche. Al contrario,Guglielmo da Saliceto condanna gli interventi ad hoc, senza che ci sia una metodologia rigorosa. Lamedicina è per lui una scienza a tutti gli effetti. Il discorso scientifico non deve trattare gli interventiparticolari, bensì un modus operandi generale (“scientia docens modum operandi”) (Agrimi &Crisciani 1994: 68). E' precisamente grazie al possesso di un quadro metodologico interiorizzatoche il buon medico puo agire in modo competente in una situazione particolare4.
1 Chirurgia: 'Explicit Cyrurgia magistri Guillelmi Placentini de Saliceto, quam ipse compilavit in civitate bononiensi ad utilitatem studentium Millesimo ducentesimo sexagesimo octavo' – citato in Agrimini & Crisciani (1994: 64).
2 Agrimi & Crisciani (1994: 64) segnalano una seconda versione della Cirurgia, finita a Verona intorno al 1275. Non è chiaro se e in quale misura questa seconda versione è diversa dalla prima. In assenza di un'edizione critica del testolatino, e di qualsiasi riferimento alla seconda redazione come “diversa” nella letteratura secondaria, prendiamo cometesto di riferimento (e di paragone) la ricostruzione stabilita da Otto Schaarschmidt (cf. §3.1.1.2 Uno sguardo al testo latino).
3 Agrimi & Crisciani (1994: 64).4 « Ille est melior medicus, qui novit aptare vel contrahere quod docetur in universali ad particulare », citato in Altieri
4

Saliceto stesso rivendica con orgoglio la sua posizione intermedia fra teoria e prassi. Criticaseveramente sia i chirurgi che intervenivano senza dottrina (i cosiddetti laici), sia i medicidogmatici che non volevano sporcarsi le mani e lasciavano l'“operare” ai barbieri (Altieri Biagi1970: 17).
Un'arma intellettuale maneggiata da Guglielmo da Saliceto contro i laici ignoranti, è la linguastessa. Guglielmo denunciava la terminologia “corrotta” di questi empirici. La terminologia usata daSaliceto si avvicinerebbe di più al discorso scientifico universitario. Altieri Biagi (1970: 12-13) citaalcuni esempi tratti dal primo libro della Cirurgia: “crusta et scabies in capite et fronte puerorumqui lactantur [...] lattucium a laycis [appellantur].” (I, 2), “sincopis appellatur somnus a laycis” (I,59).Una tale attenzione terminologica già nel testo latino, rende ancora più complicato il compito delvolgarizzatore. Egli infatti deve rendere intelligibile non solo i concetti scientifici del testo latinonella lingua vernacolare, ma anche le differenze di registro nella lingua-fonte. Tali necessitàrendono interessante lo studio di un volgarizzamento, perché è probabile ritrovare una molteplicitàdi denominazioni più o meno dotte per uno stesso concetto; cosa che è meno probabile in altri tipi ditesti.
1.1.2 Percorsi di volgarizzamento
La versione latina del trattato di Guglielmo da Saliceto conobbe un'ampia diffusione. Heimerldocumenta non meno di 46 manoscritti tramandati5. A partire dal XIV secolo disponiamo anche diuna ricca tradizione manoscritta in lingua vernacolare, di cui non meno di 26 manoscritti ci sonopervenuti6. Da un punto di vista linguistico, l'insieme di manoscritti vernacolari si suddivide inalmeno 2 gruppi: una “famiglia” settentrionale ed una fiorentina. Esistono inoltre manoscritti chepresentano proprietà linguistiche di entrambe le varietà . Anche all'interno di uno stesso gruppo, visono divergenze notevoli, dovute a diverse traduzioni e rimaneggiamenti (Coco & Di Stefano 2008:58). Per quanto riguarda i testi a stampa della Cirurgia, notiamo una preferenza per ivolgarizzamenti: l'editio princeps in lingua vernacolare (14747) precede di due anni l'editio princepsdel testo latino (14768) e ha conosciuto un maggior numero di riedizioni. Il testo latino dellaCirurgia venne inoltre pubblicato insieme alla Summa, come una specie di compendio, e non informa autonoma, come la versione volgare.
Il corpus per questo studio è un volgarizzamento pubblicato a Milano nel 1504. Se la datazione dellibro-materiale è reperibile nell'edizione stessa9, stabilire con precisione la genesi del testo cheabbiamo sotto gli occhi, è un'impresa pressoché impossibile. Come abbiamo accennato sopra, ilvolgarizzamento della Cirurgia è stato un processo dinamico fatto di molteplici traduzioni erielaborazioni, e notizie che riguardano il testo-fonte usato dall'editore e dal traduttore sono
Biagi (1970: 16).5 Per una documentazione esaustiva, cf. Heimerl (2008: 93-96)6 Si contano i manoscritti documentati da Heimerl (2008: 93-96), completate con i dati bibliografici forniti da Coco e
Di Stefano (2008: 59-60).7 La ciroxia vulgarmente fatta (1474) Venezia: Filippo di Pietro8 Summa conservationis et curationis. Chirurgia (1476), Piacenza: Johannes Petrus de Ferratis9 Qui finisse la cirugia de Maestro Gulielmo da Piasenza divisa in cinque
libri vulgarmente. Impressa in la Inclita Cità de Milano per Johanne AngeloScinzenzeler. Neli anni del nostro Signore 1504. El di XXVI de Octobre.
5

assenti10. La distanza fra il terminus post quem (1268, fine della stesura del testo latino) e ilterminus ante quem (1504, anno di pubblicazione del volgarizzamento) è un arco di tempo di più didue secoli.
Questo dato di fatto mette in luce la relatività del neologismo lessicografico, che si definisce inrapporto alla forma attestata in un documento materiale, e quindi con una realtà extra-linguistica. Quando nella nostra analisi facciamo riferimento alla prima attestazione, l'obbiettivo è quello disituare la genesi di una certa forma in una determinata epoca più globale (Antichità, Medioevo,Rinascimento, …) per collegarla a procedimenti linguistici tipici per quell'epoca (aferesi della primalettera dell'etimo nel Medioevo, ipercorrettismo grafico nel Rinascimento, …).
1.2 Inquadramento geografico
Il volgarizzamento sul quale abbiamo effettuato il nostro studio è stato pubblicato a Milano epresenta varie caratteristiche settentrionali (cf. 2.6.3 Fattori geolinguistici). Per la natura ibrida deltesto – che è frutto di una lunga tradizione –, una localizzazione più precisa non è possibile.Nondimeno, l'aspetto settentrionale, che si riflette nella formazione stessa di alcune voci, è unelemento di prim'ordine nello studio del volgarizzamento. Costituisce infatti la specificità del testo,presentando la terminologia dotta, latineggiante – e perciò più “universale” – in parallelo conespressioni più popolari, che inseriscono il testo in un determinato contesto spazio-temporale esociale.
10 La situazione si presenta altrimenti per l'area francese, dove il traduttore menziona esplicitamente il suo fonte:Cy finist la cyrurgie de maistre Guillaume de Salicet dit de Placennapar luy commancee a Bolongne et achevée et corrigée a Veronne l'an del'incarnation de nostre seigneur 1476 [sic] le xxve jour de may. Veue sur lelatin par honnorable homme maistre Nicole Prévost, docteur en médecine.Et imprimée a Lyon par maistre Mathieu Husz, imprimeur, l'an 1492 le xvie jour de novembre.
6

2. Lingua comune e discorso specializzato: uno stato dell'arte
2.1 Definizione e denominazioni
Gli elementi lessicali che formano l'oggetto del presente lavoro provengono da una fonte cherappresenta ciò che potremmo definire un discorso specializzato. La denominazione è tradotta daGotti, che definisce specialized discourse come “[the expression] which reflects more clearly thespecialist use of language in contexts which are typical of a specialized community stretchingacross the academic, the professional, the technical and the occupational areas of knowledge andpractice.” (Gotti 2005: 24).
Si preferisce parlare di discorso invece che di lingua (p.es. lingua speciale in Cortelazzo 1990,langue spécialisée in Lerat 1995) per sottolineare l'importanza dell'uso e dei contesti, mentre ladenominazione di lingua – intesa nell'opposizione saussuriana langue 'sistema' – parole 'produzioneindividuale e situata' – privilegerebbe la nozione di un sistema astratto e decontestualizzato.L'analisi diacronica di una selezione di voci renderà chiaro che il discorso specializzato comprendedegli elementi lessicali che acquisiscono il loro senso esclusivamente in determinati contestiscientifici e linguistici. Un approccio prettamente strutturalista è pertanto difficilmente sostenibile.
Altri termini correnti nella tradizione accademica italiana segnalati da Cortelazzo (1990: 7) sonolinguaggio speciale – come sinonimo di lingua speciale (a partire da Devoto 1939) – , linguaggiosettoriale o specialistico-settoriale (Beccaria 1973), tecnoletto (Wandruszka/Paccagnella 1974) emicrolingua (Balboni 1982). Spesso però, come sostiene lo studioso, “si ricorre a esplicazioni perenumerazione o si fa implicito riferimento a un'idea intuitiva di lingua speciale” (Cortelazzo1990:7).
Parlando di lingua, Cortelazzo non tiene tanto alla distinzione saussuriana fra langue e parole,quanto alla differenza tra lingua e linguaggio. Preferisce il primo termine sul secondo per “limitarela considerazione al codice verbale, escludendo altri sistemi di codificazione, che pure si affiancanoad alcune lingue speciali” (Cortelazzo 1990: 8). Una tale differenziazione tuttavia non è primordialeper questo studio, visto che nei documenti presi in esame altri sistemi di codificazione non sonopresenti. Data la molteplicità di interpretazioni delle nozioni di lingua e linguaggio in ambito italiano11, siprofila la necessità di un termine più trasparente. Lerat segnala la possibilità dell'inglese languagefor special purposes (1995: 19), in cui lingua e linguaggio si confondono. Per le lingue romanze, latraduzione dell'espressione inglese preferita da Gotti 2005 – specialized discourse – sembra fornireun'alternativa valida; it. discorso specializzato, fr. discours spécialisé.
Per quanto riguarda l'uso del participio passato specializzato, invece di speciale, ci allineiamo conLerat, che argomenta che una tale indicazione permette di esprimere una gradualità dispecializzazione, includendo nella definizione l'uso del discorso specializzato fra non-specialisti(1995: 20)12. Questa gradualità del discorso specializzato è un aspetto di prim'ordine nello studiodel lessico in un volgarizzamento scientifico quale il Guglielmo Vulgare in Cirugia.
11 Accanto alla visione di Cortelazzo 1990, Corbolante 2013 distingue lingua 'sistema' da linguaggio 'facoltà', 12 Per illustrare l'uso del discorso specializzato fra non-specialisti, Lerat 1995 dà gli esempi del cliente, del giustiziato,
del cittadino, del consumatore, del lettore e del telespettatore (1995: 20).
7

2.2 La dimensione verticale: divulgare e tradurre
Nello studio della comunicazione scientifica Trosborg (1997: 16) ha introdotto la metafora delloschema cartesiano. Sull'asse orizzontale si distribuiscono le varie discipline. L'asse verticale èquello che ci interessa maggiormente. Qui sono rappresentate i vari livelli di specializzazione.L'idea che regge questo modo di rappresentare il “campo scientifico” è quella che il discorsospecializzato si adatta a seconda dei livelli che interagiscono.
2.2.1 Divulgare
Per la comunicazione scientifica scritta attuale, Darian (1982) propone una divisione in 5 livelli:
1 Popular magazines, newspapers Uneducated layman2 Scientific American and popular
booksA reader conversant in thegeneral area
3 High-school text Layman – limited generalknowledge and technicalbackground information
4 Introductory college text Layman – educated to collegelever of general knowledge
5 Scholarly journal, specialized book-length study
Specialists and advancedgraduate students
(Darian 1982, cit. in Gotti 2005: 203-204)
La presentazione di Darian si focalizza sulle competenze scientifiche del lettorato di determinati tipidi testi. Gotti (2005: 204) aggiunge il criterio dello “scopo” (purpose) del testo, che può esserepedagogico o divulgativo (popularisation). Nei testi pedagogici vengono dati al lettore elementi concettuali e terminologici propri delladisciplina, in modo che acquisisca il quadro concettuale necessario per sviluppare un'ulterioreconoscenza nel campo scientifico in questione. Nei testi divulgativi non vi è l'intento di svilupparenel lettore un nuovo sistema concettuale e pertanto la lingua usata è più vicina alla lingua comune eall'esperienza quotidiana (Gotti 2005: 204).
Posizionare il nostro volgarizzamento cinquecentesco in questo schema è un'operazione spinosa,perché c'è il rischio dell'anacronismo. Lo scopo pedagogico, che Gotti (2005) associa ad unaspecifica attenzione terminologica, è esplicito ma nel contempo le voci presentano dei trattiregionali ed il numero elevato di paragoni concrete, rende il discorso molto vicino alla “linguacomune e all'esperienza quotidiana”. Siccome Saliceto scrive la sua opera espressamente per i suoi studenti, si potrebbe classificare laCirurgia fra la posizione 3 e 5 sulla scala di Darian (1982). Tuttavia, il trattato non vuole tantocostruire un discorso scientifico esaustivo (“intenzion non so numerare tuti li membri particular”)quanto fornire delle informazione pratiche. Questo aspetto “manualistico” non s'inserisce bene nellagraduatoria proposta. Nei paragrafi successivi si prenderanno in esame le proprietà specifiche delvolgarizzamento tardo-medievale e rinascimentale.
8

2.2.2 Tradurre
In quanto tutte e due operazioni in cui si cerca di trasmettere un certo contenuto, adattando ildiscorso ad un determinato pubblico, la divulgazione e la traduzione sono procedimenti strettamentecollegati.
Nel modello sviluppato da Jakobson (1966, cit. in Sarukkai 2001: 648) si distinguono tre tipi ditraduzione: la traduzione interlinguale, in cui si traduce da una data lingua ad un altra, quellaintralinguale, in cui si ricorre a frasi e parole differenti di una stessa lingua per comunicaresignificati simili e quella intersemiotica, una “interpretazione di segni verbali tramite l'uso di unsistema di segni non-verbali” (Sarukkai 2001: 648).Un problema che accomuna queste categorie è quello dell'equivalenza completa (completeequivalence), tratto distintivo di una traduzione perfetta, che non si realizza in nessuno dei tre tipi ditraduzione (Sarukkai 2001: 648). Questo problema emerge nella ricerca di sinonimi (re-wording) odi frasi alternative appropriate (re-writing) (Sarukkai 2001: 648).
La nozione stessa di equivalenza è multidimensionale. Essa può essere equivalenza referenziale, maanche connotativa, formale, pragmatica, etc. (Sarukkai 2001: 650). Sarukkai sottolinea inoltrel'importanza di vedere come funziona la nozione d'equivalenza per il lettore e le differenti culturecoinvolti nel processo di traduzione, oltre alla considerazione del solo testo (Sarukkai 2001: 650).Per le traduzioni attuali sarebbe possibile esaminare come differenti lettori e culture percepisconol'equivalenza in tutti i suoi aspetti tramite sondaggi o dispositivi sperimentali. In uno studio delle traduzioni medievali e rinascimentali, al contrario, le notizie sulla loro ricezioneda parte dei lettori sono assai scarse. E' invece possibile esaminare una quantità di testi e dimetatesti, da cui possiamo ricavare le idee e le pratiche della traduzione che circolavano all'epoca.
2.3 Divulgare e tradurre nel tardo medioevo e nel Rinascimento: la posizione intermedia dei volgarizzamenti
Mentre nelle attuali traduzioni interlinguistiche di testi scientifici, riferimenti espliciti a problemi ditraduzione sono rari (Sarukkai 2001: 650)13, la problematica dell'equivalenza fra le espressioni usatenel testo originale e quello tradotto è visibilmente presente nei volgarizzamenti di trattati tecnicitardomedievali e rinascimentali. Tant'è vero che i traduttori dell'epoca non avevano sempre adisposizione una parola vernacolare che esprimesse lo stesso significato che la voce che si trovassenel testo-fonte. Bazin-Tacchella osserva che i vari procedimenti di traduzione – “dal mantenimento del terminelatino alla traduzione del termine, passando per l'adattamento, il calco, il binomio sinonimico o laglossa” - caratterizzano un'esitazione fra i due obbiettivi del traduttore: “rendere il testo accessibileindipendentemente dal testo latino e mantenere le esigenze didattiche di un discorso preciso especializzato che possiede una propria terminologia” (Bazin-Tacchella 2005: 67). Lo statutointermediario del volgarizzamento fra divulgazione e traduzione è qui ribadito.
13 Secondo Sarukkai questa mancanza notevole è in gran parte dovuta alla convinzione diffusa che “l'essenza” dei testi scientifici stia nei principi matematici che sorreggono il ragionamento (mathematical subtext). Sarukkai stesso critica questa convinzione e ribadisce la presenza altrettanto importante di un natural language subtext (Sarukkai 2001: 650).
9

2.4 I volgarizzamenti scientifici e la creazione di una terminologia
Fra i vari procedimenti elencati da Bazin-Tacchella, vorremmo fare un'ulteriore distinzione fra letecniche che operano sul livello del discorso e quelle che si applicano alle singole espressioni.
2.4.1 Livello del discorso: l'introduzione di parole nuove
Due elementi paratestuali che possono inquadrare una voce sentita come non comune sono la glossae il glossario. La glossa è un'annotazione (in margine o a piè di pagina) che chiarisce un'espressioneche ha bisogno di spiegazione14. Il glossario è “un elenco (…) dei termini rari o difficili di untesto”15
Un'altra possibilità di stabilire un'equivalenza nel testo, senza perciò alterare l'espressione che sitraduce, è la creazione di un binomio sinonimico. Un tale binomio consiste dell'espressioneoriginale e di un'espressione equivalente.
Citiamo alcuni esempi tratti dal Guglielmo vulgare in Cirugia:
a. la canna del polmon, over trachea artaria, ch'è una medema cosa (8, 17)(Lat.: canna pulmonis vel trachea arteria – 22, 21)
b. el membro del homo id est el malmenchion (15, 15-16)(Lat.: membrum virile sive virga – 44, 20-21)
c. E col dezuno se continua il colon ver el budelo sotil (17, 15)(Lat.: Cum ieiuno continuatur yleon, seu gracile intestinum – 52, 4)
Si noti che il binomio sinonimico è già presente nel testo-fonte. Non è quindi una tecnica riservataalla traduzione, ma alla divulgazione scientifica; obbiettivo che accomuna la versione latina e ilvolgarizzamento. Infatti, nell'explicit della versione originale della Cirurgia (1268), l'autore esibisceuna esplicita intenzione pedagogica, affermando d'aver scritto il trattato ad utilitatem studentium.Solo nel caso b, il volgarizzamento non segue la fonte e combina l'espressione membro del homonon con verga – voce di cui si serve tuttavia nel seguito del testo – ma con l'espressioneesclusivamente vernacolare malmenchion.
Quanto alla struttura del binomio, l'elemento “meno comune” può trovarsi prima (b, c) o dopo (a)l'elemento “più comune”. In altri casi è difficile decidere quale dei due elementi sia più notodell'altro.
c. Sopra quelo velame, over panicolo (2, 31-32)(Lat.: Super istud velamen vel panniculum – 6,11)d. el chisto del fiele, overo el sachelo de la colora (16, 31)(Lat.: cystim fellis seu saculum colerae – 50, 6)
14 Enciclopedia Treccani, glossa15 Enciclopedia Treccani, glossario. Il Treccani aggiunge “in ordine alfabetico”, tratto che abbiamo omesso perché
esistono anche altri principi di organizzazione di un glossario
10

Tali casi illustrano l'intento pedagogico di sviluppare un nuovo quadro concettuale, nel qualevengono fornite tutte le espressioni con cui certi significati possono essere espressi. Talvolta ilnumero di tali espressioni non si limita a due, in modo che invece di binomio sinonimico, sarebbepiù preciso parlare di serie sinonimica.
f. quello loco se chiama salvatela over epatica over splenetica (11,25)(Lat.: illic vocatur salvatella seu epatica vel splenetica – 34, 5-6)
g. una, la qual è in la piegadura del brazo in mezo e fi chiamada purpurea over negra overcomuna (11, 27-28)(Lat.: quaedam vena, quae est in curvatura brachii in medio et vocatur purpurea seu nigra velcommunis [vel matrix a quibusdam] – 34, 7-9)
Un ultimo procedimento della divulgazione scientifica è quello di elaborare il binomio sinonimico,il modo che si ottenga una specie di definizione.
h. la nothomia, over l'ultima division deli membri (1, 27)(Lat.: anathomiam seu ultimam membrorum divisionem – 2, 19)
i. l'os<s>o, el qual se chiama petroso, cioè molto duro (4, 14)(Lat.: in osse, quod appellatur petrosum, et hoc est durum – 10, 8-9)
2.4.2 La lessicogenesi o coniazione delle parole per dire la scienza
Oltre che sulla struttura testuale e paratestuale, il volgarizzatore di testi scientifici lavora sul lessicostesso. Cortelazzo osserva che il discorso specializzato richiede una quantità di elementi lessicalimaggiore a quella richiesta dalla lingua comune. Per motivare questo bisogno lessicale (1990: 10)di certi settori specialistici, vede sostanzialmente due argomenti: l'uso di oggetti o nozioni estraneiall'esperienza quotidiana e il livello d'analisi più elaborato rispetto al senso comune (1990: 10).
Nel contesto della traduzione scientifica, si può venire incontro al bisogno lessicale della lingua incui si traduce tramite la trasformazione di espressioni già esistenti in quella lingua, o tramite leespressioni presenti nel testo-fonte. Queste trasformazioni si svolgono sul piano formale omorfologico (§2.4.2.1) e/o su quello del significato o semantico (§2.4.2.2). Nei paragrafi citatipresentiamo prima la formazione lessicale a partire da elementi lessicali già presenti nella lingua esuccessivamente a partire da elementi lessicali provenienti dalla lingua-fonte.
11

2.4.2.1 Aspetti morfologici
3.4.2.1.1 Neoformazione intralinguistica: derivazione, composizione e collocazione
Nuovi elementi lessicali che si costruiscono su elementi già esistenti sono risultati di unaderivazione o di una composizione.
a) derivazione
Il Garzanti Linguistica definisce la derivazione come il “processo di formazione di una parolanuova da un’altra già esistente, mediante suffissi o prefissi” (GL, 2014). Per definizione, unaderivazione è quindi costituita da una sola forma base (“parola”) in combinazione con uno o piùaffissi. Per completezza allarghiamo la categoria degli affissi, includendo anche gli infissi, interfissie circonfissi.
I circonfissi sono “morfi discontinui costituiti da un prefisso e un suffisso che stannoobbligatoriamente insieme” (Iacobini 2010a), come per esempio abbottonare (da un sostantivo) oaddolcire (da un aggettivo)16.
La distinzione fra infisso e interfisso non è sempre netta. In senso stretto, l'infisso è quel suono “cheviene inserito nell’interno di una parola, per lo più nell’interno della radice stessa; per es., in latino,la -n- presente nel verbo frangĕre, derivato dalla radice frag-” (Vocabolario Treccani 2014). Il Treccani non prevede un'entrata per interfisso, ma cita soltanto alcuni esempi, quali leoncino,rockettaro e finisco. Nel Dictionary of Grammatical Terms in Linguistics di Trask (1993: 144) èesplicitato inoltre che l'interfisso è privo di significato semantico17.
Nel Guglielmo vulgare siamo confrontati a morfemi con valore lessico-aspettuale18 come l'iterativo-ic- in zoppicare o -isc- in zotischare. Sono morfemi che non sono inseriti nella radice stessa, nésono “morfi privi di significato semantico”. Rohlfs (1969) lega tali morfemi al suffisso finaleottenendo cosi zopp-icare, zot-ischare. Data l'esistenza di rispettivamente zoppare e zotare, abbiamoscelto di categorizzare -ic- e -isc- come entità a sé stanti. Seguendo la terminologia di Meul (2011),parleremo di infissi.
Oltre alla derivazione mediante affissi, è stata descritta anche la derivazione zero o conversione; “laformazione, ottenuta senza aggiunta di affisso derivazionale, di una parola appartenente a una partedel discorso diversa da quella della base” (Iacobini 2010b). Per parte del discorso s'intende lacategoria grammaticale. Nel Guglielmo vulgare la conversione da verbo a sostantivo è frequente.
a. l'odorare (lat. virtus odorabilis) < odorareb. l'essise (lat. exitus) < essirec. l'aldire (lat.auditus) < aldired. lo strangosare (lat. sincopis) < strangosare
16 Esempi tratti da Iacobini 201017 “An empty morph occuring between a stem and a meaningful suffix” (Trask 1993: 144).18 termine ripreso da Meul 2011: 102
12

b) La composizione e le collocazioni
Contrariamente alla derivazione, dove si ha un solo morfema lessicale, la composizione è laformazione di un nuovo lessema, combinando due o più morfemi lessicali. Zwanenburg (1992: 170)distingue fra la composizione dotta (composition savante) e la composizione non dotta(composition non-savante). Il criterio distintivo della composizione dotta è l'uso di morfemi legati, che non hanno esistenzaautonoma (p.es. ana- 'ripetutamente'19 e -tomia 'taglio'). Sono i morfemi che Cottez (1980), autoredel Dictionnaire des Structures du Vocabulaire Savant chiama formanti (formants). Lacomposizione non dotta ricorre invece spesso a morfemi originariamente non legati20, così pessedela gola proviene da pesse (nome) + de (preposizione) + la (articolo) + gola (nome). La strutturadella composizione non dotta è formata da un determinato a sinistra (pesse) e un determinante adestra (de la gola) (Zwanenburg 1992: 171), mentre per la composizione dotta l'ordine ètendenzialmente inversa (ana-tomia è una specie di taglio)21.
Le voci composte nel Guglielmo vulgare sono quasi tutte “non dotte” e presentano la struttura[nome + preposizione + articolo + nome]: pesse de la gola 'cavità substernale', osso de la lauda'osso occipitale', capo de le mamele 'capezzolo', ...
Se vogliamo considerare tali strutture come voci composte, si pone il problema di distinguere frauna voce composta e una collocazione.
Per Faloppa (2010) “il termine collocazione indica la combinazione (tecnicamente co-occorrenza)di due o più parole, che tendono a presentarsi insieme (contigue o a distanza) più spesso di quanto sipotrebbe prevedere” o, secondo Jezek 200522, “una combinazione di parole soggetta a unarestrizione lessicale, per cui la scelta di una specifica parola (il collocato) per esprimere undeterminato significato, è condizionata da una seconda parola (la base) alla quale questo significatoè riferito”. La collocazione è quindi un dato di tipo statistico e i suoi elementi costitutivi possonoessere disgiunte, cosa impossibile per le composizioni.
2.4.1.2.2 lingue in contatto: prestiti
Accanto alle neoformazioni che si basano su materiale (morfemi lessicali) già presente in una certalingua, nuove voci possono anche essere costruite su morfemi lessicali provenienti da altre lingue.Quando una forma straniera viene integralmente riprodotta in un'altra lingua, si parla di prestitointegrale o forestierismo (Fanfani 2010a). Esempi di forestierismi nel Guglielmo vulgare sono ilatinismi dura e pia mater, grecismi come colon e splen e l'arabismo sifac23. Fanfani (2011) fanotare che questo tipo di prestito “non necessita che di una minima conoscenza preliminare dellastruttura e della semantica del termine alloglotto, nascendo da una attività imitativa o riproduttivasemplice e immediata”.Quando il prestito è stato “adattato alle strutture fonomorfologiche e alla grafia della lingua” siparla di prestito adattato (Fanfani 2010a). Nel volgarizzamento della Cirurgia ritroviamo fra l'altroi prestiti adattati chisto (< lat. cysti(m) < gr. kust jι ), longano (< lat. longaon/longabo).
19 'ripetutamente' è sola una delle interpretazioni possibili di ana- (cf. nothomia)20 “Originariamente”, perché nell'italiano attuale possono presentarsi anche legati in una forma grafica unica, come in
capostazione (Iacobini 2010b). Un tale tipo di composizioni non occorre tuttavia nel Guglielmo vulgare.21 Eccezion fatta per alcune parole composte come filologia, filantropia, ...22 Citato in Faloppa 201023 Si tenga presente che i grecismi e l'arabismo in questione sono già presenti nella fonte latina.
13

2.4.2.2 Aspetti semantici
2.4.2.2.1 Neologia semantica intralinguistica
Un altro tipo di neologia è l'uso di un significante già presente nella lingua per esprimere nuovisignificati. Da un punto di vista sincronico, il mutamento semantico può avvenire attraverso lametafora, un principio di trasferimento di significato in base a una similitudine24 o la metonimia,basata su un rapporto di contiguità25. Da un punto di vista diacronico sono possibili ladifferenziazione o la specializzazione semantica. Esempi di differenziazione nel nostro corpus sonopetenegio 'pube' e petene 'pettine', entrambe dallo stesso etimo latino pecten 'pettine1, pube2'. Unesempio di specializzazione è la voce negreza 'carattere nero' che denota nel Guglielmo vulgare la'pupilla'26.
2.4.2.2.2 lingue in contatto: calchi
Quando un significante in una data lingua acquisisce nuovi significati già presenti in un'altra lingua,si parla di un calco. Questi calchi si suddividono in calchi strutturali (o formali) e calchi semantici(Fanfani 2010b). Per esprimere il significato 'membrana', espresso in latino dalla voce tunica'indumento romano1, membrana2', si trovano nel Guglielmo vulgare il prestito tunica e il calcosemantico gonella. L'espressione petene della man 'metacarpo' può essere considerato un calcostrutturale dal latino pecten manus.
2.5 Percorsi etimologici
Nel tracciare il percorso etimologico delle voci prese in esame, partiamo dalla definizione diZamboni, che per etimologia intende “la scienza che studia l'origine delle parole o, in altri termini,la ricerca dei rapporti – formali e semantici – che legano una parola con un'altra unità che laprecede storicamente e da cui quella deriva” (Zamboni 1976: 1). In questa definizione, “origine” e“rapporto” vengono messi sullo stesso piano. Pfister, distinguendo fra la ricerca etimologicaromanza e quella indoeuropea, specifica che l'etimologo romanzo si occupa meno dell'origine(proto-)indoeuropeo quanto del rapporto fra la parola romanza e l'etimo latino, saltuariamente grecoo di un altra lingua di substrato. Criteri che vanno maggiormente considerati in questo approcciod'étymologie-rapport27 sono fattori semantici, geografici e socioculturali (Pfister 1980: 20-21). Questa molteplicità di fattori intra- e extralinguistici, portano Mecking ad affermare che “ogni unitàlessicale ha la sua propria storia”, e che pertanto converrebbe stabilire una étymologie-histoire dumot28 (Mecking 2014: 8). La nostra ricerca, in quanto presenta il percorso etimologico di una vocenon necessariamente ancora in uso, insieme al suo (eventuale) percorso di lessicalizzazione, seguequesto orientamento.
24 “Figura retorica che risulta da un processo psichico e linguistico attraverso cui, dopo aver mentalmente associato due realtà differenti sulla base di un particolare sentito come identico, si sostituisce la denominazione dell’una con quella dell’altra” (Treccani 2014)
25 “Figura retorica che risulta da un processo psichico e linguistico attraverso cui, dopo avere mentalmente associato due realtà differenti ma discendenti o contigue logicamente o fisicamente, si sostituisce la denominazione dell’una a quella dell’altra” (Treccani 2014).
26 Questo significato specializzato è tuttora presente nei dialetti delle zone alpine del Piemonte e della Lombardia e neidialetti del Trentino e del Friuli-Venezia Giulia (ALI 1995: 20).
27 Contrapposta all'étymologie-origine (Pfister 1980: 21).28 “Il nous semble pertinent de rappeler la notion d'étymologie-histoire du mot, concept de l'école wartburgienne se
substituant à celui, résolument trop réducteur, d'étymologie-origine. En effet, chaque unité lexicale – ou mot tout court – a une histoire strictement individuelle et unique que se développe en relation avec le réseau ou système dans lequel elle évolue, en fonction de paramètres intra- et extralinguistiques” (Mecking 2014: 8).
14

2.5.1 La paretimologia
I rapporti formali e semantici spesso si possono descrivere come i risultati dei procedimenti dimutamento semantico e formale descritti sopra (§2.4.2 La lessicogenesi). In altri casi, l'evoluzione(tendenzialmente) prevedibile di una voce viene interrotta, a causa di una “rimotivazione del segnolinguistico” (Neumotivierung in Pfister 1980: 101). Pfister spiega questo fenomeno come unasoluzione al bisogno del locutore di dare un (nuovo) senso a voci che esprimono un significato chenon viene più inteso29. La rimotivazione avviene attraverso assonanze, derivazioni arbitrarie einterpretazioni associative. Il termine italiano per questo fenomeno è paretimologia (a partire daPisani 1967). Si preferisce la denominazione paretimologia a etimologia popolare (ted.Volksetymologie, fr. étymologie populaire), perché l'ultima suggerisce che il fenomeno si produceprevalentemente presso le classi popolari, mentre esso è altrettanto presente nel discorso di parlanti(e scriventi) più competenti di una lingua30. Un problema che emerge nell'analisi di voci soggette aduna rimotivazione paretimologica, è che non sempre si può ricostruire con certezza l'associazioneche è stata fatta. Esemplare è l'espressione pesse de la gola (< pyxis gulae) per cui un rapporto conpesce sarebbe – da un punto di vista grafico e fonetico – ipotizzabile, mentre per quanto riguarda illegame semantico non possiamo che limitarci a congetture31.
2.5.1.1 La rianalisi morfologica
Un caso particolare della paretimologia riguarda le voci opache il cui significato non vienenecessariamente alterato, bensì la struttura morfologica. Sgroi 2011 distingue diversi tipi dirianalisi. Citiamo i fenomeni più importanti per lo sviluppo del lessico32:
(1) spostamento di confine di morfema (la radio > l'aradio)(2) agglutinazione dell'articolo (l'astrica > la lastrica)(3) pseudo-deglutinazione (il lusignolo, l'usignolo)(4) risegmentazione con aferesi (subitana 'di sotto'> fovea *subtana 'buco sotterraneo' > tana
'covo')(5) retroformazione del singolare muovendo dal plurale (sg. microbio > pl. microbi > sg.
microbo)(6) Formazione del singolare a partire da un altro singolare (sg. cisti > sg. ciste)(7) Rimorfologizzazione del genere (gr. dialektoj (f.), lat. dialectus (f.), it. dialetto (m.))
29 “Will man die in der Volksetymolgie wirksame Tendenz positiv sehen, so ist es ein Bemühen um Verständlichmachung, Motivierung der Bezeichnung, Neumotivierung einer nicht mehr verstandenen Bezeichnung.”(Pfister 1980: 101).
30 Pfister (1980: 101) elenca un serie di alternative e le loro rispettive origini in area germanofona (Sekundäre Motivation, lautlich-begriffliche Wortassimilation, geistige Etymologie, metaphysische Etymologie, Paretymologie, evolutive Etymologie, synchronische Etymologie) e francofona.(étymologie seconde, attraction homonymique, attraction paronymique, étymologie statique, étymologie associative).
31 Zamboni (1976: 47) estende la natura non di rado “congetturale” della paretimologia all'etimologia nel suo insieme. Questa problematica, in combinazione con delle prove frammentarie, mette in bilico lo statuto di “scienza” dell'etimologia. Tuttavia, argomenta Zamboni, “l'elemento casuale ed intuitivo che certamente entra nel concetto nonè che un momento di sintesi che deve necessariamente appoggiarsi a una critica rigorosa e completa di tutti i dati, interni ed esterni,” rivendicando con queste parole l'impostazione scientifica dell'etimologia.
32 Gli esempi – a titolo illustrativo – sono stati ripresi da Sgroi 2011.
15

In diacronia, si distingue fra la caduta di uno (o più)33 suoni – aferesi, sincope o apocope a secondadella posizione del suono caduto (rispettivamente all'inizio, in mezzo e alla fine della parola) – el'aggiunta di uno (o più) suoni: protesi, epentesi o epitesi. Precisiamo che questi termini si applicanoin prima istanza alla forma grafica della parola, considerata come unità autonoma. Nel parlato, larianalisi morfologica non è sempre visibile (p.e. fra la notomia e l'anatomia non c'è differenzaudibile). La rianalisi avvenuta si manifesta, quando cadono le restrizioni d'uso di una data forma(p.e. l'occorrenza della forma con aferesi notomia senza articolo che la precede). In tali casiparleremo della lessicalizzazione della forma.
2.5.2 La trasmissione di testi manoscritti: rimotivazione a partire dalla cacografia
Un problema ricorrente per i copisti di manoscritti, è la scarsa leggibilità del testo-fonte. Nellaricostruzione di una forma, può succedere che il copista l'interpreti in una maniera non conforme alsignificato originario, rimotivando in tal modo il segno linguistico. Anche nella Cirurgia troviamoevidenza di questo fenomeno:
Lat. rarificatio volg. ratification accanto a rarificationLat. flectura [digitum pedis] volg. figura [de li didi del pé]
I casi citati sono contestualmente situate, ma vi sono anche casi in cui la nuova espressione silessicalizza. Nel terzo capitolo svolgeremo un'analisi dei percorsi di lessicalizzazione delle vociosso de la lauda e ossi vernal.
2.5.3 Ipercorrettismi
Per Fresu 2010 “l’ipercorrettismo (meno spesso ipercorrezione) consiste nella sostituzione di unaforma linguistica che sarebbe esatta, ma che viene erroneamente ritenuta scorretta per somiglianzacon una forma effettivamente sbagliata”. Delle definizioni simili si ritrovano in vari altri dizionarisincronici34. Trattando dei testi che datano dal tardo medioevo-primo rinascimento, vorremmotuttavia adottare una definizione più larga del concetto. Invece di focalizzare sulla dicotomiasbagliato/corretto, ci sembra più opportuno considerare come alcune caratteristiche particolari delmodello linguistico prescelto vengono estrapolate e applicate al di fuori del campo di applicazioneoriginario. La lingua cancelleresca, sviluppatasi nel '400-'500, sullo sfondo di un crescente bisogno diuniformazione dovuto all'invenzione della stampa, costituisce una tappa significativa per lastandardizzazione della lingua. Dal momento che acquisisce più importanza la lingua scritta rispettoalla produzione orale (Palermo 2010), emerge una specie di ''ipercorrettismo grafico''. Il modellosoggiacente alla produzione scritta nelle cancellerie era la grafia latina, che si sostituiva allescriptae regionali, che riflessero maggiormente le caratteristiche fonetiche di un posto (Palermo201035). Le particolarità grafiche del latino, quali i grafemi <y> e <h>36 vennero reintrodotte, peresempio in tyranno (lat. tyrannus) o thesauro (lat. thesaurus). Importa notare che – in latino –
33 Può cadere anche un morfema intero, come illustra l'esempio subitana > tana.34 Dizionario del Corriere della sera, Dizionario di Sapere.it, Hoepli 2014, ...35 “Sul piano grafico il latino svolse l’importante funzione di fornire un diasistema che consentiva, in una lingua
veicolata prevalentemente attraverso la scrittura, di conguagliare per l’occhio, non per l’orecchio, le diverse realizzazioni fonetiche locali.”
36 Nei nessi consonantici <ph> e <th>
16

questi grafemi occorrono quasi esclusivamente in prestiti provenienti dal greco: y < u, ph < f, th <q. Quando si fa la sostituzione grafica, senza che la restrizione suddetta venga rispettata – siaperché l'etimo greco è diverso, sia perché l'etimo greco presenta una <t> e non una <q> (p.e.ymagine < lat. imago, gr. ei)doj o anathomia < lat. anatomia, gr. a)natomia) – parleremo diipercorrettismo.
2.6 Percorsi di stabilizzazione lessicale
Secondo i procedimenti descritti sopra, ogni parlante/scrivente può creare nuove formeidiosincratiche nella sua produzione individuale (o performance in termini chomskiani). In questostudio vorremmo fare una riflessione sulle caratteristiche delle voci che vengono accolte da unacomunità di parlanti più estesa e quelle che invece non vengono riprese.
2.6.1 Significati usuali e occasionali
Un primo fattore da prendere in considerazione è il significato della forma in un dato contesto. Inquesto rispetto è significativa la distinzione fra “significato usuale” (Usuelle Bedeutung) e“significato occasionale” (Okkasionelle Bedeutung), introdotta da Hermann Paul (1880, cit. in Alan2013: 560). Il significato usuale è il significato così com'è stabilito in una comunità di parlanti. E'questo il senso che viene descritto nei dizionari. Il significato occasionale è il significato che unaforma acquisisce nel contesto di un enunciato37 specifico e contestualizzato. Pertanto, il significatooccasionale è il risultato dell'interferenza tra fattori contestuali e il significato usuale (Alan 2013:560). Vice versa, l'occorrenza frequente di un significato occasionale può corroborare allastabilizzazione del significato quanto significato usuale, e quindi alla sua lessicalizzazione.
2.6.2 La nozione di 'diagrammaticità'
La nozione di diagrammaticità è dovuta a C.S. Peirce. Il suo modello semiotico suddivide i segni inicone, indici e simboli. Nella categoria delle icone, segni basati sul principio dell'imitazione, eglidistingue ulteriormente fra immagini – imitazione fra segni della stessa “sostanza” – , diagrammi –imitazione strutturale – e metafore – imitazione fra segni che condividono una proprietà semantica(Apothéloz & Boyé 2004: 2). La diagrammaticità di un'espressione linguistica è quindi la misura in cui vi è una corrispondenzastrutturale fra il significante e il significato. La nozione è applicabile nell'ambito della derivazione edella composizione. La voce melancolico ('affetto dalla bile nera', da melan 'nero' e colè 'bile') peresempio ha un grado di diagrammaticità più elevato rispetto all'attuale malinconico, in cui leformanti etimologiche non sono più direttamente riconoscibili. Nel Guglielmo vulgare troviamo una“forma di mezzo” fra questi estremi; melanconico, in cui la prima formante è rimasta inalterata.E' la nostra ipotesi che le voci con un alto grado di diagrammaticità si possano trasmettere tantoquanto quelle con una diagrammaticità più bassa, ma che ci sia una distribuzione diversa fra ildiscorso specializzato, dove la diagrammaticità è preferita e risponde al bisogno scientifico dellaclassificazione, e il discorso comune, che non richiede un grado di diagrammaticità elevata. IlGuglielmo vulgare, quale volgarizzamento (discorso comune) di un sapere scientifico (discorsospecializzato) presenta espressioni di ambedue i lati del spettro.
37 In Alan (2013: 560) “utterance” , ma il concetto rimane valido anche per la lingua scritta.
17

2.6.3 Fattori geolinguistici
Il lessico del Guglielmo vulgare presenta non poche caratteristiche della koinè settentrionale, comelo scempiamento delle doppie (budelo gobo), la lenizione intervocalica (stomego) e la pronuncia[ts/dz] per [tʃ/ʤ], resa con il grafema <z> (zenochio). Le tendenze di standardizzazione della lingua, e quindi anche della grafia, avvenute conl'invenzione della stampa, hanno favorito il modello linguistico fiorentino, e buona parte dellevarianti settentrionali sono stati rifiutati dai dizionari della lingua italiana. In alcuni progettilessicografici attuali, come il TLIO, le varianti regionali vengono rivalorizzate. Tuttavia il motore diricerca funziona in questo momento ancora soltanto con la variante toscana.
3. Metodo
3.1 Costituzione del corpus
Il corpus comprende una serie di termini selezionati da un volgarizzamento cinquecentesco di untrattato anatomico scritto in latino. In questa parte espliciteremo i criteri di selezione delvolgarizzamento, del testo originario e dei termini stessi.
3.1.1 Selezione del testo
L'analisi riguarda una selezione di (antiche) voci scientifiche. Il vantaggio che offre unvolgarizzamento è la cooccorrenza di voci dotte ed espressioni popolari in uno stesso testo. DellaCirurgia di Guglielmo da Saliceto disponiamo inoltre di una versione latina e accanto alla versionevernacolare. Ciò rende possibile un confronto fra le voci.
3.1.1.1 Trascrizione di una versione vernacolare
Il corpus di questo studio è il quarto libro del Guglielmo vulgare in Cirugia, e viene anche indicato con il nome di Anatomia. Il documento che abbiamo trascritto è disponibile in formato scanerizzato nella banca dati Gallica (www.gallica.bnf.fr) della Bibliothèque Nationale de France. Il catalogo collegato prevede le seguenti informazioni:
Tipo testo a stampa, monografia
Autore Guillaume de Saliceto (1210?-1280?)
Titolo Gulielmo vulgare in Cirurgia [Microforma]
Edizione Riproduzione dell'edizione di: [Milano]: [Johanne Angelo Scizenzeler], [1504] ([ca 150] p.)
Pubblicazione Cambridge (Mass.): Omnisys, [ca 1990]
Descrizione materiale 1 microfilm ; 35 mm
Collezione Italian books before 1601 ; 508.7
Segnatura FRBNF 37265122
18

3.1.1.1.1 Convenzioni di trascrizione
In questa leggenda si chiarificano i segni diacritici ricorrenti nella trascrizione.
corsivo e sottolineato Abbreviazioni sciolte< > Testo difficilmente leggibile; testo ricostruito<a/b> Testo difficilmente leggibile; diverse letture possibili<XXX> Testo non leggibile[ ] Nota[...] Parte mancante
3.1.1.1.2 Procedimento e problemi pratici
Il documento sopracitato ha fornito il testo di base. A causa della qualità non sempre ottima dellacopia, alcune parti sono difficilmente leggibili. In tali casi, abbiamo cercato di ricostruire il testomediante un confronto con l'edizione bresciana di 1486, anch'essa reperibile su Gallica (segnaturaFRBNF 37243925).Siccome lo scopo della collazione era quello di ricostruire l'edizione milanese, le differenzeortografiche fra le due versioni non sono state prese in considerazione. Nei luoghi in cui vi è unadifferenza semantica notevole (expulsiva/explusiva, concavitade/continuitade), una nota a pié dipagina è stata aggiunta. Vista la quantità piuttosto elevata di parti illeggibili in questo secondodocumento (a causa di macchie d'inchiostro sul lato verso delle pagine), un confronto sistematiconon è stato possibile.
La trascrizione che presentiamo è un compromesso fra l'aspirazione ad una riproduzione il piùfedele possibile e il bisogno di un testo leggibile. Per migliorare la leggibilità del testo, abbiamoaggiunto una punteggiatura secondo le regole dell'italiano moderno. Nei casi in cui i segni diacritici(punti finali e lettere maiuscole) erano già presenti nel testo, essi sono stati preservati, anche inposizioni '”abnorme” secondo l'uso attuale.
La separazione delle parole era un'altra questione spinosa. Il testo stesso non è sistematico nell'usodegli spazi bianchi. Tuttavia abbiamo ritenuto necessario seguire fedelmente l'incunabolo – anchenelle sue inconsistenze – , perché la separazione ''sbagliata'' delle parola (da un punto di vistaetimologico), può tradire una rianalisi morfologica, che è una tappa essenziale nella formazioneparetimologica38.
Una difficoltà interpretativa a cui siamo stati confrontati durante la trascrizione era la similitudinegrafica fra <s> e <f>. Nella maggior parte dei casi, il contesto fornisce abbastanza indizi dapermettere un'interpretazione sensata. Problematica invece era l'alternativa fra si o fi + participiopassato, caso in cui abbiamo optato sistematicamente per il costrutto fi + participio passato, permettere in rilievo il legame con il latino fieri, che può esprimere un valore futuro (Rohlfs 1969: 129-130).Per l'alternativa <s/f>, così come per alcune altre combinazioni problematiche, proponiamoambedue le letture nei casi in cui il contesto non permette una scelta motivata.
38 cf. §4.1 la notomia
19

3.1.1.2 Il Guglielmo vulgare come traduzione: uno sguardo al testo latino
Così come esistono diversi versioni vernacolari della Cirurgia più o meno interdipendenti, anche latradizione latina conosce delle varianti. Un'edizione critica del testo finora non è ancora stata fatta.Il testo latino di cui ci serviamo come corpus parallelo è la versione fornita come testo parallelonell'edizione dell'Anatomia medio-inglese, a cura di Heimerl (2008).Quella versione latina è basata sul testo latino stabilito da Schaarschmidt (1919), che aveva eseguitoun confronto di un manoscritto e due incunaboli39. Heimerl osserva alcune lacune nel lavoro diSchaarschmidt e ci informa che egli stesso ha modificato il testo fornito dallo studioso tedesco, alfine di facilitare un confronto con il testo inglese40. In attesa di un'edizione scientifica del testo latino, un confronto con questa versione latina rimanetuttavia utile, nella misura in cui vi possiamo ricavare il significato delle espressioni “tradotte”. Daun punto di vista formale, alcune particolarità grafiche, visibili nel testo latino (come <y> indyafragma) ci aiutano a ricostruire la pronuncia e quindi l'evoluzione fonetica di alcuni suoni.Anche se la versione di Heimerl/Schaarschmidt – ricostruita e talvolta inconsistente –indubbiamente non è stata quella che i copisti, traduttori e editori avevano sotto gli occhi, essarimane una fonte preziosa.
3.1.2 Selezione dei termini
Le espressioni vernacolari che analizzeremo sono state selezionate in base ad una “divergenza”formale e/o semantica dalla voce corrispondente nella versione latina.
Chiamiamo divergenze formali quegli sviluppi che non seguono l'evoluzione fonetica tendenziale (equindi prevedibile) dell'italiano standard, di stampo fiorentino. Le divergenze possono esseredovute ad una rianalisi morfologica (1), ad un'evoluzione fonetica o una derivazione a carattereregionale (2), all'uso di un etimo diverso (3) o ad una combinazione di questi fattori (4).
I cambiamenti semantici sono specializzazione o generalizzazione. Questi sono dovute ad usimetaforiche o metonimiche. Nei casi dell'origine paretimologica di una voce, forma e senso sonoalterate, portando ad una rimotivazione del segno linguistico (Pfister 1980: 101).
39 MS 1177, Universitätsbibliothek Leipzig, ff.242r-249v
Summa conservationis et curationis. Chirurgia. Venezia, 1490Ars Chirurgia. Venezia, 1546(Heimerl 2008: lix)
40 “Unfortunately, Schaarschmidt does not give the variants of all texts in every instance, nor folio references, which isthus necessarily also the case for my emendations. The Latin text of the parallel-text edition has been modified with Schaarschmidt's notes so as to be as closa as possible to the Middle English version in order to present the reader with a text for comparison.” (Heimerl 2008: lix)
20

Nel quadro sottostante si categorizzano le espressioni selezionate.
Guglielmovulgare in
CirugiaCirurgia latina
Divergenzaformale osemantica
Origine delladivergenza
Voce acarattereregionale
la notomia anatomia formale rianalisi morfologica
didimo didimus semantica specializzazione semantica
gombedo cubitus formale e semantica formazione paretimologica
X
malmenchion virga formale etimo diverso + affissione
X
merisfagus
canna del stomego
meri vel ysophagus
canna stomachi
formale
semantica
contrazione di due termini
generalizzazione per via di metafora (risp. a canna 'fusto')
ri-specializzazione
morene hemorroides velhemorroidae
formale e semantica formazioneparetimologica
ossi vernaliosso de la lauda
ossa verrualiaos alauda/ os a landae
formale e semantica formazione paretimologica
pesse de la gola pixis gulae formale e semantica formazione paretimologica
X
petenegio femur formale etimo diverso X
scaio ascella formale etimo diverso
strangosare sincope formale etimo diverso X
zotischare claudicare formale sviluppo fonetico settentrionale + rianalisi dell'infisso
X
21

3.2 Tra etimologia e traduzione
3.2.1 Il Guglielmo vulgare come punto di partenza
Nello svolgimento delle indagini etimologiche, il punto di partenza era la nostra trascrizione delGuglielmo vulgare. Tramite il contesto immediato dell'espressione si cercava di capirne ilsignificato. Anche il testo latino, e in qualche caso le versioni francese41 e medio-inglese42 servivanoa questo scopo.
3.2.2 Dizionari etimologici e dialettali
Il passo successivo era la ricostruzione etimologica. Giacché la maggioranza delle voci nonvengono considerate come appartenente alla lingua italiana standard, soltanto poche espressionisono state descritte nei dizionari etimologici, quali il Dizionario Etimologico della Lingua Italiana(DELI; Cortelazzo & Zolli 1978-88) e il Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana (Pianigiani1907).
La conoscenza della voce corrispondente latina (etimo o non), facilitava una ricerca progressiva; dallatino alle varietà italoromanze. Dizionari che sono stati utili per questo tipo di indagini sono ilLessico Etimologico Italiano (LEI; Pfister & Schweickard 1979-) e il FranzösischesEtymologisches Wörterbuch (FEW; Von Wartburg et al. 1922 -). Il LEI offre una documentazione molto dettagliata, con un'ampia descrizione semantica el'inclusione di un buon numero di varianti locali. Lo svantaggio di questo dizionario è il fatto che sitratta di un progetto lessicografico in corso, attualmente arrivata alla lettera C e che pertanto unagran parte del lavoro rimane da fare.Il FEW torna utile per conoscere lo sviluppo di un certo etimo latino in francese. In tal modo unpossibile sviluppo italiano potrebbe farsi intuire. Spesso vi è menzionato anche la forma italianastandard. Il vocabolario di Wartburg risulta però meno adatto quando si cercano varianti italianelocali.
Una quantità delle voci selezionate sono varianti settentrionali, di cui talvolta possiamo trovaretracce nei dialetti. Perciò abbiamo dato uno sguardo anche ai dizionari dialettali del milanese(Cherubini 1838), bresciano (Melchiori 1817), bolognese (Berti 1874), modenese (Neri 1973),ferrarese (Ferri 1889), veneziano (Boerio 1867), triestino (Pinguentini 1969) e friulano (Pirona et al.19922). Facciamo notare che i dizionari dialettali datano dall'800 o dal '900, e che pertanto nonpossiamo essere sicuri che quelle voci sono ancora in uso (cf. §3.3 Percorsi di lessicalizzazione).
3.2.3 Altre fonti
Voci o varianti molto specifiche (come le varianti petenegio o nothomia) non sono statedocumentate in nessun dizionario che abbiamo consultato. In questi casi abbiamo inseritol'espressione nel motore di ricerca Google, in cerca di documenti che contenessero il termine e cipotessero illuminare sul loro uso. Consideriamo questi documenti provvisoriamente come primeattestazioni, in attesa di uno spoglio più sistematico.
41 La Cyrurgie (16 novembre 1492), Lyon: Mathias Huss; tradotta da Nicole Prévost. Ringraziamo Ildiko Van Tricht per la realizzazione della trascrizione della versione francese.
42 Heimerl 2008
22

3.3 Percorsi di lessicalizzazione
Stabilire quanto successo ha riscontrato una voce è un'impresa difficile. Un primo problema è ilfatto che relativamente pochi manoscritti e incunaboli sono stati digitalizzati.Il criterio più obbiettivo che possiamo adottare è quello di vedere se una voce è stata inclusa neidizionari e in quale tipo di vocabolario. Abbiamo consultato vari dizionari sincronici, che ricopronodiversi periodi. Per il periodo attuale abbiamo ritenuto il dizionari di De Mauro (2002), Devoto-Oli(2009) e Hoepli (2014, consultabile in rete). Quest'ultimo ha il vantaggio di accogliere un maggiornumero di voci, compreso delle espressioni cadute in disuso. L'Atlante Linguistico Italiano (ALI;Massobrio e.a. 1995) fornisce delle informazioni sulla distribuzione delle voci meno tecniche neidialetti. Per il periodo fra il '500 e l'800, abbiamo consultato quattro edizioni successive del Vocabolariodella Crusca: 16121, 16232, 16913, 1729-17384. Dal momento che la Crusca tiene una posizionefiorentina-purista nella scelta dei vocaboli che include, i dizionari dialettali (citati in §3.2.2)fungono da contrappeso.
Faccendo un confronto fra la frequenza di varianti, un'applicazione interessante è Google NGramViewer. Questo programma, a partire da uno o più termini di ricerca, costruisce un grafico con ilnumero di occorrenze in un periodo determinato. Da 2012 esiste anche un corpus italianoconsultabile. Un aspetto problematico è che il corpus si limita ai libri digitalizzati in Google Books.Così troviamo tramite il motore generico alcuni documenti contenenti la voce nothomia, mentre laricerca non dà nessun risultato in NGram Viewer. Per l'obbiettivo specifico delle nostre indagini,sarebbe stato altrettanto interessante poter disporre di un corpus di testi latini, da confrontare con ilcorpus di testi italiani (per esempio anotomia in italiano vs anotomia in latino). Purtroppo non èancora sviluppato un corpus latino in NGram Viewer, e anche un confronto fra i vari corpora rimaneun progetto da realizzare. Nonostante questi limiti, i risultati ottenuti per le variantinotomia/anatomia dimostrano una chiara evoluzione, confermando la tendenza che si individua neidizionari. Ne concludiamo che Google NGram Viewer è uno strumento ancora in pieno sviluppo con unampio margine di interpretazione, i cui risultati vanno confrontati con risultati ottenutidiversamente, in modo più controllato e controllabile.
3.4 Prospettive di ricerca: sondaggi e rilievi orali
Una visione d'insieme del percorso di lessicalizzazione di una parola finisce idealmente nelpresente. Voci standardizzate si ritrovano facilmente nei dizionari della lingua italiana. Rintracciarevestigia dialettali tramite una ricerca lessicografica è meno evidente, visto che gran parte deidizionari dialettali risale all'800. Potrebbe essere interessante affrontare la questione medianteun'indagine sul campo, con sondaggi e rilievi orali.
Durante una giornata di studio a Milano nell'estate di 2014 abbiamo svolto un'attività preparatoriaad una tale ricerca. Con un registratore audio abbiamo documentato 10 interviste in cui si chiedevaagli informatori:
(1) A quale zona linguistica apparteneva (L'indicazione “zona” è deliberatamente vaga.L'informatore può rispondere con il nome di un quartiere, un comune, una città, una regioneamministrativa o una regione definita altrimenti).
(2) Se capiva e/o parlava un dialetto e quale dialetto.(3) Se conosceva o intuiva il senso di una lista di parole (che erano le voci analizzate in questa
tesi).
23

I dati qualitativi ottenuti in questo modo, possono fornire indicazioni per ricerche più mirate. Cosìla voce strangosare 'mandare di traverso' venne riconosciuta sistematicamente dagli informatori chedicevano di sapere il milanese. Il numero di interviste è certo troppo ridotto per trarne delleconclusioni. Con il resoconto di questa esperienza si auspica di aver fornito un punto di partenza perindagini future.
24

4. Analisi
4.1 Nothomia/notomia
Nothomia nell' Anatomia
a. Capitulo.i. dela nothomia e figura del capo e de la gola (1,9)
Cap. primum de anathomia et figura capitis, gulae et colli (2,1)
b. Capitulo II dela nothomia e figura del humero e del aiutorio e del brazo o schaio (9,15)
Capitulum secundum de anathomia et figura humeri, adjutorii, brachii, manus et digitorum (20, 9-10)
c. Capitulo iii dela notomia e figura dela forcola e dele coste e del torace dela spina (12,29)
Capitulum tertium. De anathomia et figura furculae, costarum, thoracis et spinae (38, 1-2)
d. Capitulo iiii dela nothomia e figura del ventre de fuora, dela boca del stomeco infin ale anche e
ali spondili de questa parte. (14, 31-32)
Capitulum quartum. De anathomia et figura ventris exterioris ab ore stomachi usque ad ancas et spondylibus
huius partis. (44, 1-3)
e. Capitolo quinto de la nothomia e figura de l'ancha, del dedo grosso dela gamba, del pé e deli
dedi e de le membre permagnando in questi. (18, 14-15)
V. De anathomia anchae, pedis, cruris, digitorum et membrorum circa ea. (54, 16-17)
f. Avegna che'l sia promesso determinare de la nothomia, intention non so numerare tuti li membri
particular. (1, 11-12)
Quamvis permissum sit determinare de anatomia, inentio non fuit enumerare membra omnia particulariter
(2, 4-5)
g. Conciò sia che sia posibile la nothomia, over l'ultima division deli membri. (1, 26-27)
Cum sit possibili per anathomiam seu ultimam membrorum divisionem (2,19)
25

h. Adonca è meio e più utele e a mi pare che'l sia processo in la nothomia, si come io promisi, cioe
in comun metando el nervo e la forma over figura, el sito over location deli membri, le qual cose
posano esser manifesti ali sentimenti aciò che tu possi proceder cum incision, scotadure e operation
manual senza error. (1,32-2,1)
Ergo propter hoc melius et utilius videtur mihi, ut procedam in anatomia, sicut promisi in communi, scilicet
ponendo numerum et formam, vel figuram, vel situm loci, complexionem membrorum, quae possunt esse
sensibus manifesta, et in eis cum incisionibus, cauteriis et manualibus operationibus absque errore procedere
possis. (2, 21-25)
i. Primo de la notomia del cerebro del cavo e de li membri siando cerca quello (2,6)
Primo ab anathomia cerebri, capitis, et membrorum existentium circum ea et in eis (4, 4-5)
La voce not(h)omia viene usata per tradurre il latino anat(h)omia. L'oscillazione fra la variante conepentesi della <h> e quella senza si manifesta sia nella versione latina che nel volgarizzamento.
Nothomia nei dizionari e in altri documenti volgari
Sotto il lemma anatomia, il TLIO (1994-) registra le forme notomia (1324-132843) e anotomia(1369-137344). La variante nothomia non è invece documentata nei dizionari che abbiamoconsultato.
Il primo testo italiano contenente questa variante che abbiamo ritrovato sono le AntiquarieProspettiche Romane (ca.1499-150045), un testo che tratta opere d'arte, soprattutto sculture,provenienti da collezioni private romane e i resti delle principali architetture romane (Scippacercola1995). L'autore del testo viene considerato di area lombarda. In effetti – oltre ai cenni al circuito artisticomilanese presenti nel testo stesso, su cui elabora Scippacercola (1995) – anche la linguadell'opuscolo è caratterizzata da alcuni tratti settentrionali. Così lo scempiamento delle doppie(ymaginosse), l'uso della preposizione de invece di di e il pronome possessivo maschile so.
La grafia del testo è latineggiante (pictore, sculptore, triumphante, thesoro, vitio, ...), rincorrendo innon pochi ipercorrettismi46: ymaginosse, ystoriate, sacrifitium, ...Se nell'etimo latino anatomia, la <h> è assente, l'epentesi di questo grafema nel testo lombardopotrebbe essere capito come un ulteriore caso di latino ipercorretto.
Et Anton polli fel proprio modelloper nothomia et ogni neruo et ossocomo facto lhauessi praxitello
43 Jacopo della Lana, Chiose alla Commedia di Dante. Paradiso, canto XXVI, 67-78, in. TLIO 1994, 'anatomia'44 Guglielmo Maramauro, Expositione sopra l'Inferno di Dante, cap.28, in TLIO 1994, 'anatomia'45 Datazione stabilita in base alle opere artistiche descritte nel trattato (Scippacercola 1995)46 Rispetto alla grafia del latino classico
26

Aspetti morfologici
Prendendo insieme le forme italiane e latine, si giunge a 8 varianti della voce anatomia. Questevarianti sono determinate da tre variabili: la presenza della prima vocale <a> (1), l'epentesi delgrafema <h> dopo <t> (2) e l'alternanza allofonica [a/o] della seconda vocale (3).
Non tutte le varianti sono attestate in ambedue le lingue e le prime attestazioni delle rispettive formedivergono quanto all'epoca e alla zona geografica. Nella figura sottostante si confrontano leattestazioni latine ed italiane, per vedere poi come s'inserisce il nostro volgarizzamento dellaCirurgia in questo quadro.
Non per tutte le forme che si esaminano i dizionari documentano una prima attestazione. Perciòabbiamo voluto includere anche alcune attestazioni che abbiamo ritrovato tramite l'uso di varimotori di ricerca47. Un caso particolare è l'Anothomia di Mondino de' Liuzzi, trattato medico inlatino, il cui titolo cambia a seconda dell'edizione. I titoli presenti in questo quadro sono stati ripresitali da WorldCat.
Latino Italiano
anatomia V secolo: Caelius Aurelianus, Liber Celerumet Acutarum Passionum, I,8 (Lewis&Short1874)48
1484: Mondino de' Liuzzi, Anatomia corporishumani. (Padova: Matteo Cerdone, prima edizione astampa)
I dizionari italiani non segnalano la primaattestazione.
anathomia 1493: Mondino de' Liuzzi: Anathomia(Lipsia: Martin Landsberg)
1513: Mondino de' Liuzzi: De omnibus humani corporis interioribus membris anathomia(Strasburgo: Martin Flach)
variante non riscontrata
anotomia variante non riscontrata 1369-1373: Guglielmo Maramauro,Expositione sopra l'Inferno di Dante, cap.28(TLIO 1994-)
anothomia 1316: Mondino de' Liuzzi, Anothomia:(manoscritto, edito da Giorgi 1992)
variante non riscontrata
natomia variante non riscontrata variante non riscontrata
nathomia variante non riscontrata variante non riscontrata
notomia variante non riscontrata 1324-1328: Jacopo della Lana, Chiose allaCommedia di Dante. Paradiso, canto XXVI,67-78 (TLIO 1994-)
nothomia 1491: Deputati dell'Ospedale Maggiore diMilano, Pro nothomia
ca.1499-150049: autore lombardo, AntiquarieProspettiche Romane
47 Motori di ricerca generici come Google, come anche delle banca dati più specifici come Gallica e WordCat.48 Lo stesso dizionario cita anche Macr. S. 7, 15, ovvero le Saturnalia di Macrobio (V secolo), libro VII, cap.15. La
voce anatomia tuttavia non è presente nel testo citato, bensì l'aggettivo derivato anatomica (7, 15) e il sostantivo anatomicorum (7,13) (controllo effettuato sull'edizione di Von Jan 1852)
49 Datazione stabilita in base alle opere artistiche descritte nel trattato (Scippacercola 1995)
27

L'alternanza [a/o]
Da questo quadro emerge che l'alternanza allofonica [a/o] è presente in ambedue le lingue a partiredal '300.
Le 4 edizioni del Vocabolario della Crusca ci forniscono alcune informazioni quanto alla forma piùgeneralizzata. Nella prima edizione (1612), la voce anatomia viene spiegata con una definizionepropria:
“Proprio quel minuto tagliamento, che si fa delle membra de' corpi umani da' medici, perveder la compositura interna di essi corpi: e quegli, che esercita cotale arte, e detto Notomista.Qui per simil. Lat. anatomia, dissectio. Gr. ἀνατομὴ. ”
La variante anotomia non compare nella prima edizione. La base con [o] è tuttavia presente nelsostantivo derivato notomista.
Nella seconda edizione (1623) è la forma anatomia che è assente. La definizione sopracitata vieneletteralmente ripresa per il lemma anotomia. Colpisce il fatto che il riferimento etimologico vienepresentato, senza che l'alternanza vocalica fra la voce italiana e l'etimo greco-latino vengaesplicitata.
Nella terza (1691) e la quarta edizione (1729-1738) entrambe le varianti sono state incluse. Laforma anotomia viene dotata di un'entrata completa, vale a dire la definizione sopracitata, ilriferimento etimologico e alcuni esempi. La variante anatomia viene definita come “lo stesso cheanotomia”. Vengono forniti tuttavia anche degli esempi per anatomia.
Prima edizione Seconda edizione Terza edizione Quarta edizione
Anatomia definizione propria / rimando a anotomia rimando a anotomia
Anotomia / definizione propria definizione propria definizione propria
Ne possiamo dedurre che durante il '600 – '700 entrambe le varianti erano in uso, ma che la formaanotomia era quella preferita, almeno per quanto riguarda la sensibilità degli accademici dellaCrusca.
L'aferesi della <a> inizialeLe successive edizioni ci informano non solo sull'alternanza [a/o], ma anche sull'aferesi della <a>iniziale, dovuta ad una rianalisi morfologica dell'articolo. Anche se sono previste delle entrate peranatomia e anotomia, gli accademici aggiungono sistematicamente il commento “più comunementenotomia50”.
Per quanto riguarda il sostantivo derivato che indica la persona che esegue l'anatomia, il quadro èpiù complesso. Nella prima edizione tale persona è detta notomista. Questa indicazione è fornitasotto il lemma anatomia. Nella seconda edizione lo stesso nome è dato sotto il lemma anotomia.Nella terza e la quarta edizione notomista diventa un'entrata autonoma. Nella terza edizione però,sotto il lemma di anotomia si afferma che “ quegli, che esercita cotale arte, é detto Anotomísta”. Laterza edizione dimostra in tale modo l'esitazione fra il sostantivo derivato aferetico (in un'entrata asé stante) e quello non aferetico (sotto anotomia).
50 Per quanto riguarda le varianti aferetiche, è attestata solo la variante con [o].
28

Nella quarta edizione questa ambiguità è stata soppressa, mantenendo l'entrata autonoma pernotomista e eliminando il riferimento alla persona nella definizione di anotomia.
La distribuzione fra notomia e anatomia descritta sopra, in cui notomia era la forma privilegiata,cambia nel corso del '700. L'evoluzione è chiaramente visibile sulla grafica generata dal NGram-viewer di Google books. Laddove nella prima metà del Settecento il numero di libri che contengonola voce notomia è superiore, all'inizio del novecento il numero di tali documenti è irrilevanterispetto ai libri che contengono la parola anatomia.
Prima del Settecento, l'immagine è più confusa. La ragione principale è il numero (troppo) limitatodi libri digitalizzati per il periodo che va dal XVI al XVII secolo. Il grafico sembra tuttaviaconfermare la preferenza per notomia, che troviamo nel Vocabolario della Crusca.
Resta a vedere il percorso di lessicalizzazione delle derivazioni di notomia, cioè notomista enotomizzare. Nel dizionario sincronico Hoepli 2014, notomia e notomista sono incluse come vocinon più in uso. Dall'altro canto, vi troviamo la voce notomizzare 'analizzare minutamente' (Hoepli2014) come variante più frequente di anatomizzare. La preferenza per la forma aferetica o quellaintera dipende quindi dal vocabolo specifico e non è generalizzabile a tutta la serie lessicale.
Dal quadro delle attestazioni fornito sopra si evince che, laddove in italiano l'aferesi della <a> èfrequente prima del '500, in latino questo fenomeno pare quasi assente. Tuttavia abbiamo ritrovatoun'attestazione di nothomia in un testo latino. Si tratta in un'ordinazione dei deputati dell'OspedaleMaggiore di Milano, intitolata Pro nothomia, datata 7 dicembre 1491 (Azzolini 2006: 162)51.Questo fenomeno illustra a nostro avviso l'influsso che la lingua volgare può esercitare sul latino.
51 Deliberaverunt quod de pauperibus moriendi in hospitale ad discretionem dictorum phixicorum [sic] fiat nothomia particularis et de ipse nothomia fiat disegnum perpetuo in prefato hospitale (cit. in Azzolini 2006: 162).
29

L'epentesi del grafema <h>
Prima del '500, l'epentesi della <h> dopo <t> è rara in italiano. In effetti non è stata documentatafino agli ultimi decenni del '400. A partire dal '500, questo tratto appare in un maggior numero ditesti: il Guglielmo vulgare in Cirugia (1504), l'Opera del clarissimo poeta Francesco Petrarca conel commento de misser Bernardo Lycinio sopra li triumphi (1515)52 e il Libro de manuscansia deMaestro Augustino Columbre (1518)53 sono solo alcuni esempi di stampe in cui il grafema <t> eseguito da una <h>. La quasi totalità dei documenti di cui disponiamo in cui appare la formaepentetica è di area settentrionale. Nelle lettere dei segretari di Cosimo I de' Medici almaggiordomo ducale Pier Francesco Riccio (1543-1544), vi è un'oscillazione fra notomia enothomia54. Anche se nel Vocabolario della Crusca, la variante con una <h> epentetica non vieneconsiderata, l'uso di entrambe le varianti si prolungherà fino all'800.
Aspetti semantici
Nella sua storia, la voce anatomia con le sue varianti è stata dotata di diversi significati. Nelpresente lavoro mi limito ai significati dei formanti55 – di matrice greca –, alla prima attestazionelatina (Lewis & Short 1874) e allo sviluppo semantico della voce nella lingua italiana.
Il Pianigiani (1907) individua in anatomia il prefisso greco ana- e la formante -tomia, 'sezione,taglio'. In questa composizione il significato esatto di ana- non è chiaramente definito. In un'entrataautonoma Pianigiani enumera per ana- i significati 'a parti uguali', 'ripetizione', 'allontanamento' e'modo intensivo'. Combinando questi significati tali quali con il significato 'taglio' , non si riesce astabilire una definizione soddisfacente.Sarà quindi piuttosto il contesto a determinare di volta in volta il significato preciso della voceanatomia.
La prima attestazione della voce in latino si trova nel Liber Celerum et Acutarum Passionum diCaelio Aureliano (V secolo)56, tradotto da un trattato medico in greco di Sorano d'Efeso (II secolo).Cosciente del suo ruolo di traduttore, Caelio Aureliano stabilisce in modo esplicito un rapporto fra itermini che egli usa e i significanti greci provenienti dalla sua fonte, confrontando talvolta diversevarianti latine e greche57.
Nel primo libro, capitolo ottavo leggiamo:
Si quidem per apertionem, quam Graeci anatomiam, didiceratis sensuales vias inde sumereexordium.(Caelius Aurelianus, V secolo, ed. Colinaeum 1533)
52 p.CVI53 cap.2854 Ciranni 2009: 4-855 Mi servo della terminologia di Cottez 1980 56 Secondo Lewis&Short 1874, anatomia57 Dysert 2007 cita il passo dove Caelio Aureliano spiega l'etimologia dell'idrofobia, “iam Graeci timorem phobon
vocant, aquam hydor appellant” (Cael.Aur.Acut. IX: 9. cit. p.167), elencando poi altri termini che sono state usate per indicare quel morbo; hygrofobia, phobodipsos e cynolyssos (Dysert 2007: 167)
30

La voce anatomia entra quindi nel latino tramite una traduzione, facendo parte del binomio apertio'apertura'58 - anatomia, in cui apertio è il termine noto e anatomia quello nuovo. La preposizioneper comunica che l'apertio, ovvero l'anatomia, cioè 'l'atto di tagliare', precede la conoscenza (delle'vie sensuali da cui iniziare'). Ancora nell'Anothomia di Mondino de' Liuzzi (1316) l'anatomiadenota l''atto di tagliare'59.
In italiano lo stesso significato di anatomia si tramanda. Le successive edizioni del Vocabolariodella Crusca definiscono l'anatomia (1a edizione) o la variante anotomia (2a-4a edizione) come“Propriamente quel minuto tagliamento, che si fa delle membra degli animali da' medici, per vederla compositura interna de' loro corpi”. Sulla scia di questo senso si svilupparono tuttavia significati diversi: il TLIO (1994 - ) descrive ilsenso della variante (a)notomia come la “descrizione della struttura interna di un organismomediante dissezione.” Non più la dissezione stessa, bensì il risultato è messo in rilievo. Infatti, ilsecondo esempio fornito dal dizionario non corrisponde del tutto alla definizione, perché è soltantouna descrizione di un organismo, senza che si menzioni una dissezione preliminare:
Maramauro, Exp. Inf., 1369-73 (napol.>pad.-ven.), cap. 28, parr. 15-20, pag. 416.23: Tra legambe etc. menugia sono le intestine, e La corata e il tristo saco, idest lo ventre, il qual famerda di quel che è mal digesto. E questa è bona anotomia. (TLIO 1994 - anatomia)
Un ulteriore sviluppo del senso è la generalizzazione per la quale si ottiene il significato 'verifica,esperimento' (TLIO 1994). Un altro significato, non documentato nel TLIO, bensì in dizionari sincronici della lingua è la'conformazione, struttura del corpo' (Hoepli 2014)
Significato contestuale
La voce not(h)omia ricorre soprattutto nei titoli dei capitoli. In teoria, essa potrebbe denotare tanto'l'atto di tagliare' quanto 'la composizione' di un certo organo. Nel secondo caso vi è tuttavia unrapporto tautologico con la voce figura che segue.Nel testo stesso l'autore fornisce, con un binomio sinonimico, una definizione della voce: “lanothomia, ovvero l'ultima division deli membri” (es.g, 1, 26-27). A questa definizione, che è unapossibilità teorica, viene contrapposta una definizione più ristretta, ma anche più pratica dellanothomia. L'autore comincia con una concessione, in cui ammette di non aver l'intenzione di fare lanothomia in modo in cui uno lo potrebbe inizialmente intendere, cioè “numerare tuti li membriparticular”.
Avegna che'l sia promesso determinare de la nothomia, intention non so numerare tuti li membri particular.(1,11-12)
58 Lewis & Short 1874, apertio59 [et] quia cognitio partium subiecti in medicina, quod est corpus humanum, quae loca dispositionum appellatur, est
una pars scientiae medicinae, ut dicit Averroys primo sui Colliget, capitulo de diffinitione medicinae. Hinc est quod inter cetera vobis cognitionem partium corporis humani, quae ex anothomia insurgit, proposui tradere, non hic observans stilum altum, sed magis secundum manualem operationem vobis tradam notitiam. (Mondino de' Liuzzi, Anothomia, 1316, ed. Giorgi 1992)
In fatti nella medicina la conoscenza delle parti del soggetto, cioè il corpo umano, della loro denominazione e delle loro relazioni è parte della scienza medica stessa, come dice Averroè nel primo libro del suo Colliget nel capitolo sulla definizione della medicina. Questo è il motivo per cui mi sono proposto di tramandarvi, fra le altre cose, la conoscenza delle parti del corpo umano che deriva dall'anatomia, non osservando in ciò uno stile aulico, ma vi istruirò invece secondo il metodo manuale.(trad. Giorgi 1992)
31

Invece, egli sceglie di trattare tutte quelle parti del corpo che sono visibili a occhio nudo (“manifestiali sentimenti”).
Adonca è meio e più utele e a mi pare che'l sia processo in la nothomia, si come io promisi, cioe in comunmetando el nervo e la forma over figura, el sito over location deli membri, le qual cose posano esser manifesti alisentimenti aciò che tu possi proceder cum incision, scotadure e operation manual senza error. (1,32-2,1)
Questa seconda definizione riflette bene lo scopo didattico del testo, cioè quello di insegnare aglistudenti come procedere alle “operation manual”.
Sintesi
La voce not(h)omia conta 8 occorrenze nel Guglielmo vulgare, di cui 5 nei titoli, 3 nel testo. Il suosignificato 'atto di tagliare per vedere la composizione interna' può essere compreso in senso teorico– l'“ultima division”– o pratico – “in commun mettando […] le […] cose [che] possano essermanifesti ali sensi” – considerando l'esplicito intento pedagogico del testo.Da un punto di vista formale tre aspetti sono stati presi in esame: l'aferesi della <a> iniziale,l'epentesi di una <h> e l'alternanza [a/o] della prima vocale.L'aferesi della <a>, dovuta ad una rianalisi morfologica dell'articolo, è un fenomeno italiano. Inlatino succede raramente. In latino infatti manca l'articolo determinativo, in modo che la rianalisinon avviene. I casi in cui la forma aferetica occorre tuttavia, questo è dovuto all'influsso delvolgare.L'epentesi della <h> è un fenomeno ricorrente sia in latino che in italiano. Sembra che la varianteepentetica sia più frequente in area settentrionale, ma manca ancora una solida documentazione ditesti meridionali sull'anatomia per verificare questa ipotesi.Anche l'alternanza [a/o] è presente in latino come in italiano. Questa oscillazione tradisce lamancata conoscenza del formante greco ana-, che – etimologicamente – sta alla base della voce,che dal greco è entrata nel latino tramite la traduzione dell'opera di Sorano d'Efeso fatta da CaelioAurelio nel V secolo.Per alcuni secoli – almeno dal '500 fino al '700 – notomia è stata la forma privilegiata. Lo si evincedal trattamento delle varianti della voce nel Vocabolario della Crusca, e dal numero di libripubblicati con il vocabolo nel titolo. Da notomia sono derivati notomista 'colui che eseguel'anatomia' e notomizzare 'analizzare minutamente'. Nel corso del '700-'800, la variante più vicinoall'etimo anatomia ha preso il sopravvento. Notomia e notomista sono stati sostituiti da anatomia eanatomista. La voce notomizzare rimane tuttora una voce in uso ed è più frequente della varianteanatomizzare.
32

4.2 Bossolo, bussolo, pesse (de la gola)
Documentazione
a. Sapi che la gola se continua con la forcola del peto in loco e chiamase pesse dela gola, over
continuade60 (9, 10-11).
Scias etiam, quod gula contrahitur cum furcula pectoris in loco, qui appellatur pixis gualae seu concavitas
(26, 4-5)
b. Infin de quella sie una vacuitade, la qual se chiama bossolo de l'osso dela spalla. (9, 26-27)
In fine eius est quaedam vacuitas, quae appellatur pixis ossis spatulae (26, 21-22)
c. Dredo questi ossi sono li ligamenti insensibili, li quali ligano e continuano questi ossi ad insieme,
zoè in mezo del bossolo [...] (10, 7-8)
Post ista sunt ligamenta insensibilia, quae ligant et continuant ista ossa ad invicem, et est in medio pixidis
ligamentum, continens vertebrum cum pixide [...] (28, 12-13)
d. L'altro capo se continua con la simelitudine del peto, dove è el bussolo dela gola. Sotto li quali
ossi dela forcole e bossolo fi ordenadi vii ossi in lo peto [...] e dura la longeza de questi ossi, con
continuation del bossolo dela gola infin al figato soto le mamelle (12, 32 – 13,3)
Aliud vero caput continuatur summitati pectoris, ubi est pixis gulae. Sub quibus ossibus furculae et pixide
ordinentur septem ossa pectoris [...] et durat longitudine ossium cum continuatione a pixide gulae usque ad
parum sub mamillis. (38, 5-9)
e. [...] una grosseza manifesta, in la qual el bossolo de l'anca se continua (18, 20-21)
[...] habet grossitudinem manifestam, in qua est vacuitas, quae appellatur pixis anchae (54, 21-22)
f. E in mezo del <b>ossolo sie uno ligamento, el qual amezando fi ligado al vertebro o col bossolo
(18, 22-23)
Et in medio pixidis est quoddam ligamentum, quo mediante ligatur vertebrum cum piscide [sic] hac (56, 1-2)
g. Dredo lo bossolo fi ordenado l'osso dela cossa [...] del qual la extremitade desopra intra in lo
bossolo de l'ancha (18, 27-29)
Post pixidem ordinatur os coxae [...] cuius extremitas superior pixidem anchae ingreditur (56, 7-8)
60 concavitade nell'edizione bresciana del 1486
33

h. Ma l'altra estremità de soto intra in lo bossolo del mazor deli focili dela gamba. (18, 32)
Alia vero inferior extremitas pixidem maioris focilium cruris ingreditur (56, 8)
Aspetti morfologici
Entrambe le voci pesse e bussolo si sono sviluppate a partire dal latino pyxis 'scatola (di bosso)61'.Questa voce, attestata in latino classico62, è un prestito del greco πυξίς (Lewis & Short 1874). Lavariante usata da Giovenale è puxis, in cui la vocale [y] e palatalizzata. Nel latino medievale vi è una cooccorrenza delle continuazioni delle due varianti: rispettivamentepyxis/pixis e buxis. La grafia medievale di pixis riflette la pronuncia anteriore [i] del grafemaoriginario <y>, [y] in latino classico.
La variante buxis, con lenizione della consonante iniziale è attestata a partire dal IV secolo. VonWartburg (1922) fornisce la seguente citazione di Placitus Papyriensis, un medico di quel secolo:“pyxidem quam nos corrupte buxidem vocamus” (FEW, pyxis)63. Buxide(m) si continua nel franceseboiste, di cui troviamo una prima attestazione nel Saint Nicolas de Wace (1150) (TLFi, boîte).
Da buxis è derivato anche il diminutivo bussullus/bussula 'cofanetto'. La prima attestazione latina(1389 secondo il Du Cange 1883-1887) è tuttavia posteriore alle prime attestazioni in italiano, cherisalgono al XIII secolo (TLIO). In italiano, come in latino, sono presenti le varianti di genere sia maschile (bosolo, bossolo,bossulo, busolo, bussolo, bussulo, buxolo) che femminile (bossola, bucxula, buxola, buxula). Sonostati attestati anche il diminutivo in -ellu(m) – bosselo – e l'accrescitivo bossona. In italiano antico, la variazione del genere non produce differenze di significato, come invece sarà ilcaso nell'italiano contemporaneo (cf. Aspetti semantici).
La variante pixis (acc. pixide(m)) ha dato l'italiano pisside 'vaso o scatoletta di materiale prezioso'(Hoepli 2014). La forma pesse, presente nel Guglielmo vulgare, è un hapax.
Aspetti semantici
Tutti i significati dell'italiano bossolo e del latino pixis/bussullus/bussula che sono stati descritti nelTLIO (1994-) e in Lewis & Short (1874) rispettivamente, si rifanno ad un contenitore,originariamente in legno di bosso, ma quindi il senso si è generalizzato ad una scatola di altromateriale (Treccani 2014). Gli usi della voce documentati provengono dall'ambito domestico 'Vasetto in materiale pregiato,dotato di coperchio, destinato alla conservazione di oggetti preziosi (segnatamente unguenti ocosmetici)' o politico-civile 'contenitore usato per le votazioni con le pallotte (o le fave)'64. L'uso metaforico nell'ambito della medicina 'cavità che protegge e contiene un organo, unmeccanismo'65 è stato documentato per il francese66 (TLFi, boîte), ma non nei dizionari di latino67,né per pyxis/pixis, né per bussullus/bussula. Anche nella maggior parte dei dizionari – sincronici ediacronici – d'italiano68 manca un riferimento a questo settore. Un'accezione medica della voce è
61 Si noti il trasferimento metonimico di significato: dal materiale all'oggetto62 Cicerone, Pro Marco Caelio ; Svetonio, Nero ; Plinio il Vecchio, Naturalis Historia (Lewis & Short 1874, pyxis)63 Vol.9, p.665a64 Le definizioni provengono dal TLIO, bossolo65 Tradotto dal TLFi, boîte66 H. de Mondeville, 131467 Lewis & Short 1874, Gaffiot 1934, Georges & Georges 1918, Du Cange 1883-188768 Pianigiani 1907, Treccani 2014, Devoto-Oli 2009, DELI 1988
34

solo presente nel LEI (1972-: 542), in un significato ancora più specializzato: 'concavità dell'ossodelle anche'; significato che risale a Francesco Redi (XVII secolo).
Mentre nell'italiano antico non vi era una distinzione semantica fra le varianti bossolo e bossola,queste si sono differenziate nell'italiano moderno. Il maschile bossolo ha mantenuto il suosignificato generale di 'specie di contenitore'. La variante femminile bussola è usata con ilsignificato specializzato di 'strumento di orientamento' (Hoepli 2014).
Significato contestuale
Al posto della voce latina pyxis, il volgarizzamento presenta quasi sistematicamente bossolo,eccetto in un solo luogo: pesse de la gola 'cavità substernale'. La stessa situazione si presentanell'edizione a stampa bresciana (1486) e quella veneziana (1504). Stabilire con certezza lamotivazione di questa forma non è possibile. Qualche indizio, per quanto indiretto, suggerisce unlegame associativo con pesce. La voce piscis (qui sotto forma di piscidem) invece di pixis (pixidem)occorre già in alcuni luoghi del testo latino. Ciò potrebbe facilitare l'interpretazione 'pesce' da partedi un traduttore/copista inattento69. Un secondo elemento è che nel manoscritto Landiano della Cirurgia (XIV secolo), studiata daAltieri Biagi, le voci corrispondenti al latino pixis sono pesie, pesse, pisce e pisis (1970: 107), nonsolo per la cooccorrenza pixis gulae, ma per tutte le pixides che figurano nel testo. Allineandociall'ipotesi di Biagi, consideriamo la declinazione al maschile di queste forme70 come un ulterioreindizio di una confusione con piscis (1970: 108).
La domanda perché le tre edizioni sopracitate mantengano soltanto l'espressione pesse dela gola,traducendo tutte le altre occorrenze con bossolo, rimane una questione aperta.
Sintesi
Pesse e bossolo sono due varianti che risalgono all'etimo greco pucij 'scatola (di bosso)'. Questavoce è entrata nel lessico latino, dove si sono sviluppate le varianti pyxis, pixis, puxis e buxis.
Pyxis/Pixis si è mantenuta nella lingua latina postclassica, con una panoplia di significati più omeno specializzati. Una continuazione vernacolare è la voce italiana pisside 'vaso o scatoletta dimateriale prezioso'. Buxis (buxidem) ha dato il francese boiste 'cofano'. L'italiano antico presenta lecontinuazioni bussolo e bussola (insieme ad alcune varianti), costruite sul diminutivo dibuxus/bosso. Una differenziazione semantica fra bussolo e bussola, sinonimi nell'italiano antico, haportato rispettivamente ad una voce con il significato generale 'specie di contenitore' e una voce conil significato specializzato di ' strumento di orientamento'.
La Cirurgia latina usa la voce pixis per indicare una 'cavità che contiene e protegge un organo'. Inalcuni manoscritti è presente la corruzione piscis. Nei primi volgarizzamenti la voce viene tradottacon pisis, pesie, pesse o pisce. E' stata proposta una spiegazione paretimologica basata suun'associazione con la parola pesce. Le tre edizioni a stampa che abbiamo consultato rendono ilvocabolo quasi sistematicamente con bossolo. Soltanto l'espressione pixis gulae diventa pesse delagola. La motivazione di questa variazione non è chiara. Questo tratto comune suggerisce tuttaviaun'interdipendenza delle edizioni.
69 Si tenga presente che “il” testo latino, è quello proposto da Schaarschmidt (1919) e potrebbe essere stato diverso dal testo-fonte del traduttore/volgarizzatore.
70 “Lo pesse che è de soto la golla” , “questo pisce”, “in lo pisce de la spalla”, … (citati in Altieri Biagi 1970: 107)
35

4.3 Didimo
Documentazione
a. Ma del panicolo defora, quando el se destende secondo lo logo del petenegio e del didimo, sopra
li canali li quali vegnano al sifac, fi fato la borsa de fora deli testicoli (15, 32-33).
Ex paniculo vero exteriori, cum extenditur in loco femoris et didimos, vel super canales, quae veniunt ex syphac,
et fit bursa testiculorum. (46, 12-13).
Didimo figura una sola volta nel trattato per rendere il latino didimos 'funicolo spermatico'.
Aspetti semantici
La parola didimo ha un'origine greca: didumoj 'doppio, gemello' (Pape 1880: 616a). In testianatomici (p.es. di Oribasio, IV secolo), la voce si usava metaforicamente per indicare i 'testicoli' oil 'funicolo spermatico'. Con la traduzione delle opere di Oribasio, realizzata a Ravenna nel VI secolo (Mørland 1932), lavoce, con il suo significato specializzato, venne introdotta nella lingua latina (DEI 1956: 1292b),poi anche in francese (1314, Henri de Mondeville71) e in italiano (XIV secolo72).
Nel grafico si vede come nell''800 la voce didimo è più frequente rispetto a testicolo, fino alla finedel secolo, quando testicolo prende il sopravvento.
Verso la fine del XVIII secolo73, la parola acquisisce un altro significato specialistico nell'ambitodella botanica: 'vegetale costituito di due parti tondeggianti unite per un breve tratto' (Hoepli 2014).
71 Tobler-Lommatzsch (1915: 1913a), TLFi (2014)72 TLIO (1994-)73 1783 per il francese (a partire da Bulliard; TLFi 2014), per l'italiano a partire dal XIX secolo (DEI 1954: 1292b)
36

Questo significato è compreso nel numero di occorrenze della forma didimo in NGram-viewer, manon altera la visione d'insieme, perché il significato si aggiunge solo a partire dal '900, periodo incui la frequenza di didimo rimane comunque più bassa della frequenza di testicolo.
Aspetti formali
In testi italiani settentrionali e francesi sono state attestate le varianti nasalizzate dindimo (it.74) edindime (fr.75). La variante francese didyme (TLFi 2004) mantiene il grafema etimologico <y>. Ladesinenza -os nella versione latina è può essere una corruzione o un genitivo grecizzante. In questosecondo caso però, vi è un trasferimento di declinazione. L'etimo didimoj (-ou) appartieneoriginariamente alla seconda declinazione e non alla terza in -oj.
74 Ms. Landiano della Chirurgia (XIV secolo) (TLIO 1994-)75 Prévost 1492
37

4.4 Gombedo
Gombedo nell' Anatomia
La parola gombedo occorre 12 volte nell'Anatomia. Qui figura una selezione di contesti illustrativi:
a. Ma l'altra extremitade se continua alo aiutorio in lo gombedo con l'osso, el qual ha la figura
simile dela rotula con la quale se traze l'acqua. (10, 16-17)
Alia vero extremitas adiectorii contiguatur in cubito cum osse, quod habet figuram similem rotulae, cum qua
hauritur aqua. (28, 22-23)
b. E l'altro focile sie desoto e sie più longo e più grosso e mazore, qual va ala parte salvadega, cioè
del dido menuello, al gombedo e fi sopramesso con una eminentia che a ponta e con longeza alo
adiutorio e ala soa rottola e fa la figura del gombedo aguza quando se piega. (10, 20-22)
Et focile est longius et grossius et maius et tendit a parte sinistra scilicet a digito auriculari ad cubitum. Et
superponitur cum quadam eminentia rostrali et longitudine adiectorii et rotulae eius et facit figuram cubiti cum
flectitur acutam. (30, 2-4)
La voce traduce il latino cubitus 'gomito'.
Aspetti formali
La variante gombedo, con epentesi della <m>, occorre nei dialetti settentrionali. L'ALI (1995, carta43) registra la voce nei dialetti del Piemonte settentrionale, della Lombardia e del Venetooccidentale. I dizionari del milanese (Cherubini 1838: 246b) e del bresciano (Melchiori 18717: 301)registrano rispettivamente gombed e gombet 'gomito'. L'entrata è assente dal dizionario venezianodi Boerio (1867). Per gomito, il DELI (1988) stabilisce l'etimo cubitus, senza spiegare lo sviluppoformale della voce. Il Pianigiani (1907) parla di “corruzione”.
Interessante è l'entrata gomba nel dizionario triestino di Pinguentini: “Bugna, bozza, rilievo susuperficie liscia. Veneto antico gonbo 'gobbo'. Dal latino popolare gumbus” (1969: 159). La vocegomba è documentata da Du Cange (1883-1887) con il significato 'tumore' (tumor), insiemeall'aggettivo gumbus 'gibboso' (gibbosus).
Si potrebbe ipotizzare una formazione paretimologica della parola gombedo, sulla base di cubitus egombus.
38

4.5 Malmenchion
Malmenchion nell' Anatomia
a. [...] el membro del homo id est el malmenchion (15, 15-16)
[…] membrum virile sive virga (44, 20-21)
La voce malmenchion 'membro virile', occorre una volta nel volgarizzamento al postocorrispondente del latino virga. Altrove la parola latina è resa con la sua continuazione direttaverga.
Aspetti formali e semantici
Malmenchion è una voce vernacolare, composta dal prefisso dispregiativo mal-, la base minchia eil prefisso accrescitivo -one.
L'etimologia di minchia (o menchia) fa dibattito. Vi è consenso quasi generale76 sull'etimo latinomentula 'membro virile'. Dopo la caduta della [u] postonica, il nesso consonantico [tl] si continuain [kl], poi [kj] (Tagliavini 1934)77.
La motivazione semantica di mentula è meno chiara. Per Devoto78 è il diminutivo di mentum'sporgenza'. Tale proposta tuttavia fa emergere la questione perché il diminutivo sarebbe di generefemminile e non neutro come la voce-base. Kretschmer (1923), Spitzer (1927) e Kerény (1932)fanno risalire mentula a menta 'menta (pianta)'. L'argomento che portano gli studiosi per fondarel'ipotesi è che l'uso di metafore “del giardino” per indicare parti del corpo (Kretschmer 1923: 283) èfrequente nelle lingue vernacolari e a forteriori il loro uso come eufemismi per gli organi genitali(Spitzer 1927: 13879).Kerény considera la pianta non tanto come oggetto formalmente simile al membro, ma piuttostocome causa della gravidanza. La credenza nella potenza fertilizzante della pianta è molto presentenell'area balcanica (Kérény 1932: 186), ma anche in altre parti d'Europa80.Concentrandosi sugli esiti nelle lingue vernacolari (Kretschmer e Spitzer) o su elementi folcloristici(Kerény), gli studiosi citati tralasciano di fornire altre voci latine che hanno conosciuto unosviluppo simile e che avrebbero potuto corroborare la loro argomentazione. Per conto nostro,possiamo segnalare la voce virga (it. verga), il cui significato di base 'radice di una pianta' cominciaad indicare metaforicamente il 'membro virile' a partire dal VI secolo81.
76 Cortelazzo & Zolli segnalano un'opinione opposta, benché isolata: “Fa eccezione l'opinione isolata di Meier (Die Onomasiologie der Dummheit, 1972: 31-32), che include minchione in una ricca famiglia di dispregiativi, facenti capo al lat.parl. *minuus (da cui *minu-icolone)” (DELI 1988 : 757).
77 Esempi di questo sviluppo sono vetulus > vecchio, fistula > fischia, ...78 Avviamento alla etimologia italiana, 1966, cit. in DELI (1988 : 757)79 it. prezzemolo 'organo genitale femminile'
fr. flouquet de persil 'organo genitale dell'uomo'80 Kerény (1932: 187): “Bestätigt und ergänzt wird das Angeführte zunächst durch weitere, europäische Beispiele für
Schwängerung durch Blumenduft (französische Legende aus dem 13. Jahrhundert), Blumengenuss (dänisches Märchen) [und] Blüttentrank (wallachisches Märchen).”
81 Cassiodoro, De Anima, 9. (in Lewis & Short 1874)
39

Altieri Biagi sostiene che malmenchion è “con tutta probabilità una glossa entrata nel testo” (1970:92). Considerando il fatto che la voce fa parte di un binomio sinonimico nel volgarizzamento, chetraduce un binomio nel testo-fonte, pare difficile sostenere che la parola vi è entrata per mero caso.La variante minchia è d'altronde una voce usata anche in altri testi scientifici medievali82, e quindinon vi è ragione per considerare malmenchion una voce “fuori posto”.
82 Due opere documentate nel TLIO (1994-)Antidotarium Nicolai, XIII secolo (fiorentino)Mascalcia Mosé da Palermo, XIV secolo (toscano)
40

4.6 Merisfagus, meri, canna del stomego
Merisfagus nell' Anatomia
Sopra li spondili del collo dal ladi dela gola è logada la canna del stomego, la qual se chiama
merisfagus, per lo quale passa el cibo e la bevanda al stomego [...] e continuase verso la gola con la
canna del polmon, over trachea artaria, ch'è una medema cosa, la qual è componuda de lacerti e
cartilagine nervi che vengono dal sexto pare deli nervi dal cerebro e è rugosa e ha mezi circoleti
verso la parte de fora in la continuation con el meri over con la canna del stomego a planura e
basseza in la soprana parte de quella alo epligoto e covertura, azò che in l'hora del manzar el cibo
non entra in quella ne alcuna cosa che offenda se non aere overo alcuna cossa a modo de aere. (8,
14-22)
In parte anteriori super spondyles colli ex latere gulae est locata canna stomachi, quae meri vocatur vel
ysophagus, per quam transit cibus et potus ad stomachum. [...] Et continuatur versus gulam cum canna pulmonis
vel trachea arteria, quod idem est, quae est composita [ex] cartilagine et nervis venientibus a sexto pari nervorum
cerebri. Et est rugosa et habet semicirculos versus partem exteriorem. In contignatione cum meri vel canna
stomachi planicium habet et lenitatem, et in supremo eius habet epiglotum et coapertorium, ut hora comestionis
cibus eam non intret neque aliquid laedens nisi sit aer vel aliquid ad modum aeris. (22,17 – 24,4)
Nell'Anatomia, il concetto 'esofago' viene espresso con tre espressioni: canna del stomego, meri emerisfagus. Nella versione latina riscontriamo canna stomachi, meri e ysophagus.
Aspetti formali e semantici
Le diverse forme che esprimono lo stesso concetto ci ricordano l'intenzione pedagogica del testo,che è visibile non soltanto nel volgarizzamento ma anche già nella fonte. In una serie sinonimica iltesto latino introduce prima l'espressione popolare (canna stomachi), poi le denominazioni dotte(meri e ysophagus).
Ysophagos è d'origine greca. La voce è composta della formante verbale oiso- 'portare' (Hyrtl 1879:173) e la formante nominale -phagos 'cibo' (Cottez 1980: 318). Il grafema <y> invece di <oi>tradisce la pronuncia [i], commune per molti prestiti greci in latino (Heimerl 2008: 71). L'uso di<y> invece di <i>, secondo Heimerl, non è altro che un marchio della provenienza greca, mapotrebbe trattarsi anche di un ipercorrettismo.
Se il FEW classifica la parola meri comme una voce di origine sconosciuta (vol. 21, 317b), diversetestimonianze la fanno risalire all'arabo mari 'esofago' (Heimerl 2008: 71, Pellegrini 1965: 747,Garzoni 1626: 133, Hyrtl 1897: 172), derivato da maraa 'passare' e quindi una specie di 'luogo dipassaggio'.Per quanto riguarda le lingue vernacolari, la continuazione di meri è attestata per il francese (meri,mery; Godefroy 1902: 258a), l'italiano (meri; TLIO) e l'inglese (mery, Heimerl: 2008) e occorre
41

spesso in un binomio sinonimico con (una variante di) esofago83.
La voce merisfagus è il risultato di una contrazione delle due voci dotte. Non occorre neimanoscritti esaminati da Altieri Biagi (1970) e Coco & Di Stefano (2008), bensì in almeno treedizioni a stampa: Brescia (1486), Milano (1504) e Venezia (1504). La ricorrenza di una talevariante composta in tutte e tre le edizioni, dimostra la loro interdipendenza. La neoformazione eraoccasionale e non è stata ripresa in altre opere.
L'espressione popolare canna, denotava originariamente una 'pianta erbacea con fusto alto erubusto', tanto in italiano quanto in latino (canna) e in greco (kanna) (DELI 1988: 195). Persineddoche, anche il fusto solo venne indicato con quel significante (Marchi 1828: 152). Unfrequente uso metaforico ha fatto sì che il senso si sia poi generalizzato per indicare diversi tipi di'tubi'. Nel DELI troviamo i significati 'bastone' (XIV secolo), 'parte di un'arma a fuoco' (1532,Ariosto), 'tubo di un organo' (1519, Leonardo), e appunto 'esofago o trachea' (a partire dal 1300ca.).
Nella Cirurgia occorrono le espressioni canna del stomego e canna del polmon. Il significatogeneralizzata di canna, che può indicare sia 'l'esofago', sia 'la trachea', richiede l'aggiunta di undeterminante preposizionale per distinguere i due organi.
83 Tanto nei volgarizzamenti della Chirurgia, dove il binomio è prevedibile perché già presente nella fonte, quanto in altre opere mediche (citazioni di tre fonti diverse in Godefroy 1902: 258a).
42

4.7 Morene
Documentazione
a. E circondano el forame del dito culo v vene grande, ale quale el figado e la spienza cazano molto
sangue melanconico. Quando s'apreno queste vene, fano morene sopra questo budelo in l'hom e
verso el petenegio e in la femina verso la matrice, cioè sopra la boca dela matrice. (17, 18-21)
Et circumdant ipsum ani foramen quique venae magnae, ad quas hepar et splen multum sanguinem
melancholicum expellunt. Et cum aperiuntur istae venae, dicuntur hemorroidae vel hemorroides. (52, 8-10)
Aspetti morfologici e semantici
La voce morena figura una volta nella Chirurgia. In italiano, la forma morena è una variante dimurena, un 'pesce marino voracissimo, teleosteo dell'ordine degli Anguilliformi' (Hoepli 2014). Una trasformazione paretimologica da hemorroides a morene è tuttavia un caso isolato nell'italianostandard e nelle varietà settentrionali indagate. Non avviene neanche nel francese o nello spagnolo –le rispettive voci muraine e morena vi vengono usate soltanto per denotare un tipo di pesce – manella lingua catalana una simile neoformazione è attesta: morena per 'pesce' e 'emorroide' (DLC1994: 1312).
Le formanti etimologiche di hemorroides 'parti del corpo caratterizzate dal sangue che scorre' sonohemo- 'sangue', -rheo- 'scorrere' e -oide 'caratterizzato da' (Cottez 1980: 182, 366, 198).
Assumendo morena 'pesce' come termine associato a hemorroides 'emorroidi', la forma latina allaquale risale la voce rimotivata è muraena (< gr. muraina, secondo Pianigiani 1907). E tuttavia possibile anche un legame associativo con moro 'colore oscuro', che si dice moreno inspagnolo. L'etimo latino di questa parola è maurus84 'abitante della Mauritania' (FEW, vol. VII,546). Quel senso si è generalizzato ad un 'abitante arabo o islamizzato dell'Africa del Nord o dellaSpagna musulmana' (ibid.). Per metonimia, l'aggettivo moro si è applicato a qualsiasi cosa di 'colorescuro' (FEW). Per la forma suffissale morena 'di colore scuro', il Diccionario Crítico Etimológicodella Lengua Castellana (DCEL; Corominas 1954) propone due possibilità: il suffisso preromano-enus, la cui apparizione sorprenderebbe tuttavia a causa della sua combinazione con una base latina(DCEL 1954: 444), o il diminutivo -īnus in *maurinus, la quale forma però non è stata documenta.
84 morus, -i, f., dal greco mwra 'mora' (Lewis & Short 1879)
43

4.8 Osso de la lauda e ossi vernali
Le espressioni osso de la lauda 'osso occipitale' e ossi vernali 'ossi parietali', benché siano vocidistinte, presentano una problematica etimologica simile. Per questa ragione le trattiamo in un'unicasezione.
Documentazione
a. Continuase etiamdio con doi ossi grandi li quali se chiaman vernal a modo de sega e fase una
figura continuada a modo de una crose, de la quale la linea desopra sie remota da questi doi ossi
vernali se continua in mezo del capo a modo de una sega intrinseca. E continuase questi doi ossi
vernali a modo de una sega con l'osso de la lauda. (4, 4-7)
Continuantur etiam cum quibusdam ossibus magnis, quae verrualia vocantur ad modum serae et fit ibi figura
continuationum ad modum crozole seu cruris, cuius linea superior sit remota. Ista duo ossa verrualia continuantur
in medio capitis admodum serae inter se cum ossae alaudae. (9, 17-20)
b. Poi se mette questo osso basilare a l'osso dela lauda e metase e fermase dentro quelo e la
mandibula disopra. (4, 8-9)
Applicatur tunc hoc os ossi a landae et ponitur et firmatur inter ipsum et mandibulam superiorem. (10, 2-3)
c. Fi chiamadi ossi mondosi, li quali se continua con li ossi vernali. Sono [solo] per sotometer l'una
parte a l'altra (4, 12-13)
Et vocatur ossa mendosa, quae non continuantur cum ossibus verrualibus et magnis, nisi per per suppositionem
partis ad partem. (10,6-7)
Nella versione volgare, le voci ricorrenti sono gli ossi vernal(i) e l'osso de la lauda85. Nella versionelatina troviamo sistematicamente ossa verrualia, ma un'alternanza fra os a landa(e) e os alaudae.
Aspetti grafici e semantici
La voce ossa alaudae 'osso occipitale' è discussa in Heimerl (2008: 66). Secondo l'editore del testomedio-inglese della Cirurgia, la neoformazione è dovuta ad un “errore nel tradurre o nel copiare”l'espressione galenica os lambdae 'osso a forma di una lettera lambda, osso occipitale'. Nel lexiconmedicum graeci-latinorum di Bartholomaei Castelli, l'osso occipitale è indicato con ladenominazione lambdoides (Altieri Biagi 1970: 90), il che sostiene la proposta di Heimerl.
La variante os lauda sarebbe già stata attestata negli scritti di Hrabano Mauro († 856) e diCostantino l'Africano (ca. 1015-1087) (Heimerl 2008: 66). L'occorrenza relativamente diffusa di oslaudae86, insieme alle sue continuazioni nelle lingue vernacolari (it: osso de la lauda) è un indizio
85 Facendo astrazione dell'articolo più o meno contratto, che non consideriamo come varianti vere e proprie (cf. §3.1.1.2.2 Problemi pratici)
86 Non solo nell'opera di Saliceto, ma anche in quella di Chauliac (Bitterling 2002: 202).
44

della rimotivazione avvenuta dal significato etimologico 'lambda' al significato secondario 'lode'.
Per quanto riguarda la variante os alaudae, con protesi della <a>, Bitterling la considera come unaformazione paretimologica, basata sull'associazione fra lauda e alauda 'allodola' . Questa secondavariante occorre nella traduzione francese della Cirurgia (Nicole Prévost, ca.1492: “l'os appeléalauda”) e nell'opera di Lanfranco da Milano (Bitterling 2002: 220).
Anche l'espressione ossi vernali sarebbe dovuta ad una rimotivazione dell'originaria ossa verrualia.Per l'etimologia di questa voce, troviamo in Heimerl (2008: 68) l'etimo latino veru 'spiedo'. Ladenominazione ossa verrualia 'ossa parietali' sarebbe dovuta alla loro contiguità con la suturasagittale (lat. sutura verruculata), un'articolazione di tessuto connettivo fra le ossa parietali (cf.figura)87.
La variante vernacolare ossi vernali è presente in più di una versione della Cirurgia88 e anche nellatraduzione francese di Prévost (“les grans os vernaulx”). Altieri Biagi segnala l'espressione ossanervalia, voce riscontrata nell'opera di Lanfranco, che “[rispetto agli ossi vernali nella Cirurgia]occupa lo stesso ''posto'' dopo l'osso pasilare e prima di ossa mendosa” (1970: 136).
Due indizi portano quindi all'ipotesi che la formazione paretimologica ossa verrualia > ossavernalia sia avvenuta in latino: l'occorrenza della voce in diverse lingue vernacolari ed una suppostametatesi partendo da ossa vernalia. Tuttavia tale espressione (*ossa vernalia) finora non è ancorastata attestata. Un'edizione critica del testo latino, che potrebbe gettar luce sulla questione, sarebbeauspicabile.
87 Per la definizione di sutura sagittale: Wikipedia (2014), Sagittal suture88 Altieri Biagi (1970: 136) cita un manoscritto e un libro stampato in cui ha riscontrato la voce:
Firenze, Biblioteca Riccardiana, 2171 (1471)La ciroxia vulgarmente fatta (1491) Venezia: Nicolò Ferrari
45
Figura 1: Sutura sagittale

4.9 Petenegio, petencio, petenechio
Documentazione:
Petenegio nell' Anatomia
a. Driedo le coste in la parte denanci sie la pele de fora, che copre el stomego e li budeli, e
continuase con la malitia infin a l'osso del petencio. E <s/f>ase questo loco tuto mole in fina a quela
parte e fi chiamada questa pele defora ventre. (14,34-15,2)
Post costas in parte anteriori ex parte extrinsica est pellis, cooperiens stomachum et intestina, et continuatur cum
mollicie usque ad os femoris, et fit hic locus totus mollis usque ad partem illam. Et vocatur haec pellis exterior
venter. (44, 4-7)
b. Advien el descendere del cibo ala borsa deli testicoli e fi fato alcuna fiada solamente eminentia.
Lo petenegio per lo descendere al desoto e in quela fiada sanno li medesi che la rotura del sifac non
è molto grande, la qual fi curada de lezier con impiastro e con riposso e con lo zitarse sopra la spina
con lo corpo in suso. (15, 7-11)
Accidit descensus zyrbi et intestinorum ad bursam testiculorum; et fit aliquando eminentia in femore propter
descensum ad inferius; et tunc sciunt medici, quod ruptura syphac non est multum magna, quae curatur de facili
cum emplastris et quiete et iacitura super spinam, corpore supino. (44, 10-14)
c. Soto questo sifac se mete l'osso del petenegio fato a modo de mezo circolo. Se non che in la parte
de sotto ha una eminentia e fi ligado con le anche in lo inguinaio, aciò che elo faza distantia, aciò
che'l sostegna queli loci da ligamento over ligamenti, sotto lo quale e in lo quale molto ample sono
artarie e vene. (15, 9-14)
Sub isto syphac ponitur os femoris, quod os factum est quasi ad modum semicirculi nisi quia in superiori parte
versus umbilicum habet quandam eminentiam et ligatur in inquinibus cum anchis, ut distantiam faciat, ut loca
illa substentet duritie sua. A ligamento vel ligamentis, ex quo corpus nervorum exoritur simile ligamento, sub
quo et in quo multae amplae arteriae existunt (44, 15-19)
d. Ma del panicolo defora, quando el se destende secondo lo logo del petenegio e del didimo, sopra
li canali li quali vegnano al sifac, fi fato la borsa de fora deli testicoli. (15, 32-33)
Ex panniculo vero exteriori, cum extenditur in loco femoris et didimos, vel super canales, quae veniunt ex
syphac, et fit bursa exterior testiculorum. (44, 12-13)
46

e. Quando s'apreno queste vene, fano morene sopra questo budelo in l'hom e verso el petenegio e in
la femina verso la matrice, cioè sopra la boca dela matrice. Verso el petenegio è logada la vesiga, la
qual vesiga sie vaselo de l'orina e sie nervosa. (17, 19-22)
Et cum aperiuntur istae venae, dicuntur hemorroidae vel hemorroides. Super illum intestinum in vero versus
femur et in muliere versus matricem locata est vesica, quae vesica est vas urinae et est nervosa. (52, 9-12)
f. E passa el suo colo sotto l'osso del petenegio e sotiliasse in l'osso de quelo a le part<e> de fora e
fase la via de quella a modo de una vena granda in l'homo e entra in la compositione de la verga per
mezo. E per quella parte esce l'orina. (17, 23-26)
[...] et transit collum eius sub osse femoris et subtiliatur in exitu eius ad exteriora. Et fit via eius in modum
magnae venae in viro et intrat compositionem virgae et transit usqua ad carnem virgae, [sub virga quasi], et
carnem virgae perforat per mediam et per illam partem transit urina seu exit (52, 14-18).
I vocaboli petenegio (6 occorrenze) e petencio (1 occorrenza) occorrono quando il volgarizzamentoitaliano traduce la voce latina femur 'coscia'.
Petenegio nei dizionari e in altri documenti
La forma petencio è un hapax. La voce Petenegio invece è stata descritta da Giovanni Pappafava(17962: 233) nel Vocabolario veneziano e padovano co'i termini e modi corrispondenti toscanicome “pettignone, pube, quella parte del corpo ch'è tra la pancia, e le vergogne. Anguinaia.”89
La definizione di petenegio di Giuseppe Boerio – qui sotto forma di petenechio – si allinea in partecon quella definizione, ma vengono aggiunte alcune informazioni ulteriori: “Pettignone, pube, minchiabbo. Quella parte pelosa del corpo umano tra il bellico e le partivergognose. Anguinaia o inguine, si dicono le parti laterali del pube tra la coscia e 'l ventre” (Boerio1876: 499c).
È notevole il fatto che l'entrata sembra contenere due definizioni; quella di petenechio e quella dianguinaia/inguine, senza che il legame fra le due sia reso esplicito. Non è chiaro se l'inguine debbaessere considerato come una parte del petenechio o se invece ne vada distinto. Oltre ai due sinonimi segnalati da Pappafava, Boerio aggiunge un terzo equivalente, minchiabbo.Dalle due entrate emerge poi che il petenegio costituisce una 'zona di transizione' fra la 'pancia'(Pappafava) e gli organi genitali. Il Boerio precisa che l'ombelico demarca la separazione fra lapancia e il petenegio e che questa parte del corpo è pelosa.
Oltre a queste testimonianze venete, la voce petengio appare in un documento di origine emiliano: ilLibro di Segreti (XV secolo)90. Nell'introduzione alla trascrizione del documento, Baraldi (2008: 1)segnala il termine come una voce “tipica della zona Ferrara-Modena e quindi propriamenteestense”. Il vocabolo tuttavia non è documentato nei dizionari del ferrarese (Ferri 1889) o delmodenese (Neri 1973)91.
89 La definizione (quella...vergogne) corrisponde testualmente a la definizione fornita dal Vocabolario della Crusca (1619) per il lemma 'pettignone'
90 Biblioteca Estense Universitaria, Modena Ms. Campori 74 = Campori Appendice 159 = gamma.S.6.3 91 Né nel diazionario bolognese (Berti 1874), che abbiamo controllato per completezza, dal momento che questo
47

Anche nel Libro di Segreti, petenegio significa 'inguine' (secondo Trenti 2008, in Baraldi 2008: 1).Nel testo stesso torna la qualità 'pelosa' dell'inguine a cui riferisce anche il Boerio:
Se tu volli che la cagna no(n) faza se no(n) cagnoli masculi tolli [sorgo destro] deli pelli del petenegio del homo e ligali ali colioni de lo cano che la toca e fa che no(n) la tochi se no(n) quello e no(n) fara se no cagnoli masgi. (Baraldi 2008: 35)
Aspetti morfologici
Nei dizionari consultati, un legame formale fra petenegio e un'eventuale forma latina preesistentenon è stabilita. Il dizionario di Du Cange (1883-1887) prevede un'entrata per pectenegium 'pube',indicandola tuttavia come una derivazione dall'italiano (“ab italico”) petteneggio92. Stando ai pochitesti in cui questa forma 'italiana' viene riscontrata, petenegio pare invece essere piuttosto un esitolocale – nordorientale –, costruito sul latino pecten 'pube' (ma anche 'pettine', cf. infra). L'origine delsuffisso -eggio è incerta. Per Rohlfs (1969: 385), il morfema è presente nei sostantivi derivati daverbi in -eggiare93. Ciò nonostante non abbiamo trovato evidenza di un verbo *peteneggiare. Sipotrebbe trattare di una formazione per analogia con tali sostantivi deverbiali (come corteggio inRohlfs 1969). L'equivalente che – al contrario di petenegio – è accolto nella maggior parte dei dizionari dellalingua italiana è pettignone. E' una continuazione del diminutivo di pecten; i.e. *pectinione(m)94. IlMelchiori (1817: 112) documenta per il dialetto bresciano la voce petenèt 'pettignone'. Questa voceè anch'essa un diminutivo, ma costruito sull'affisso italiano -etto (Rohlfs 1969: 452-453).
In una visione d'insieme delle continuazioni formali di pecten e delle sue derivazioni, occorrenotare che nell'Anatomia ritroviamo anche la voce petene, che designa il 'metacarpo'. Il percorsosemantico di questa voce verrà elaborato nel paragrafo Aspetti semantici.
Aspetti semantici
Lewis&Short (1874) registrano la voce latina pecten con il suo significato di base 'pettine'95, masegnalano anche altri significati: il senso di 'pube', ritrovato in Celso96 e il senso di 'crini intorni alleparti pudende', che è attestato in Plinio97. Il ricorso a queste metafore – in rapporto metonimico fra di loro – non si verifica soltanto nel latino.Anche in greco antico la voce kteis può significare sia 'pettine' che 'pube' o 'pelo pubico'98.
Se però nelle lingue classiche i significati coincidono in un medesimo significante, nelle lingueromanze assistiamo ad una diversificazione formale. In francese, pecten nel senso di 'pettine' sicontinua in peigne. Per denotare il 'pube', è preferito il diminutivo *pectiniculum, che dà l'esitoformale pénil99. Anche in italiano, il significato 'pube' viene espresso non da pettine, ma tramiteforme derivate da pecten (pettignone < *pectinionem) o dall'italiano pettine (petenegio).
vocabolario è più elaborato rispetto ai dizionari dialettali locali sopracitati.92 Du Cange, 'pectenegium'93 Nei verbi l'infisso -eggi-, dal greco -iz-, lat. -idi-, esprime l'aspetto iterativo (cf. §4.12 zotischare).94 Garzanti linguistica online, 'pettignone'95 Lewis&Short (1874), 'pecten'96 De Medicina, VIII, 1 (cfr. Lewis&Short 'pecten')97 Naturalis Historia, XXIX, 26 (cfr. Lewis&Short 'pecten')98 Liddel&Scott, 'kteis'99 FEW, '*pectiniculum': VIII, 108a
48

Man mano che il sapere scientifico si sviluppa, pecten si presta ancora una volta come un elementodi paragone. Così Constantinus Africanus sceglie la forma pecten per designare un nuovo concetto:il 'metacarpo'100, cioè “lo scheletro della regione della mano, intesa con esclusione delle dita”101 o ilmetatarso, la struttura corrispondente nel piede. Questo nuovo significato è più specializzatorispetto al greco, dove kteis può denotare anche il dito.Anche in questo caso la motivazione dei nuovi significati risiede in una metafora, in quanto lastruttura ossea del metacarpo assomiglia a un 'pettine'. Il traduttore della Cirurgia ricorre al terminepetene due volte per indicare il metacarpo e una volta per il metatarso. L'uso della voce italianapettine per questi significati è documentato a partire dal XIV secolo102.
Tirando le somme, possiamo affermare che nelle lingue classiche, le voci che indicano un 'pettine'(kteis e pecten rispettivamente), possono denotare – per ragionamento metaforico – diversi concetti:'le dita' (a), il 'pube' (b) e il 'pelo pubico' (c). Nello sviluppo del latino, assistiamo ad unadiversificazione formale, per cui la diretta continuazione di pecten (petene) denota – oltre alsignificato di base 'pettine' – i sensi specializzati 'metacarpo' e 'metatarso'. Le forme derivate petenegio, petenechio (forme locali) e pettignone esprimono il senso 'pube'. Ilsignificato di 'pelo pubico' è scomparso, anche se in vari documenti (il Libro di Segreti e ildizionario del Boerio), la presenza di peli è vista come una caratteristica inerente – e forseindissociabile del pube.
Significato contestuale
La voce petenegio nel volgarizzamento della Cirurgia traduce il latino femur; voce che secondo ildizionario di latino classico di Lewis&Short (1874) denota la 'coscia' e non il 'pube'103. Nellaversione latina di Guglielmo da Saliceto tuttavia, i rapporti reciproci tra anca, coxa e femur siconfigurano diversamente rispetto al latino classico.
Walter Von Wartburg e Stephen Ullmann descrivono lo slittamento semantico di coxa 'anca' versocoxa 'coscia' e il prestito del germanico hanka per denominare l''anca' come un'evoluzione“necessaria” per evitare l'omonimia di femus 'sterco' e femur 'coscia' (Von Wartburg-Ullman 1963:127). Comparando le denominazioni dell'anca e della coscia nelle lingue romanze, pervengono alloschema seguente104:
'anca' 'coscia'
latino classico coxa femur
italiano anca coscia
francese hanche cuysse
spagnolo anca muslo
portoghese anca coxa(adattato da Von Wartburg-Ullmann 1963: 127)
100Du Cange (1883-1887), 'pecten(3)'101Dizionario di Medicina (2010), 'metacarpo'102TLIO, 'petene'103Lewis&Short, 'Femur'104Tralasciamo lo sviluppo delle denominazioni della 'gamba' per motivi di economia e di chiarezza.
49

Nella versione latina dell'Anatomia, vediamo che l'evoluzione semantica descritta da Wartburg eUllmann si è realizzata: ritroviamo le voci (h)anca 'anca' e coxa 'coscia', tradotte rispettivamentecon 'anca' e 'cossa'.
a. Lat: Capitulum quartum. De anathomia et figura ventris exterioris ab ore stomachi usque ad ancas et spondylibus huius partis.It: Capitulo iiii dela nothomia e figura del ventre de fuora, dela boca del stomeco infin ale anche e ali spondilide questa parte.
b. Lat: [quae appellatur pixis anchae.] Ibi contignatur vel intrat rotunda ossis coxae, quae appellatur vertebrum.It: in la qual el bossolo de l'anca se continua, over entra la extremitade redonda de l'osso dela cossa, la qual se chiama vertebro.
La voce femur e tuttavia presente, non più nel suo significato originario – ormai espresso da coxa –ma con il nuovo significato 'pube'. Pertanto, laddove nel testo latino occorre la voce femur, ilritroviamo sistematicamente petenegio (o petencio) nella traduzione italiana.
a. Lat: [...] et continuatur cum mollicie usque ad os femoris, et fit hic locus totus mollis usque ad partem illam [...]It: Driedo le coste in la parte denanci sie la pele de fora, che copre el stomego e li budeli, e continuase con la malitia infin a l'osso del petencio. E <s/f>ase questo loco tuto mole in fina a quela parte e fi chiamada questa pele defora ventre. (14,34-15,2)
b. Lat: sub isto syphac ponitur os femoris, quod os factum est quasi ad modum semicirculi nisi quia in superiori parte versus umbilicum habet quandam eminentiam et ligatur in inquinibus cum anchis [...]It: Soto questo sifac se mete l'osso del petenegio fato a modo de mezo circolo. Se non che in la parte de sotto ha una eminentia e fi ligado con le anche in lo inguinaio, aciò che elo faza distantia, aciò che'l sostegna queli loci da ligamento over ligamenti, sotto lo quale e in lo quale molto ample sono artarie e vene. (15,9-14)
Questi due estratti ci fanno capire che il femur designa effettivamente il pube. L'illustrazione ciconferma la forma 'semicircolare' dell'osso pubico, di cui parla il trattato (es. b: l'osso del petenegiofato a modo de mezo cirolo).
Figura 2: Il pube/ L'osso pubico
50

Lo schema di Von Wartburg-Ullmann può dunque essere arricchito in questo modo105.
'anca' 'coscia' 'pube'
Anatomia (versione latina) hanka coxa femur
Traduzione italiana anca cossa petenegio
È da notare che l'uso della voce femur per indicare il 'pube' è raro. Non è stato documentato neidizionari del latino medievale che abbiamo consultato. Si documentano tuttavia dei significati affinicome il 'pelo pubico' (Latham 1975: 917a) e il 'sesso maschile' (Georges&Georges 1918). In italiano contemporaneo, il femore non indica il 'pube', questa voce è bensì sinonimo di coscia(Garzanti 2014).
Sintesi
Petenegio, nel Guglielmo vulgare, esprime il significato 'pube'. E' una voce costruita sull'etimolatino pecten 'pettine' o 'pube'. L'origine del suffisso -eggio è incerta. Ciò nonostante è quel suffissoche nel trattato permette di distinguere fra petenegio 'pube' e petene 'metacarpo o metatarso'. Inlatino, infatti, i significati 'pettine' e 'pube' coincidono nella forma pecten, come è anche il caso ingreco, dove quei significati vengono espressi con la voce kteis. Il rapporto metaforico fra i due sensiè allora stabilito anche al di fuori delle lingue (neo)latine.
105Nella traduzione francese di Nicole Prévost (1492), la distribuzione delle denominazioni è ancora diversa: hanche 'anca', hanche 'coscia' e cuysse 'pube'.
51

4.10 Scaio, schaio, asela
Scaio nell' Anatomia
a. Driedo questi muscoli sie ordenado vene manifeste e occulte; una dele quale le parte dala
saphena, over dela vena de laqual è manifesta in lo scaio (11, 15-17)
Post istos musculos ordinantur venae manifestae et occultae, quarum una dividitur a vena ascellari, vel a vena
quae est in ascella manifestatur. (32, 18-19)
b. Dal schaio desoto vien un altra, la qual passa per lo profundo de l'aiutorio infin al gombedo (11,
22-23)
Ab ascellari inferiori venit illa vena, quae transit per profundum adiunctorii usque ad cubitum (34, 4-5)
c. E dela [vena] humerale cefalicha over aselata in la parte desoto nasce e pare una, la qual è in la
piegadura del brazo in mezo e fi chiamada purpurea over negra over comuna. (11, 27-28)
Ex humerali autem et ascella inferiori cephalica nascitur et apparet quandam vena, quae est in
curvatura brachii in medio et vocatur purpurea seu nigra vel communis [vel matrix a quibusdam]
(34, 7-9)
d. El è cognosuto come la vena comuna serve ali membri desopra e desoto, le qual manifestamente
appare in mezo dela piegadura del gombedo e questo sie perché del humeral desopra e dela asela
desoto ela nasce e fi componuda sì come manifestamente apare. (12, 11-14)
Notorium est enim, quo modo vena communis servit membris superioribus et inferioribus, quae
manifeste apparet in medio curvaturae cubiti; et haec est propterea, quia ex humerali superiori et
ascella inferiori nascitur et componitur ut manifeste apparet. (36, 5-8)
e. E dal ramo dela forcola nase el ramo el qual va al humero e al scaio (12, 25-26)
Et ex ramo furculae nascitur ramus quae vadit ad humerum et ad ascellam (36, 18)
La voce scaio rende il latino ascella. Una sola volta, ascella è resa con la sua continuazione direttaasela.
52

Aspetti formali e semantici
La forma latina ascella è l'equivalente medievale del latino classico axilla 'ascella' (< lat. ala)(Walde 1965: 89). Tale variante è attestata a partire dal VI-VII secolo con Isodoro da Siviglia (DuCange 1883-1887). In italiano, una prima attestazione di ascella si trova in Dante106 (TLIO 1994-).La voce rimane tuttavia rara. Per quanto riguarda i volgarizzamenti della Chirurgia, secondo AlieriBiaggi “ascella [...] viene sempre reso con scaio, lasena, titilico, faldella, ecc. Resistenza […] chenon ci meraviglia affatto perché, se è vero che ascella è già in Dante, sappiamo che questo terminesuonava ancora ''latino'' al Varchi, nel Cinquecento, mentre documentava l'uso del terminefiorentino ditelle” (1970: 39-40). Questa spiegazione è sorprendente, dal momento che non ci sono indizi che permettono di supporreun rifiuto – o “resistenza” – ai termini latini nel volgarizzamento. Nei volgarizzamenti a stampacontrollati (Brescia 1486, Milano 1504 e Venezia 1504) la voce asela è addirittura presente. Vieneusata inoltre la collocazione vena aselata 'vena ascellare'107, espressione che risale allo stesso etimo,senza ulteriori spiegazioni che potrebbero marcare una resistenza.
L'etimologia di scaio è incerta. L'ALI (1995: 43) documenta l'uso di questa voce nei dialetti delFriuli-Venezia Giulia, soprattutto a Trieste e nei dintorni. Nel Veneto orientale abbiamo la formascaĝo108, documentata anche da Boerio con la grafia scagio (1867: 614). Nel Dizionario del Dialetto Triestino, Pinguentini ipotizza un'origine celtica asgall (1969: 280b-281a). La forma si sarebbe continuata in sgalo > sgalio > scaio. Il presunto sviluppo èproblematico, perché presenta delle evoluzioni fonetiche difficilmente spiegabili (p.es. sgalo [l] >sgalio [lj]). Un'altra proposta è l'etimo greco skaios 'sinistra', “per l'abitudine di portare alcunché sotto l'ascellasinistra” (ibid.). L'esistenza della variante sottoscaio (ven. sottoscaĝo) (ALI 1995: 43) rende laproposta più convincente. Un esito fonetico [dʒ] (ven.) della semiconsonante intervocalica [j] (grecoe triestino) pare possibile109. L'attestazione di una parola (dialettale) greca che denota sia 'sinistra'che 'ascella' potrebbe accertare l'ipotesi. Siccome non abbiamo potuto ritrovare una tale voce, laquestione rimane aperta. Boerio (1867: 614) pensa ancora ad una corruzione di scavo, ma quella proposta viene considerata“fantasiosa” dal Pinguentini (1969: 281a) e infatti non è sostenuta da sviluppi fonetici documentate.
106 Commedia, Inf. XVII, 13 (1321)107 L'espressione risale allo al latino vena ascellata (in Costantino l'Africano, XI secolo) (Du Cange 1883-1887)108 ĝ = [dʒ] 109 E' uno sviluppo regolare dal latino classico all'italiano (Rohlfs 1966: 304). Mancano i dati per stabilire con certezza
lo sviluppo della semiconsonante intervocalica dei prestiti greci nell'area romanza nordorientale.
53

4.11 Strangosare
Strangosare nell' Anatomia
Le vene e artarie in lo colo molto manifeste sono de dredo le orechie. La incision dele quale sie
molto timorosa, perché per la incisione de quelle, per la soa visineza el cor, con el polmone e col
cerebro, se ne siegue strangosare e defeto de molte cose e per lo molto flusso de sangue se ne
siegue molte fiade morte (7-34, 8-5)
Venae autem et arteriae in collo manifestae sunt duae post aures, quarum incisio valde timorosa est, quod ex
incisione earum propter earum affinitatem cum core et pulmone et cerebro sequitur sincopis [et] defectus in
multis rebus et ex incisione ipsarum nimius fluxus sanguinis [...] mors sequitur multotiens (22, 8-10)
La voce strangosare 'perdere i sensi' (Verlato 2009: 744) è attestata una sola volta nella Cirurgia etraduce il latino sincope 'svenimento' (Lewis & Short 1879).
Aspetti formali
Strangosare è una voce settentrionale110, composta dal verbo angosciare (< lat. angustiare'restringere') ed il prefisso stra-, che indica un eccesso111.
Verlato (2009: 744) propone come spiegazione etimologica un'interferenza tra angosciare estrangolare. Anche se vi sono locutori che fanno effettivamente questa associazione (5 sui 7locutori che hanno commentato la voce nelle interviste a Milano112), l'ipotesi è difficilmentesostenibile per due ragioni. La prima è l'esistenza del prefisso stra-, indipendentemente dalla vocespecifica strangolare. Il morfema ricorre frequentemente in verbi che hanno un significato moltodiverso. Il Vocabolario Treccani illustra la produttività del prefisso con una serie di esempi, qualistrafare, stravincere, strapagare, ecc. Un sinonimo di strangosare, fornito da Boerio (1867: 771a)e Cherubini (1838: 322b), è trambasciare, da tra- e ambascia (Pianigiani 1907). La corrispondenzastrutturale delle due parole suggerisce la natura composta di strangosare, piuttosto che un rapportoambiguo con strangolare.Infatti, la voce strangosare stessa esprime dei significati che sono poco compatibili con il senso distrangolare (LEI 1972-: 1262): strangosare 'fare una cosa in furia' (b.piem.), strangosaa 'profondasonnolenza' (trent.or.), strangusciata 'lunga e stancante cammino' (trent.or.).
Aspetti semantici
Nella Cirurgia la voce latina sincope viene usata da Guglielmo per due significati: il 'sonno'113 e lo'svenire'. Nel libro dell'Anatomia – che è il quarto libro della Cirurgia – il senso è quello di'svenimento'.
110Riscontrata anche in siciliano antico (LEI 1972-, vol.2, 1262: strangusciare, sec.XV)111Vocabolario Treccani, stra-112cf. §4.4, Prospettive di ricerca113“sincopis appellatur somnus a laycis” (I, 59), citato in Altieri Biagi (1970: 12-13)
54

I significati di strangosare nei dialetti settentrionali, documentate da Boerio (1867) e dal LEI(1972-) si potrebbero suddividere in 'possibili cause dello svenimento' (Boerio: 'riempirsid'angoscia, penar grandemente'), lo 'svenimento' stesso oppure significati affini quali il 'sonno' e la'morte'. Alcune collocazioni registrate dal Boerio (1867: 771a) portano il senso generalizzato di'passione o brama eccessiva':
strangossar de la brama: agognarestrangossar de la fama: star aspettando avidamente il cibostrangossar per voglia de bever: morire o affogar di setestrangossar dal gusto: godere assai di che che sia
55

4.12 Zotischare
Documentazione
Zotischare nell' Anatomia
a. Quando l'osso esce dal logo, [...] salta fora e non fi curado in soa vita che elo non zotischa. (18,24-25)
os vertebri exit a loco, [...] resilet et non curatur quin in vita sua claudicet (56, 2-5)
Zotischare nei dizionari e in altri documenti
La voce zotischar(e) in quella forma specifica non è stata documentata da nessun dizionario. Graziealla versione latina della Cirurgia, il senso di 'zoppicare' (claudicare in latino) può essere affermatocon certezza. Voci simili sono attestate nelle varietà nordorientali dell'italiano. Per il veneto, Boerio (1867)114
registra il verbo zotar 'far diventar zoppo o divenir zoppo'. I verbi zotegar, zotignar e andarzotignon esprimono il senso affine 'zoppicare'. I nomi appartenenti a questa serie lessicale sonozota 'zoppaggine', zoto 'zoppo' e le derivazioni zotin e zoton. Per il friulano, Pirona (1992) registra ilnome zuèt 'zoppo' e il verbo zueteâ115.
Per il fiorentino abbiamo la voce – relativamente rara116 – ciotto. In un commento alla Commedia,Vieusseux (1829) critica la posizione ideologica di un tale professor Viviani (cit.), che fa dipenderela voce dantesca ciotto dal friulano zuèt e dal veneto zot.
“Ma quello che stava massimamente a cuore al prof. Viviani era lo sventare la vanapretensione di coloro i quali vogliono che la favella del sì debba chiamarsi Toscana e nonpiuttosto italiana […] domanderemo: qual documento avremo per credere che Dante, perintrodurre maggior dolcezza nel vocabolo, abbia da zot, o zuet formato ciotto […] cangiandola z in c, e aggiungendo la finale o ; piuttosto che credere che i veneti e i friulani abbiancangiato il c in z , e soppressa [sic] la o finale , secondo il loro solito?” (Vieusseux 1829: 30).
Bisogna notare che la critica espressa da Vieusseux è altrettanto ideologica, visto che suggerisce chei dialetti settentrionali derivano dalla norma toscana.Per ciotto 'zoppo' il TLIO documenta le varianti settentrionali cioto, çot e çot(t)o. Le primeattestazioni veneziane (XII-XIII secolo) sono anteriori a quelle toscane (XIV secolo), il checonfermerebbe l'affermazione di Viviani che la voce toscana ciotto è un prestito dei dialettinordorientali.
114Dizionario del dialetto veneto, 821c-822a.115Vocabolario del Friulano, 1323a.116Ciotto, attualmente non ha più il significato di 'zoppo'. Quel significato è ancora documentato nel Vocabolario della
Crusca (tutte e quattro le edizioni), con esplicito riferimento a Dante, un commentatore di Dante e Francesco Sacchetti.
56

Aspetti morfologici
Il Boerio 1867 e il Pirona 1992 non fanno riferimenti morfologici per le rispettive entrate zoto ezuet. Per çoto il TLIO segnala un'”etimologia incerta”. Sulla scia di Pisani (1976: 156-158), vienesuggerito uno sviluppo da *clottus117.Lo sviluppo regolare del nesso consonantico iniziale [kl] in area settentrionale è quello in [tʃ]. Inalcune zone della Lombardia, della Liguria, del Veneto e della Romagna vi è un'ulteriore sviluppoin [ts] (Rohlfs 1966: 244). Il grafema <z> è una variante tipografica per rendere il fonema [ts].
Lo stesso sviluppo può aver portato dal latino tardo cloppus118 all'italiano zoppo. Il DELI119 presentaanche alcune altre ipotesi, che aggirano la questione dell'evoluzione fonetica [kl] > [ts]:
(1) zoppo < *soppu(m) < suppes (sub + pes 'dai piedi storti') + cloppu(m) (De Gregorio, Studiglottologici italiani, VIII, 1928, pp.315-316).
(2) zoppo < *zaupo 'tronco' (Prati, RLiR XII, 1936, p.130)
(3) zoppo < la forma onomatopeica preromana *zopp-/ *zupp- (Hubschmid, RLiR XXVII,1963, pp. 417-422)
Pianigiani (1907) sospetta un etimo germanico e riferisce al Muratori e a Diez, affermando chezoppare proviene da schoppen 'urtare col piede'. L'esistenza delle voci francesi cloper 'zoppicare' eclopin 'zoppo', rende tuttavia più probabile l'etimo tardo-latino cloppus.
Aspetti (morfo-)semantici
Nella serie lessicale veneta, come in quella italiana, siamo confrontati con la presenza o l'assenza diun infisso. Nella tabella qui sotto presentiamo (1) i verbi veneti formati sulla base zot-120, (2) i verbiitaliani formati sulla base zopp- e (3) gli infissi latini da cui derivano gli infissi veneti e italiani.121
Veneto (Boerio 1867) Italiano Latino
zot-Ø-a-r -Ø-
(az-)zopp-Ø-a-re-Ø- -Ø-
zot-eg-a-r-eg-
zopp-ic-a-re-ic- -ic-
(friul.) zuet-e(j)-â-e(j)-
zopp-eggi-a-re-eggi- -idi-
zot-isc-ar-(i)sc- -sc-
zot-ign-a-rzot-ign-o-(i)gn-
-(i)ne-us
117Attestato invece è l'aggettivo claudus 'zoppo' (Lewis & Short 1879)118Ménages (1694: 203) segnala un'attestazione della voce cloppus nel glossario latino-greco del Pseudo-Philoxenus
che attualmente si fa risalire ad un momento fra il VI e il IX secolo (Boulanger 2003: 204). La voce sarebbe un prestito del greco xwlopouj (Du Cange 1883-1887, cloppus).
119zoppo, p.1469. I riferimenti bibliografici sono stati ripresi dall'entrata nel DELI.120Aggiungiamo l'hapax zotiscar, non registrato da Boerio 1867, ma formato sulla base zot- e il verbo friulano zueteâ,
che presenta la continuazione friulana -e(j)- dell'infisso latino -idi- nella prima coniugazione (Meul 2011: 207)121Gli infissi latini -sc- e -ine- hanno ugualmente una continuazione in italiano, ma non in combinazione con la radice
verbale zop-. Per questo motivo non sono stati ritenuti nel quadro.
57

L'infisso122 veneto -eg- e quello italiano -ic- hanno, secondo Rohlfs, un valore rafforzativo (1969:468-469). In italiano viene usato anche l'infisso -eggi-, proveniente dal latino volgare -idi- convalore frequentativo (Rohlfs 1969: 465-466). Nel veneto sono presenti varianti con due altri infissi:-isc- e -ign-. Anticamente, -isc- aveva valore incoativo (Rohlfs 1968: 243). Il verbo zotignar èderivato da zotigno in cui l'infisso -ign- (< latt. -ine-) serve alla derivazione aggettivale a partire daun nome (zoto) (Rohlfs 1968: 243).
I significati degli infissi, così come sono stati descritti da Rohlfs 1968-1969, si fanno allorariassumere in questo modo:
-ic--eg-
rafforzativo
-idi--eggi--e(j)-
frequentativo
-sc- incoativo
(-gn-) (nome > aggettivo)
Per il valore del latino -sc-, Meul (2011: 81) fa notare che l'aspetto incoativo è stato enfatizzato daigrammatici latini e anche in alcuni lavori più recenti, ma che attualmente prevale la convinzione chel'infisso è caratteristico per un processo in atto, un “divenire”123.
Considerando la serie lessicale di zotare/zoppare vediamo tuttavia che i verbi che esprimono ilprocesso in atto 'divenir/rendere zoppo' sono quelli senza infisso, rispettivamente zotare e(az)zoppare, mentre tutte le forme infissate esprimono il valore che Rohlfs (1969) chiamafrequentativo (altrove iterativo124), ovvero il 'camminar zoppo'. Il significato originariamenteriservato a -idi- si è quindi generalizzato ad una serie più ampia d'infissi.
Nella sua analisi dello sviluppo diacronico di -sc- e -idi-, Meul (2011) conclude che nelle varietàromanze l'infisso -idi-, può occorrere con proprietà lessico-aspettuali (p.e. iterativo in zueteâr)oppure come morfema grammaticalizzato nella coniugazione di certi verbi125. L'infisso -sc- invece si continua oppure come morfema aspettuale (nelle varietà ibero-romanze)oppure come morfema flessivo (nelle varietà gallo-italiche) (Meul 2011: 107).
L'uso iterativo dell'infisso -sc- in zotischare, che troviamo nel Guglielmo Vulgare, sarebbe unadeviazione dalla tendenza sopramenzionata, in quanto quell'infisso nelle varietà italiche sarebbedovuto essere un morfema flessivo. Infatti la voce è un hapax e non lascia tracce in tempisuccessivi.
122Rohlfs (1969: 468-469) tratta -icare, -idiare e -esco/-isco come suffissi. Per dare maggior rilievo ai valori aspettuali espressi da -ic-, -idi- e -(i)sc-, preferiamo distinguere fra il morfema che indica l'aspetto, la vocale tematica e il morfema flessivo, categorizzando -ic-, -idi- e -(i)sc- come infissi, allineandoci a Meul 2011.
123“This kind of 'inchoative' characterization of the SC-verbs is also found in some more recent work. Yet currently thebroad consensus on the semantic-aspectual value of Latin -sc- is that it conveyed a meaning equivalent to 'becoming'rather than to 'beginning'” (Meul 2011: 81)
124Meul 2011.125Per esempio l'indicativo presente del verbo petener 'pettinare' nel dialetto di Fassano: peten-e-e, peten-e-es, peten-e-
a, petenon, petenède, peten-e-a (Meul 2011: 19)
58

Sintesi
La voce zotischare è un hapax. Dal momento che disponiamo della versione latina della Cirurgia,vi sono pochi dubbi sul suo significato 'zoppicare'. Da un punto di vista morfologico due aspetti hanno ritenuto la nostra attenzione: la <z> iniziale el'infisso -sc-. La <z> iniziale è probabilmente dovuta all'evoluzione fonetica del nesso consonanticolatino [kl] a [ts] nell'Italia settentrionale, descritta e illustrata da Rohlfs (1969). E' pertanto probabilelo sviluppo simile dal tardo-latino cloppus all'italiano zoppo. L'infisso -sc- in questo testo specifico, ha valore iterativo, come in italiano gli infissi -ic- (zopp-ic-are 'andar zoppo') e -eggi- (zopp-eggi-are 'andar zoppo'). Il latino -sc- esprimeva non un iterativo,ma un processo in atto o un cambiamento di stato. Per esprimere un 'divenire', generalmente non siusano infissi nelle varietà italiane (cf. per 'diventar zoppo': it. (az)zoppare, ven. zotare). L'infisso siè invece grammaticalizzato in un morfema flessivo della quarta coniugazione. Il ricupero del morfema -sc- con carattere lessico-aspettuale, ma anche con un significato diversodal significato latino, insieme alla radice verbale zot-, la quale distribuzione è circoscritta allevarietà nordorientali, potrebbe spiegare la non-lessicalizzazione della voce.
59

4.13 Discussione dei risultati
Il campione delle voci analizzate presenta una grande variazione interna. Il criterio che le accomunaè una divergenza formale e/o semantica dalla voce che si trova nel luogo corrispondente nel testolatino (cf. §3.1.2 Selezione dei termini). Una tale scelta ci ha permesso di analizzare attentamente ilpercorso etimologico delle parole che porta dalla loro origine al loro uso nella Cirurgia e,eventualmente, alla loro lessicalizzazione successiva. Una conseguenza di questo approccio è che il campione non è rappresentativo per l'insieme dellessico scientifico nel testo. Una grande quantità di voci infatti sono prestiti o continuazioni regolaridelle espressioni latine del testo-fonte. Tuttavia, lo studio delle parole che illustrano il versante con il più alto grado di “vernacolarità”permette di fare alcune osservazioni sulla genesi e lo sviluppo del lessico specializzato (a-c) esull'importanza della dimensione spaziale del volgarizzamento, un testo che si inserisce in uncontesto geografico specifico (d).
a) Per quanto riguarda la dimensione formale, la selezione comprende voci derivate (malmenchion,bossolo, petenegio) e voci composte (osso de la lauda, ossi vernali, pesse de la gola). A eccezione di petenegio, il cui suffisso è difficilmente spiegabile126, i suffissi derivativi, checonferiscono un significato specializzato alla voce-base (di significato più ampio), sonooriginariamente accrescitivi (malmenchion < minchia, pettignone < pectenionem < pecten) odiminutivi (bossolo < bosso, petenèt < petene).
b) Sono altresì presenti le voci scientifiche cui senso si basa su una metafora: didimo, verga, cannadel stomego, petene, petenegio. Nella maggior parte dei casi, la metafora è già funzionale nel testolatino. Solo la metafora “pube-petenegio” non è presente nella fonte, dove si usa la voce femur. Illegame metaforico “pube-pettine (di cui petenegio non è che una differenziazione formale)” ècomunque presente in altri testi latini e greci. Abbiamo riscontrato un solo caso di trasferimento semantico per via di metonimia: l'aggettivo latinomaurus è passato dal significante 'abitante arabo o islamizzato dell'Africa del Nord o della Spagnamusulmana' al senso generalizzato 'di colore oscuro'.
c) Fenomeni di rianalisi (formale) o rimotivazione (semantica) sono frequenti. Le voci nothomia,pesse dela gola, morene, merisfagus, osso de la lauda e ossi vernali rientrano in queste categorie.Tali formazioni paretimologiche non sono fattori che determinano la lessicalizzazione della voce.Pesse dela gola, merisfagus e morene non si lessicalizzano in italiano127. Osso de la lauda e ossivernali sono espressioni che ricorrono anche in altri testi, precedenti e contemporanei alvolgarizzamento cinquecentesco. Notomia è la variante preferita fino al '700 e ancora ricorrentenell''800. L'italiano attuale mantiene il verbo derivato notomizzare.
d) In questo volgarizzamento vengono usate voci la cui distribuzione geografica è limitata. Cosìscaio 'ascella' e petenegio 'pube' sono parole riscontrate esclusivamente nei dialetti dell'areanordorientale d'Italia. Le voci zotiscare, gombedo e strangosare presentano degli sviluppi foneticiprettamente settentrionali. La variante (grafica) nothomia (con epentesi) sembra anch'essa essereusata prevalentemente al nord.
126 Forse da *pecteniculum > *peteneclu(m) > petenechio > petenecio. In tale caso petenegio (in quanto diminutivo) s'inserisce nel ragionamento.
127 Anche se morene, con il significato di 'emorroidi', viene tuttora usato nel catalano.
60

La presenza di voci regionalmente marcate è un elemento fondamentale se consideriamo ladimensione pedagogica del testo. Grazie alla presentazione parallela della terminologia classica e leequivalenti vernacolari in serie sinonimiche, il lettore acquisisce un ampio ed articolato quadroterminologico. Da un punta di vista linguistico, un'analisi delle voci vernacolari mette in luce la stratificazione deldiscorso scientifico. Al lessico specializzato, cioè al lessico che viene usato nella comunicazionescientifica, non appartengo soltanto voci formalmente e semanticamente trasparenti euniversalmente accolte, ma anche realizzazioni specificamente situate nello spazio e nel tempo.
61

5. Conclusione
Svolgendo un'analisi etimologica di un campione di elementi lessicali scientifici tratti dalvolgarizzamento cinquecentesco della Cirurgia, ci siamo soffermati sull'origine delle voci, sul lorouso contestuale e sulla loro eventuale lessicalizzazione.
La discussione dell'uso contestuale si basa sulla nostra trascrizione del quarto capitolo dellaCirurgia (in appendice). L'edizione di riferimento è quella milanese del 1504. Altre versioni cheabbiamo controllato durante la trascrizione e le indagini etimologiche sono l'edizione bresciana(1486) e una veneziana (1504). Le tre versioni dimostrano una chiara interdipendenza nella sceltadegli vocaboli. Le citazioni italiane fornite nella tesi sono state messe a fronte con citazioniprovenienti dalla versione latina ricostruita da Schaarschmidt (1909).
La ricostruzione del percorso etimologico è basata su indagini lessicografiche. Per rintracciarel'origine delle parole ci siamo serviti di dizionari di latino, dizionari etimologici e dizionaridialettali. I percorsi di stabilizzazione lessicale sono stati affrontati con diversi approcci. Il metodopiù importante era la consultazione di dizionari sincronici di diverse epoche, sia per l'italiano cheper i dialetti. Anche l'Atlante Linguistico Italiano ha fornito delle informazioni preziose riguardoalla distribuzione geografica di alcune voci ricorrenti nei dialetti. Un altro strumento che abbiamo esplorato è il programma Google NGram Viewer, che visualizza lafrequenza relativa di due o più termini a partire dalla banca dati di Google Books. Per il momento,la banca dati è troppo poco fornita per poter studiare in modo approfondito il lessico di periodimeno recenti. Pertanto, in questo lavoro, le analisi di NGram Viewer sono state confrontate con letendenze individuate tramite le ricerche lessicografiche. Interviste audioregistrate con dialettofoni, in cui si verifica la conoscenza (almeno passiva) dellevoci selezionate, possono offrire nuove prospettive di ricerca. Un tale metodo richiede tuttavia unperiodo esteso di ricerca sul campo; ragione per cui l'approccio viene evocato solo brevemente inquesto lavoro.
Dalle indagini emerge il ruolo importante della zona geografica in cui ha circolato il testo. Ilvolgarizzamento presenta voci con caratteristiche fonetiche e/o morfologiche settentrionali e ancheespressioni dialettali con una distribuzione geografica relativamente limitata.
La selezione delle voci è stata fatta in base al loro interesse etimologico. Essendo stati esclusi iprestiti e le continuazioni regolari dal latino, il campione non è una rappresentazione fedele dellessico scientifico presente nel testo, bensì una selezione delle varianti più “vernacolari”.
Trosborg (1997) rappresenta la comunicazione scientifica in uno schema cartesiano, in cui l'asseverticale rappresenta i vari strati della comunicazione scientifica. Gli estremi sono costituiti da unregistro dotto in alto ed un registro popolare in basso. Altri studiosi hanno sviluppato il modello edinnalzato il numero di divisioni su quest'asse. Il volgarizzamento, tuttavia, si lascia difficilmentecategorizzare secondo il “registro” delle voci che contiene. Occupa in effetti una posizioneintermedia, presentando serie sinonimiche di termini più latineggianti e voci più marcateregionalmente. Questa particolarità è da collegare con l'esplicito intento pedagogico del testo, nelquale viene fornito al lettore uno strumentario terminologico ampio e stratificato. Queste tecnichedella trasmissione del sapere rendono interessante lo studio del volgarizzamento nell'ambito delladivulgazione scientifica.
62

Per la linguistica storica, un'analisi del lessico scientifico in un volgarizzamento comporta unamaggiore attenzione per le particolarità geolinguistiche del testo. La considerazione del contestolocale è un arricchimento nello studio sullo sviluppo del lessico specialistico, che non dovrebbelimitarsi alle sole voci semanticamente e formalmente trasparenti. Con la presente tesi speriamo aver contribuito alla conoscenza etimologica di alcune voci, mettendoin rilievo l'interesse di un approccio che tenga conto del cotesto e del contesto spazio-temporale esociale.
63

6. Bibliografia
6.1 Documenti
Baraldi, P. (2008). Il Libro di Segreti. Trascrizione del Ms. Campori 74 = Campori Appendice 159= gamma.S.6.3 della Biblioteca Estense, Modena.
Pubblicato online: http://bibliotecaestense.beniculturali.it/info/img/cat/i-mo-beu-stru-archeo-gamma.s.6.3.pdf, consultato il 9 ottobre 2014.
Caelius Aurelius (V secolo), Colinaeum, S. (1533, edit.). Caelii Aureliani methodici siccensis: libercelerum vel acutarum passionum, qua licuit diligentia recognitus, atque nunc primum in lucemaeditus. Parigi: Colinaeum.
Versione online (Gallica): http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54399p.r=Caelius+Aurelianus.langEN, consultato il 26 ottobre 2014.
Columbre, A. (1518). Libro de Manuscansia. Venezia: Guglielmo da Fontaneto de Monferra.
Liuzzi, M. (1316), Giorgi, P. (1992, edit.). AnothomiaPubblicato online (Bresadola M., Fezzi P., s.d.):
http://cis.alma.unibo.it/Mondino/textus.html, consultato il 26 ottobre 2014.
Peranzoni, R. (1515, edit.). Opera del clarissimo poeta Francesco Petrarca con el commento demisser Bernardo Lycinio sopra li triumphi. Venezia: Augustino de Zani
Scippacercola, R. (1995). Introduzione alle Antiquarie Prospettiche Romane.Pubblicato online:
http://www.liberliber.it/mediateca/libri/a/antiquarie_prospettiche_etc/antiquarie_prospettiche_romane_composte_per_prospettivo__etc/html/introduzione.htm, consultato il 19 ottobre 2014.
Von Jan, L. (1852, edit.), Macrobius (V secolo). Saturnalia.Pubblicato online (Bill Thayer, s.d.):
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Macrobius/Saturnalia/home.html, consultato il26 ottobre 2014.
64

6.2 Articoli e libri
Agrimi, J., Crisciani, C. (1994). The science and practice of medicine in the thirteenth centuryaccording to Guglielmo da Saliceto, Italian surgeon in García-Ballester, L. (edit.). Practicalmedicine from Salerno to the Black Death. Cambridge: University Press. pp.60-87.
Allan, K. (2013). The Oxford Handbook of the History of Linguistics. Oxford: University Press.
Altieri Biagi, M. (1970). Guglielmo volgare. Studio sul lessico della medicina medioevale. Bologna:Forni.
Apothéloz, D., Boyé, G. (2004). Remarques sur la compositionnalité en morphologie. In Verbum.Budapest: Akadémiai Kiadó, pp.375-385
Articolo pubblicato separatamente sul sito della CLLE-ERSS: http://w3.erss.univ-tlse2.fr:8080/index.jsp?perso=boye&subURL=ABo05-Verbum-CompositionnaliteMorphologie.pdf.
Azzolini, M. (2006). Leonardo da Vinci's anatomical studies in Milan. Re-Examination of sites andsources in Givens et al. (edit.). Visualizing Medieval Medicine and Natural History. Aldershot:Ashgate. pp.147-176.
Bazin-Tacchella, S. (2007). Constitution d'un lexique anatomique en français aux 15e et 16esiècles. in Bertrand, O., Gerner, H. e Stumpf, B. (edit.), Lexiques scientifiques et techniques:constitution et approche historique. Palaiseau: Éditions de l'École Polytechnique, pp. 65-80.
Bitterling, K. (2002). Sprachkontakt und Übersetzungsliteratur in spätmittelalterlicher Zeit. InAnglia. 120 (2002), pp.200-227.
Boulanger, J.-C. (2003). Les inventeurs de dictionnaires. De l'eduba des scribes mésopotamiens auscriptorium des moines médiévaux. Ottawa: Presses de l'Université.
Ciranni, R. (2009). Andrea Vesalio nello Studio Pisano di Cosimo I de' Medici. In Athenet online.Notizie e approfondimenti dall'Università di Pisa. num. 29, pp. 4-8Pubblicato online: http://www.unipi.it/athenet/29/athenet29.pdf, consultato il 26 ottobre 2014.
Coco, A., Di Stefano, F. (2008). La Chirurgia di Guglielmo da Saliceto: nuove ricognizioni sullatradizione manoscritta in volgare. In Filologia Italiana 5.2008. Pisa/Roma: Fabrizio Serra Editore.pp.53-99.
Corbolante, L. (2013). Language: lingua e linguaggio. In Terminologia etc.Pubblicato online: http://blog.terminologiaetc.it/2013/06/17/differenza-lingua-linguaggio/,
consultato il 30 ottobre 2014.
Cortelazzo, M. (1990). Lingue speciali. La dimensione verticale. Padova: Unipress.
Cottez, H. (1980). Introduction théorique et pratique. In Dictionnaire des structures du vocabulairesavant: éléments et modèles de formation (Les usuels du Robert). Paris: Le Robert. pp. VII – XXXI.
Dysert, A. (2007). Capturing Medical Tradition. Caelius Aurelianus' On Actute Diseases.Pubblicato online:
65

https://www.academia.edu/325369/Capturing_Medical_Tradition_Caelius_Aurelianus_On_Acute_Diseases, consultato il 10 novembre 2014.
Garzoni, T. (1626). La piazza universale di tutte le professioni del mondo. Venezia (cit. in Pellegrini1965).
Gotti, M. (2005). Investigating specialized discourse. Bern: Peter Lang.
Heimerl, C. (2008). The Middle English version of William of Saliceto's Anatomia. Heidelberg:Universitätsverlag Winter.
Hyrtl, J. (1879). Das Arabische und Hebräische in der Anatomie. Vienna: Braumüller.
Lerat, P. (1995). Les langues spécialisées. Paris: PUF.
Meul, C. (2011). The Romance reflexes of the Latin infixes -i/esc- and -idi: restructuring andremodeling processes. Tesi di dottorato, KULeuven.
Mecking, V. (2014). La terminologie médicale du XVI siècle entre tradition et innovation. In Larevue de l'Institut Catholique de Lyon, 24 (9), pp.63-73.
Mørland, H. (1932). Die lateinischen Oribasiusübersetzungen. Oslo: Brøger.
Pellegrini, G.B. (1965). L'elemento arabo nelle lingue neolatine. In L'Occidente e l'Islam nell'AltoMedioevo. Spoleto: Centro italiano dei studi sull'Alto Medioevo. pp.697-790.
Pisani, V. (1976). Contributi all'etimologia italiana in Archivio Glottologico Italiano. Firenze: LeMonnier, vol. LXI, pp.156-158.
Pfister, M. (1980). Einführung in die romanische Etymologie. Darmstadt: WissenschaftlicheBuchgesellschaft.
Rohlfs, G. (1966). Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti. Fonetica. Torino:Einaudi.
Rohlfs, G. (1966). Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti. Morfologia. Torino:Einaudi.
Rohlfs, G. (1969). Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti. Sintassi e laformazione delle parole. Torino: Einaudi.
Sarukkai, S. (2001). Translation and science. In Meta: Translators' Journal, vol. 46, n° 4, p. 646-663.
Trask., R.L. (1993). A Dictionary of Grammatical Terms in Linguistics. Londra: Routeledge.
Vieusseux, G.P. (1829). Primo articolo della Rivista Dantesca. Firenze: G.P. Vieusseux, pp.1-36.
Verlato, Z. (2009). Le vite di Santi del codice Magliabechiano XXXVIII.10 della BibliotecaNazionale Centrale di Firenze. Un leggendario volgare trecentesco italiano settentrionale. In
66

Beihefte zur Zeitschrift für Romanische Philologie, band 348. Thübingen: Niemayer.
Von Wartburg, W., Ullmann, S. (1963). Problèmes et méthodes de la linguistique. Paris: PressesUniversitaires de France.
Zamboni, A. (1976). L'etimologia. Bologna: Zanichelli.
Zwanenburg, W. (1992). Composition savante et moyen-français. In Vox Romanica. Tübingen:Francke. Vol.5, pp.169-177.
67

6.3 Dizionari e atlanti linguistici
ALI = Massobrio, L. (dir.; 1995). Atlante Linguistico Italiano. Torino: Istituto poligrafico e zeccadello Stato.
Berti, C. (1874). Vocabolario bolognese-italiano. Bologna: Monti.
Boerio, G. (1867). Dizionario del dialetto veneto. Venezia: Cecchini.
Cherubini, F. (1838). Vocabolario milanese-italiano. Milano: Regia Stamperia.
Corominas, J. (1954). Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana. Bern: Francke.
Crusca = Accademia della Crusca (16121, 16232, 16913, 1729-17384). Vocabolario della Crusca.
DEI = Battisti, C., Alessio, G. (1951). Dizionario Etimologico Italiano. Firenze: Barbera.
DELI = Cortelazzo, M., Zolli, P. (1979-1988). Dizionario Etimologico della Lingua Italiana.Bologna: Zanichelli.
De Mauro, T. (2002). Il dizionario della lingua italiana. Torino: Paravia.
Devoto, G., Oli, G.C. (2009). Il Devoto-Oli. Vocabolario della lingua italiana. Firenze: Le Monnier.
DLC = Institut d'Estudis Catalans (1994). Diccionari de la llengua catalana. Barcelona:Enciclopèdia catalana.
Du Cange, C. et al. (1883-1887). Glossarium ad scriptores mediæ et infimæ latinitatis. Niort: L.Favre.Versione online: ducange.enc.sorbonne.fr.
Ferri, L. (1889). Vocabolario ferrarese-italiano. Bologna: Forni.
FEW = Von Wartburg, W. et al. (1922 - ) Französisches Etymologisches Wörterbuch. EineDarstellung des galloromanischen Sprachschatzes. Bonn: K. Schroeder, oggi Basel: R.G. Zbinden.
Gaffiot, F. (1934). Dictionnaire Latin-Français. Parigi: Hachette.
Georges, K.E., Georges, H. (1918). Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch,Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Godefroy, F. (1880 - 1902). Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes duIXe au XVe siècle, composé d'après le dépouillement de tous les plus importants documentsmanuscrits ou imprimés qui se trouvent dans les grandes bibliothèques de la France et de l'Europeet dans les principales archives départementales, municipales, hospitalières ou privées. Paris:Vieweg.
Latham, R.E. (1975). Dictionary of medieval latin from british sources. London: Oxford UniversityPress, Vol. I.
68

LEI = Pfister, M., Schweickard, W. (1979-). Lessico Etimologico Italiano. Wiesbaden: LudwigReichert.
Lewis, Charlton T. & Short, Charles. (1879). A Latin Dictionary. Founded on Andrews' edition ofFreund's Latin dictionary. revised, enlarged, and in great part rewritten by. Charlton T. Lewis,Ph.D. and. Charles Short. Oxford: Clarendon Press.Marchi, M.A. (1828). Dizionario tecnico-etimologico-filologico. Milano: Giacomo Pirola.
Melchiori, G.B. (1817). Vocabolario bresciano-italiano. Brescia: Franzoni e socio.
Ménages, G. (1694). Dictionnaire étymologique ou origines de la langue françoise. Parigi: JeanAnisson.
Neri, A. (1973). Vocabolario del dialetto modenese. Bologna: Forni.
Pape, W. (1880). Handwörterbuch der Griechischen Sprache. Braunsweig: Vieweg & Sohn.
Pianigiani, O. (1907). Vocabolario Etimologico della lingua italiana. Roma: Albrighi e Segati.
Pinguentini, G. (1969). Nuovo dizionario del dialetto triestino. Storico, Etimologico, Fraseologico.Bologna: Cappelli editore.
Pirona, G.A., Carletti, E., Corgnali, G.B. (19922). Il Nuovo Pirona. Vocabolario Friulano. Udine:Società Filologica Friulana.
Pappafava, G. (17962). Vocabolario veneziano e padovano co'i termini e modi correspondentitoscani. Padova: Conzatti.
TLFi: Trésor de la Langue Française informatisé.Pubblicato online: http://atilf.atilf.fr/
TLIO = Beltrami, P. et al. (1994-). Tesoro della Lingua Italiana delle Origini. Pubblicato online: http://tlio.ovi.cnr.it/TLIO/
Tobler-Lommatschz, A. (1915). Altfranzösisches Wörterbuch. Adolf Toblers nachgelasseneMaterialien bearbeitet und herausgegeben von Ehrhard Lommatzsch. Berlin-Wiesbaden: Fr.Steiner.
Walde, A. (1965). Lateinisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg: Winter.
69

6.4 Entrate in opere enciclopediche
Faloppa, F. (2010). Collocazioni. In Enciclopedia dell'Italiano. Treccani. Pubblicazione online: www.treccani.it/enciclopedia/collocazioni_(Enciclopedia-
dell'Italiano)/, consultato il 26 novembre 2014.
Fanfani, M. (2010a). Forestierismi. In Enciclopedia dell'Italiano. Treccani. Pubblicazione online: http://www.treccani.it/enciclopedia/forestierismi_
%28Enciclopedia_dell%27Italiano%29/, consultato il 26 novembre 2014.
Fanfani, M. (2010b). Calchi. In Enciclopedia dell'Italiano. Treccani. Pubblicazione online: http://www.treccani.it/enciclopedia/calchi_%28Enciclopedia_dell
%27Italiano%29/, consultato il 26 novembre 2014.
Fanfani, M. (2011). Prestiti. In Enciclopedia dell'Italiano. Treccani. Pubblicazione online: http://www.treccani.it/enciclopedia/prestiti_%28Enciclopedia_dell
%27Italiano%29/, consultato il 26 novembre 2014.
Fresu, R. (2010). Ipercorrettismo. In Enciclopedia dell'Italiano. Treccani. Pubblicazione online: http://www.treccani.it/enciclopedia/ipercorrettismo_
%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29/, consultato il 26 novembre 2014.
Iacobini, C. (2010a). Affissi. In Enciclopedia dell'Italiano. Treccani. Pubblicazione online: http://www.treccani.it/enciclopedia/affissi_%28Enciclopedia_dell
%27Italiano%29/, consultato il 26 novembre 2014.
Iacobini, C. (2010b). Composizione. In Enciclopedia dell'Italiano. Treccani. Pubblicazione online: http://www.treccani.it/enciclopedia/composizione_
%28Enciclopedia_dell%27Italiano%29/, consultato il 26 novembre 2014.
Palermo, M. (2010). Cancellerie, lingua delle. In Enciclopedia dell'Italiano. Treccani. Pubblicazione online: www.treccani.it/enciclopedia/lingua-delle- cancellerie_ (Enciclopedia
_dell 'Italiano)/, consultato il 26 novembre 2014.
Sgroi, S.C. (2011). Rianalisi morfologica. In Enciclopedia dell'Italiano. Treccani. Pubblicazione online: http://www.treccani.it/enciclopedia/rianalisi_%28Enciclopedia_dell
%27Italiano%29/, consultato il 26 novembre 2014.
Tagliavini, C. (1934). Neolatine, lingue. In Enciclopedia italiana. TreccaniPubblicazione online: http://www.treccani.it/enciclopedia/lingue-neolatine_
%28Enciclopedia-Italiana%29/, consultato il 26 novembre 2014.
Wikipedia (2014). Sagittal Suture. Consultato l'11 dicembre 2014.http://en.wikipedia.org/wiki/Sagittal_suture
70

6.5 Figure
p. 45. Sutura sagittale. Sobotta's Atlas and Text-book of Human Anatomy 1909. http://en.wikipedia.org/wiki/Sagittal_suture#mediaviewer/File:Sobo_1909_46_-
_sagittal_suture.png
p. 50. Osso pubico. Zantutorial.http://zantutorial.com/locomotion-and-movement/
71

Appendice: Trascrizione dell'Anatomia
72

Guglielmo vulgare in Cirurgia,
Milan: Johanne Angelo Scizenzeler, 1504
[...]
(p.134) Qui finisse el terzo libro e comenza el quarto.
Capitulo.i. dela nothomia e figura del capo e de la gola
[1] Avegna che'l sia promesso determinare de la nothomia, intention non so numerare tuti li membri
particular. Avenga che li antiqui siano sforzadi particularmente numerare li membri e partir in li
membri particulari e avenga che'l sia necessaria a notificar li membri semplici, tamen non se diparte
infin tanto che di parte in parte non sia inteso. Perhò che ogni corpo sie finito nela sua ratification
dele sue division, perfectamente sono manifeste ali sensi. In plusor membri per alguno modo le
ultime division deli membri over rarification non si possano per alguna via (p.135) manifestar, pero
che quando se taia l'osso secondo longeza, el esse sangue over humilditade [sic] da quello. Questo
necessario sie apresso tuti li. considerando e guardando in questi membri e ossi taiadi e
maximamente quando el corpo sie vivo.
[2] E tu die creder senza dubio che donde ensira sangue, el sera necessario che la vena se trova in
quello logo, e quando el sangue corre per ato caldo, el membro vivo, e che la presentia del qual
siegue presentia del caldo e del spirito sera intosaria, ala presentia del qual siegue la presentia de la
artaria e cossì necessariamente se trovano vene e artarie in quelli membri.
[3] Ampoi lo è ramification sotile e molti. In quelli son involti altri sentimenti sempre manifeste e
etiamdio conciò sia che sia posibile la nothomia, over l'ultima division deli membri. El nervo de
quelli meter inserito per la position de tale cosse, tanto increscimento vignerave che l'aia tignerave
per soa virtude over niente over poco ne vide aprenderave.
[4] Adonca è meio e più utele e a mi pare che'l sia processo in la nothomia, si come io promisi, cioe
in comun metando el nervo e la forma over figura, el sito over location deli membri, le qual cose
posano esser manifesti ali sentimenti aciò che tu possi proceder cum incision, scotadure e operation
1
5
10
15
20
25
30

manual senza error. E perché el cavo e quello che sta dentro, cioè el cerebro, è radise, over se
m<e>te per radise o tuto el corpo specialmente fi dito radise del sentimento e del movimento senza
la qual animale perfeto non po viver, né etiamdio li animali simplicemente così per la consequente
de la radise de tute lo comenzare secondo questa consideration.
[5] Primo de la notomia del cerebro del cavo e de li membri siando cerca quello e con cose el corpo
certo sie mole in la soa substantia medoloso, abiando la figura longa secondo la longeza del cavo e
in tute soe parte.
[6] Ma parte denanci e de driedo e de mezo, le qual parte se chiama ventricoli, perché in questa
division ciascuna parte [h]a una rotonditade retetene [sic] forma quasi de ventre. In questi ventricoli
sono concavitade in li quali stanno li spiriti animali e in li quali receveno alteration e digestion aciò
che li sia apti ale operation manuale da fir complide. E avenga che tali ventricoli siano numeradi
continuamente iii. Quello denanci, al quale sie assai mazor de li altri, tuti se divide in do parte
manifeste. Perciò da alguni fi diti ventricoli del cerebro iiii. Avegna che li altri doi ventricoli
habiano separatione, eli non fi diti haver division. Del primo ventricolo se divide in ii parte.
Dividese manifesto in la presente. Dal primo ventricolo del cerebro se ordena la virtude, la qual se
chiama senso communo, over fantasia, la qual aprende tute le forme comprendude per li v
sentimenti. E zudegade queste dredo la remotion dele cose sensibile dela presentia dele virtù e deli
instrumenti sensibili de fora, in la seconda parte del primo ventricolo se ordena la imagination, la
qual e retien e salva le forme aprendude dal senso comun. In lo secondo ventricolo se ordena la
cogitation. In mezo de questo ventricolo se ordena la estimation. In l'ultimo ventricolo, over in lo
terzo, se ordena la cogitation. In mezo de questo ventricolo se ordina la memoria.
[7] E sopra el cerebro senza mezo se ordena uno panicolo mole et forte in substantia più che non ne
el cerebro, aciò che'l sia soa defesa, perché la dureza del panicolo sie perché è tessudo de artarie e
de vena a modo de rete, ligando e tegnando quelle artarie e vene insieme per la bontade de la soa
compositione particulare. E è seperado dal cerebro in alguno loco per le vene artarie, (p.136) le qual
asende dal panicolo dito e entrano in le comisure, over division del cerebro, e nutriscono la soa
sustantia e vivificano e danno a quello spirito vital, el qual dala rotura del cerchio fi digesto e
alterado, secondo como conviene in le etade e operatione de li animali. Sopra quelo velame, over
panicolo, se ordena uno altro panicolo più duro de questo, aciò che'l defenda el cerebro dal primo
panicolo, dela dureza del osso, che da quello osso per la sua dureza el non receva lesione. E questo
panica[o]lo sie tessudo de artarie e de vene in modo de hinde [deinde] ligado, e tegnando quele vene
2
5
10
15
20
25
30

e artarie forme insieme per la bontade dela soa composition paniculare. E se divide e non continua
con el primo. Sono [sennò] in alguni membri over luogi per li quali passano le vene sotile e artarie
el adiuvamento del panicollo più sotil e mior del cerebro.
[9] E quasi panicolo se chiama dura mater dali medesi overo la miringa
[10] Desopra dal cerebro.
[11] Ma l'altro panicolo, el qual senza mezo sie al cerebro, fi chiamado pia mater over la miringa.
Desoto non se continua con l'osso del craneo aciò che da quello per dureza el craneo non receva
lesion, sono [sennò] in algune comisure e zonture deli ossi del craneo per le quale parte panicolo si
ligamentale.
[12] Escono con le artarie e con le vene de li cappelli. De queste parte paniculose e ligamentale con
tuta la sua sustantia se fa panicolo de fuora, che copre tutto el craneo e cosi apareno quanto dubio
etiamdio timoreza se in la incision del timore del panicolo sopra le comisure e zonture del osso del
craneo e con perforation col trapano over raspatore in lo logo dela zontura over commisura, perché
la perforation over incision in tale logo fa nocimento al cerebro e ala dura mare. Adoncha non sia
fata operation con ferro in tale logo se'l sera possibile schivarla.
[13] Sopra ciò tu de sapere che'l cerebro in la parte denanci sotto l'osso dela fronte ha doi aditamenti
sotto li cavi dele mamele, in li quali la operacion de l'odorare se fa conciò. Sia che cerca le
caruncule mamilar del vaso el velame duro over panicolo desopra sia forado, aciò che le
superfluitade dele parte del cerebro denanci esano per quele vie etiamdio quelo medemo panicolo
over velame sia forado in la parte la quale declina verso el palado, aciò che le superfluitade delo
secondo panicolo e ultimo se purgano per quella via.
[14] Sopra questi doi panicoli, cioè la dura mare e la pia <mar>e, sono ordenadi li ossi del cavo,
over del craneo, li quali son vii e uno in fine, el qual è dentro el primo spondile e in principio de la
mità del osso del cavo, del qual la figura è a modo de questa littera V. Sostenne in la parte de driedo
tutti li ossi del capo. E perzò se chiama sustentaculo over osso basilare.
[15] El primo osso del capo del craneo sie l'osso dela fronte, el quale se chiama coronale e la soa
figura sie quasi de uno mezo cerchio e algune eminentie in la parte denanci e continuase con l'osso
3
5
10
15
20
25
30

del naso in la parte denanci a modo de una sega e in le tempie. In a gune altre parte se continua con
la masela a modo de sega.
[16] Continuase etiamdio con doi ossi grandi li quali se chiaman vernal a modo de sega e fase una
figura continuada a modo de una crose, de la quale la linea desopra sie remota da questi doi ossi
vernali se continua in mezo del capo a modo de una sega intrinseca. E continuase questi doi ossi
vernali a modo de una sega con l'osso de la lauda. E sotto questo osso se mete l'osso basilare, el
qual non se continua (p.137) al craneo ma sustenta quelo e compisse la figura del capo. Poi se mette
questo osso basilare a l'osso dela lauda e metase e fermase dentro quelo e la mandibula disopra e
per questo modo, e per la continuation de questi ossi, e per la continuation e aposition, la figura del
capo se compisse si como tu vedi. E da li ladi del capo, cioè da la parte destra e senestra, sono doi
ossi sopra li quali le orechie se fermano; e fi chiamadi ossi mondosi, li quali se continua con li ossi
vernali. Sono per sotometer l'una parte a l'altra e desoto in questi ossi verso la masela è sopra un
forame torto in l'os<s>o, el qual se chiama petroso, cioè molto duro, perché questo osso sie dela
sustantia de l'osso mondoso, per lo quale passa el nervo del audito.
[17] Sono adoncha li ossi del capo, li quali comprendono el cerebro, vi per numero e uno lo quale se
chiama basilar, el quale sie in la parte de driedo sostegnando li altri e compiando la figura del capo.
[18] Sopra questi ossi adesso sie el panicolo, fatto de panicolo dentro ligadi con le comisure del
craneo. E scende da quelle e dali comisure e fasse questo panicolo sotile e sparzese sopra tutti li
ossi del craneo e liga quelli dala parte defora. Sopra questo panicolo se fa la pele dura pelosa, la
qual se tese de vene e de artarie e de nervi, vignando le parte defora e specialmente se tesse dali
nervi li quali vengono dal primo forame del primo spondile e dal forame, lo qual dentro el primo
spondile, e secondo li quali se messedano con le vene e artarie e con li panicoli che tesono lo
panicolo che copreno l'osso del capo. E fase questa pele dura e habiando in si parte carnea e sutila
non bene aparente sotile fate ala oposition più grossa de questa pele e membro.
[19] Sapi che tute le incision meio se fano secondo meio<r> modo e secondo che correno i capeli,
perché li nervi dela pele dela carne secondo quello andar vano per la mazore parte. Ancora convien
saper che le incision, le quale se dieno far non è necessario che lese faza in ogni membro secondo le
crespadure, si come in la fronte avenga che le crespe se fazano per traverso le incision e
maximamente le profonde se dieno far per contrario dele crespe, perché i nervi dela fronte secondo
longeza e secondo le crespe procedano in lo capo. In la parte denanci se ordena el naso, fato de ossi
4
5
10
15
20
25
30

e de cartilagine e continuase con li soi forami e con doi eminentie simele ali capi de le mamele, le
qual son in la fronte, in le quale la operation dela virtù del odorare se compie. E dividese da parte
del nervo dal terzo pare de li nervi e è desopra el sentimento de quello loco. Senza quello el naso ha
uno foramo in lo palato e li forami del naso se continua con quelo forame, aciò che l'aere, quando se
serra la boca, possa aventar al cor etiamdio in l'hora del sono quando el dorme. Ordenase soto l'osso
in la fronte in la parte denanci da li ochi, li quali sono fati e componudi da tre humori e da vii
gonelle. In questo modo dal cerebro in le parte denanci dai nervi concavi se parteno e sono dal
primo paro deli nervi che hano el nascimento dal cerebro, li quali, quando se parteno dal cerebro, se
conzonzeno alquanto e fase una concavitade. De quelle doe concavitade e po se desparteno in lo
essire de quelli del craneo e lì se involzeno i doi panicoli del cerebro. E quando sono uscidi del
craneo el se fa de quelli uno panicolo grosso e duro. El se chiama selir<o>tico. Driedo questo se fa
dal ditto nervo cosi coverto un altro panicolo, el qual se chiama secondino, perché el fi fato dredo al
primo panicolo e fi situado e comprende dentro dali humori viteco. (p.138) E driedo questo panicolo
se fa un altro panicolo, el qual se chiama retino, perché ha tale figura e comprende questo retino la
mitade del humore cristalino dentro da si. Del panicolo retino se genera e fase el panicolo araneo e
chiamasi così questo panicolo perché el ha tale figure e comprende dentro da si la mitade del
humore cristalino e fase retondo al panicolo retino. Dedro lo araneo se fa un altro panicolo, el quale
se chiama uveo perché in la soa figura e disposition pare haver similitudine con un gran d'uva e sie
questo panicolo forado in mezo e questo se chiama forame dela pupila e constrenzese e largase
secondo che serà necessario de questo humore cristalino.
[20] La operation del veder si compise e comprende dentro da si tuto lo humore albugineo, el qual
sie necessario ala conservation del humore cristalino e questo humore albugineo ensirave dal forame
del panicolo uveo se'l non fidesse coverto. E cossì fo necessario la generation de uno altro panicolo,
el qual se chiama panicolo coreno e cosi fi chiamado per la sua similitudine la qual par haver col
corneto livido. Fo fato questo panicolo dal panicolo scilirotico e è ligado con quello tuto l'ochio
perché questa ligason non era ben ferma. Volse la natura per lo meio, aciò che più fermamente se
fesse la ligasone. Volse fare un altro panicolo più forte de tutti e fese uno panicolo, el quale se
chiama conzentura e comprende tutto l'ochio fora dela negreza, la qual nasce e fi fata dal panicolo
che copre el craneo defora dal qual nui disesemo che el fi fato doi parte paniculare vegnando per le
comisure over zonture del craneo del panicolo del cerebro.
Cossi apareno che per tute le vene per traverso in la fronte zova in lo descorso deli humori del cavo
over dal cerebro ali ochi. Dredo questo etiamdio viene ali ochi nervi del secondo pare deli nervi del
cerebro, per lo forame del craneo del ochio, li quali dano sentimento e movimento ali ochi da po
5
5
10
15
20
25
30

etiamdio comprende la salasadura dela vena dela fronte et etiamdio la salasadura dele vene de le
lagreme de li ochi, le quale da la parte del naso e come ela zova ale infirmitade deli ochi per la
visinanza per, lo corso de quelli deli logi deli ochi. Ma sotto li ochi dela parte denanci e sotto el
naso sie la masela de sopra la qual de xiiii ossi si compone, ma la compositione de quelli sie una
coniuntion oculta e non è ben sensibile e perzò dela soa composition e separation nui non faremo
mention. Ma sia messo per un osso per la separation manual in la dicta masela di sopra, nela qual si
forma denti xvi et in alcuna xiiii. Sopra deli ossi da la masela desopra l'osso e fi fato un panicolo
che copre l'osso dela fronte.
[21] E del terzo paro deli nervi del cerebro e dela parte del quarto pare e de la parte del quinto e del
secondo pare de li nervi dela nuca e del terzo, se fa la pele con vene e artarie convegnevole, la qual
copre quello e se li nervi, li quali sono in questa composition e li quali vene dali nervi dele parte del
cerebro e dela nuca dà nosimento e movimento in li membri dela faza e del palado e del naso, e
questo maximamente quando questi nervi intrano in le compositione deli muscoli manando queste
parte.
[22] Adonca el se conviene che le incisione, le qual se debiano fare in li logi de la mesela, desopra
del naso, che le se fazano secondo le crespe de quello logo, perché in questo membro le crespe vano
si come è la via del nervo e deli muscoli dela faza e del naso dal paro segondo e dal terzo deli nervi
de (p.139) la nuca e dal quarto viene li nervi ali muscoli dele maselle, li quali le maselle e la
mandibula de foro moveno. Questa masella de soto e se compone de doi ossi, i quali sono imento a
modo de siega e conzonzeno ad insieme. In la parte de driedo se conzonzeno con la masilla de
sopra, amezando el nodo, in la qual masella sono insicati in alguni xvi denti in algune xiiii, e
ligaseno questi denti de soto e desopra con le maselle, amezando li ligamenti e li panicoli vegnando
dal panicolo, el quale reze la masella de sopra, e ligando quella ad insieme e dali panicoli, ligando
quella masella desoto in lo mento e tuti questi panicoli e ligation destendando dal panicolo
derivado, che copre l'osso del craneo, el qual se fa del cerebro. Per questo appare como appare el
dolore deli denti. Offende el cerebro el capo per mezo e aduse dolor universale in lo capo.
[23] E dentro la masella desopra e quella de sotto sie ligato la lengua, la quale sie carne mole
biancha ventosa lacertosa e nervosa e si receve dal vi° pare deli nervi. El motivo ato in quello sono
due vene, le qual apareno quando fi levada e se salassa per infirmitade dela lengua e per posteme, le
qual se fano in la radise de quella.
6
5
10
15
20
25
30

[24] Ma pur el è da vedere perché la salassadura dela lengua in alguno caso non se die fare
universal salasso over ventosation in le spalle. Non se serà fata inanci over mondification con
medecina over cristier. Perché lo salasso dele vene dela lengua se denanci non serà fata alguna
molification de quelle le qual nui disemo. Trage la materia ala gola dove nasce la infirmitade,
specialmente se'l corpo sera repleto over stitico. Driedo le maselle e sotto li ossi nervosi in la parte
destra e senestra sono ordenade le orechie, sopra l'osso petroso duro forado e sotto le ossi mendosi,
li quali in la soa perforation molte involution hano in lo passar. E così prociedi infin al nervo del
quinto parte del cerebro, per lo qual nervo se fa l'aldire. E questo nervo sie concavo.
[25] Sopra questo osso nasce e fasse una cartilagine sparsa, in la qual sono li nervi sensibili,
vegnando dal panicolo, che copre l'osso del craneo e fi fato alguna parte mole carnose e sono là
algune volte de vene e de nervi semicirculare, le qual vene un poco insieme. E segondo quella
figura, el medego fa la incision in lo luogo quando la serave necessaria soto el capo in la parte de
driedo su la nucha, sopra la qual nucha li spondili del colo, li quali son vii, fi ordenadi, dela qual
nuca del colo escono vii para de nervi dali spondili sich' el primo paro si e<n>se dal primo forame
del primo spondile, el qual forame è verso li principii dela nuca, dove che la nuca la parte del
cerebro e fase parte deli muscoli.
[26] El ii° osso del secondo forame, el qual è dentro el primo spondile e'l secondo, mutano suso la
codega del capo e dano movimento a quella e scende alchuna parte se messeda ali muscoli del colo
e dano movimento a quelli.
[27] El terzo paro esce dal terzo spondile e sparzesse ale massele e secondo alcuna parte ali muscoli
dele spale. El quarto pare esce dal forame de sopra del quarto spondile e secondo alcuna parte ali
muscoli de la parte denanci e de dredo.
[28] El quinto paro esce dal forame desopra del quinto spondile e spandese secondo alguna parte ali
muscoli del diafragma e secondo alguna parte ali muscoli che moveno el capo e secondo alguna
parte ali muscoli dele spale.
[29] El sexto paro ese dal forame desopra el sexto spondile. El septimo ese dal forame desopra e de
sotto del (p.140) septimo spondile, in lo esito de quelle, e se sparze de sopra e de soto ali muscoli,
de sopra e de soto ali muscoli del collo e del capo e del torace e dela gola. Dredo li nervi e li
muscoli se ordena in lo colo vene e artarie manifesto e oculte. Le vene e artarie in lo colo molto
7
5
10
15
20
25
30

manifeste sono de dredo le orechie.
[30] La incision dele quale sie molto timorosa, perché per la incisione de quelle, per la soa visineza
el cor, con el polmone e col cerebro, se ne siegue strangosare e defeto de molte cose e per lo molto
flusso de sangue se ne siegue molte fiade morte.
[31] Appare adonca manifestamente che tutte le posteme del colo e tutte le incision, le qual dieno
far in lo colo, si se dieno far in quello loco, dela natura dela composition di membri del colo e delo
nascimento deli nervi per longo e dieno le artarie e le vene predite, le qual sono contegnude da
quello ladi, perciò che le artarie in quello logo sono grande sopra le vene predite.
[32] Et in quella hora dano loco, siché la vena in quello loco non se po taiar over forar, che la artaria
non se impiegasse e perforasse; dela perforation de laqual advignerave quello ch'è dito in la parte
denanci sono. Sopra li spondili del collo dal ladi dela gola è logada la canna del stomego, la qual se
chiama merisfagus, per lo quale passa el cibo e la bevanda al stomego ed è componuda de vene e de
lacerti, de artarie e nervi, che vengon dal sexto paro de li nervi del cerebro e continuase verso la
gola con la canna del polmon, over trachea artaria, ch'è una medema cosa, la qual è componuda de
lacerti e cartilagine nervi che vengono dal sexto pare deli nervi dal cerebro e è rugosa e ha mezi
circoleti verso la parte de fora in la continuation con el meri over con la canna del stomego a
planura e basseza in la soprana parte de quella alo epligoto e covertura, azò che in l'hora del manzar
el cibo non entra in quella ne alcuna cosa che offenda se non aere overo alcuna cossa a modo de
aere.
[33] Et intendi per lo epligoto una eminentia con la figura la qual apare in la gola in capo dela
canna; la qual figura sie necessaria a diverse vose da essere generade. E sopra quella copertura è
posta la radise dela lengua e gli è uno instrumento el qual s'apoza al palado in lo quale fine è una
cosa la qual è necessaria a fendere l'aere e a diverse vose da esso generade, maximamente quando
forma e figura e quantitade naturale ele retegnera:e perzò, quando passa el modo, te impaza la vose
e'l fi taiado azò che'l sia meglior instrumento a vose diverse.
[34] Sopra questa carne sono ordenadi nervi grandi e picoli, manifesti e oculti, li quali vengono dal
sexto e septimo paro de nervi del cerebro. E mesedasse li muscoli del colo e dela gola con li nervi
del terzo e del quarto paro deli nervi dela nuca e del polmon son doe vene manifeste grande, e soto
quelle son doe artarie, per la incision dele quale perforatione discorre el sangue del polmon, dalo
8
5
10
15
20
25
30

quale elo viene senza mezo e compartise da quello el polmon per la visineza e fi impazado in la
operation, el cuor li compartisse e fase morte subitana per questa cason. E per questo tute le
incision che se fano in la gola - per qualunqua cason se fazano - se dieno far per longo e schivare
tute le vene dela gola secondo el podere, specialmente le grande.
[35] E queste se chiamano guidez perche ogni vena dela gola e soto sie una artaria oculta per la qual
el capo ha maxima visinanza e se ameza col polmon e con lo cor. E così ogni incision de questo
luogo par timorosa e sensibilmente e (p.141) manifestamente apare.
[36] Sapi che la gola se continua con la forcola del peto in loco e chiamase pesse dela gola, over
continuade128. Continuasse el colo con la parte de dredo con l'octavo spondile, el qual è principio
deli spondili del torace e continuase etiamdio con l'osso dela spala quasi infin al'humero, aciò che
più fermamente e meio se mova con necessario e aciò che la soa figura para più bella e più nobela.
Capitulo II dela nothomia e figura del humero e del aiutorio e del brazo o schaio
[1] Driedo el colo e la gola dal lado destro e senestro sie ordenado lo humero, in lo quale tri ossi se
continua, aciò che la figura è miore e più nobele e più bella e più utile sia fato per movimento e
operation.
[2] El primo deli quali de questi ossi sie detto dela spala; la figura del quale verso el colo e la parte
de dredo sie, habiando largeza a modo de instrumento col qual li fornari ca<v/tt>ano el pan del
forno, e in la soa longezza è in parte aguzo, el qual se stende infin al capo dela spala, verso lo
humero, passando per lo mezo de quello per fin a una grande largheza, la qual è verso el colo, in la
qual ampleza larga sie continuamente una cartilagine. E quella cartilagine se spande per la parte deli
spondili. Inverso l'altro lado e verso lo humero, ha l'osso dela spala e una grosseza. Infin de quella
sie una vacuitade, la qual se chiama bossolo de l'osso dela spalla. Lo qual bossolo se volze el capo
rotondo de l'aiutorio, secondo como se convien ala operation de tal membro. Fato questo corale e in
tale figura, aciò che li ossi del peto e'l colo romagna fermamente in li soi lochi e aciò che'l
movemento de l'aiutorio romagnise meio, più fermo e più seguramente in lo humero e acioché per
lezer cason non se fosse deslongason de l'aiutorio.
[3] Apare per questo manifestamente che l'osso del aiutorio non se deslonga ala parte de dredo. Ma
128concavitade nell'edizione del 1486
9
5
10
15
20
25
30

da la parte denanci fi ordenado in lo humero uno capo dela forcola e continuasse con l'osso dela
spala e esce de tre ossi del humiero, aciò che'l membro romagna in la soa fermeza. E romagna
quello loco in la soa fermeza che'l non se inclina per lezier casone ale parte denanci e perché questo
in la continuanza sia diminuido da l'osso, dà la continuanza de la spala, aciò che più bella se faza la
figura del loco, aciò che non impazasse lo loco del vertebro. Così apare manifestamente come, per
la diminution de questo osso, in quela parte el vertebro del aiutorio se po deslogare ale parte
denanci. Dredo questi ossi sono li ligamenti insensibili, li quali ligano e continuano questi ossi ad
insieme, zoè in mezo del bossolo, per la rotura del qual continuo overo estension over separatione fi
impazada, la restauratione dela deslongason del vertebro in tanto che'l non se forma in lo suo sito,
che elo da cason non salte via el capo del loco dredo la restauratione.
[4] El terzo osso del humero sie quelo, el qual defora sie gobo e dentro cavado. Questo osso sie
medoloso, azò che'l receva nudrigamento se'l sera necessario de la medola per la grande sicitade
soa. El capo de sopra sie rotondo e intra entro el bosolo dela spala e se volze e continuasse li
ligamenti e mezandoli con li altri doi in lo loco si como è dito.
[5] Ma l'altra extremitade se continua alo aiutorio in lo gombedo con l'osso, el qual ha la figura
simile dela rotula con la quale se traze l'acqua. In la qual rotula la extremitade del focile e sopra
entra. E sapi che'l focil de sopra sie menor e (p.142) dala parte del dido grosso in fin ala parte del
gombedo. E l'altro focile sie desoto e sie più longo e più grosso e mazore, qual va ala parte
salvadega, cioè del dido menuello, al gombedo e fi sopramesso con una eminentia che a ponta e con
longeza alo adiutorio e ala soa rottola e fa la figura del gombedo aguza quando se piega. E questo
fo, aciò che quello logo col capo de l'aiutorio fermado in la rotula romagnisse per lo fermo e aciò
che lezier cason per la supposition del focile mazore sopra del capo de l'aiutorio. Questo logo con
forte ligamenti insensibile fortemente, aciò che la figura del membro e la situation de quelle osse
romagna in fermeza e acioché l'homo possa levar li cargi e sostenire, aciò che'l brazo non declina
verso la parte salvadega, over de fora, e in quello logo el focile de soto over mazor. E cerca la soa
eminentia receva forma e semicercolo. Drito el gombedo fi ordenado doi focili, li quali secondo
longeza se continua adinsieme, amezando li ligamenti e intro in lo menor è lo mazor quasi como
sega. E ciascaduno de questi focili ha uno zonzimento in lo loco là che el è conzò con li ossi dela
raseta. Son viii e fi ordenadi. Quatro se continua con li ossi del petene dela man e ligasse insieme
con questi dela raseta e non hanno medola per la dureza espesega de quelli.
[6] Ma li ossi deli focili hano medola per la cason narrada in l'osso de l'aiutorio, e avegnadio che'l
10
5
10
15
20
25
30

non apara in lo focile menore cossì manifestamente si como in lo mazor, tamen in quello luogo è
una raritade overo porositade del dito focile menor, in la qual se trova humiditade a modo de
medola. Dredo li ossi de la raseta dela man fi ordenadi li ossi del petene, li quali sono quattro e
ligase per la visineza e continuasse nodosamente de una extremità con li ossi del dido grosso primo
e grande. Se continua ala extremitade del focile de sopra in lo logo dela zontura e questo fo azò che
più fortamente meio se movesse e ali iiii didi più decentemente se conzonzesse. In ciascadun deli
didi dela man son iii ossi, li quali con ligamenti ad insieme nodosamente se conzonzeno. Sopra
questi ossi e ligamenti sie ordenadi li nervi deli spondili con el colo e dal vii° e dal viii° deli quali
con carne simplice e con ligamenti. De questi ossi se fano li muscoli, li quali moveno lo humero, lo
aiutorio, el gombedo, el brazo. E dala extremitade de queste muscoli nasceno le corde per le qual se
moveno li didi e li membri de soto, deli quali muscoli uno grande e manifesto è in mezo del
aiutorio, si ché alguna soa parte è in la parte domestiga e l'altra soa parte in la parte selvadega, dele
qualle corde che moveno el brazo si divise secondo diverse parte. E in lo logo sie un altro
manifesto, declin<a>ndo ala parte salvadega per lo più, e spandele per lo brazo, per lo qual diverse
coste se parteno, che moveno li didi ale parte dentro e de fora, secondo la necessitate. Driedo questi
muscoli sie ordenado vene manifeste e occulte; una dele quale le parte dala saphena, over dela vena
de laqual è manifesta in lo scaio, quando la pressa per lo humero desopra el gombedo e fi chiamada
cefalicha perché la è dela vena, la qual una parte monta al cerebro e quello con li membri fa
humido. E questa parte li membri deli brazi nutrisse, unde per questa visinanza così se chiama. Da
queste humerale viene una altra manifesta vena, la quale passa per le parte manifesta per lo
adiutorio, per (p.143) lo brazo e revolzese per la parte de l'aiutorio del brazo, lo qual se revolze
secondo questa figura e però fi così chiamada. Dal schaio desoto vien un altra, la qual passa per lo
profundo de l'aiutorio infin al gombedo e la in le parte desoto del gombedo fi manifestada e fi
chiamada basalicha, e passa per lo focil desoto salvadego, e fa rami dentro el dido de l'anello, el
menudelo, e in quello loco se chiama salvatela over epatica over splenetica.
[7] E dela humerale cefalicha over aselata in la parte desoto nasce e pare una, la qual è in la
piegadura del brazo in mezo e fi chiamada purpurea over negra over comuna. E questa vena serva
ale parte desopra e desoto e però cossì se chiamada. Soto tute queste vene, si ch'è soto ciaschaduna
vena occulta over manifesta. De questi muscoli, così componude con vene e artarie e carne e con
alcune parte de nervi sensibili, se fa la pele de questi membri e fi coperti li ossi. E per le parte deli
nervi sensibili vegnando dala composition de quella, se fa la parte de fora sensibile.
[8] E per le vene manifeste li membri manifesti senteno doglia in questo loco. Ma el è manifesto per
11
5
10
15
20
25
30

queste cose le qual nui havemo dito, come fa mestiero che'l medico proceda in la incision de questi
lochi e in le posteme de quelli, che conciosia che tuti li muscoli e nervi, corde, artarie e vene
procedano secondo longeza del humero, infin ale extremitade deli didi e'l requireno questi lochi le
incision e le cauterization secondo loco. Apare como la vena cefalica, la qual è in la pi<e>gadura
del gombedo, in la parte desopra la qual fi manifestada in lo focil desopra menor e passa dentro el
dido grosso e'l dido secondo che se chiama [...] indusese al cavo e ale parte del capo.
[9] E con la vena, la qual è in la parte desoto e in la piegadura del gombedo, la qual passa per lo
focile desoto e fi manifestada in la man dentro el dido de l'anelo, el menud<e>lo. serve al figado e
ala spienza, perché la fi separada da una parte dela vena, la qual nutrisse membri desoto. E questa in
lo dito loco dela man se chiama salvatela. El è cognosuto come la vena comuna serve ali membri
desopra e desoto, le qual manifestamente appare in mezo dela piegadura del gombedo e questo sie
perché del humeral desopra e dela asela desoto ela nasce e fi componuda sì come manifestamente
apare.
[10] Sono adonca tuti li ossi de una man sì come apare, deli [dei quali] se ha cognosenza per
numero xxvii e questo è se noi faremo separation dela rotula e l'aiutorio.
[11] Ma se non sono xx solamente, sapi che tute le vene le qual vien desopra del figado, derivano
del ramo menor de la vena grande, la qual ha el nascimento dal figado.
[12] E questa vena se divide in doe parte; dela qual vena parte va al diafragma, e l'altra parte va ala
capsa del core e l'insire de quelo se divide. E una parte de quella se continua ala orechia destra del
core, e dividese questo ramo in iii rami, deli quali uno entra in la concavitade del cor, el secondo se
spande sopra le superficie del cor, el terzo se spande per le parte de soto del peto ala forcola. E dal
ramo dela forcola nase el ramo el qual va al humero e al scaio, e questo ramo passa per le parte
interiore dela gola e va al cerebro e al capo e al mento desopra e finisse secondo necessita.
Capitulo iii dela notomia e figura dela forcola e dele coste e del torace dela spina.
[1] Soto la gola in le parte denanci nascono li ossi dela forcola, li quali defora sono gobi e dentro
cavadi, di quali l'uno di doi capi continuasse con l'humero e l'altro (p.144) capo se continua con la
simelitudine del peto, dove è el bussolo dela gola.
12
5
10
15
20
25
30

[2] Sotto li quali ossi dela forcole e bossolo fi ordenadi vii ossi in lo peto, del qual in la extremitade
de queli vii ossi una cartilagine, e dura la longeza de questi ossi, con continuation del bossolo dela
gola infin al figato soto le mamelle. E in quello loco sie la bocha del stomego propriamente over la
vacuitade de soto dal peto e chiamase questo longeza con la continuation de questi ossi
propriamente lo torace. La composition de questi ossi con le coste e con la spina de dredo fi
chiamadi propriamente el peto.
[3] Ma le coste sono xii, le qual se continua con xii spondili e chiamase propriamente questi
spondili del petto.
[4] Ma li altri spondili, li quali sono v, fi chiamadi spondili de le rene; le qual xii coste se piegano a
modo de mezo circulo. Dele qual xii la extremità dredo se continua con li spondili del dosso e la
mazor de qual le è in mezo. Ma la soa extremitede [sic] denanci se continua con le cartilagine deli
vii ossi del torace. Ma v dele dite xii coste se piegano e mai non se continua al torace ma ali
spondili de dredo fi chiamade le coste de dredo, e quando le soa extremitade, le qual sono in la
parte denanci, fi prenude e le fi trovade piegade ale parte dentro, perché le non hano sustentaculo si
como le vii grande, le qual ha li ossi del peto, se continua e da queli receveno fermeza dentro queste
coste o ossi del torace. E dentro la concavitade de le coste e sopra li spondili del pecto, el core
declina secondo la soa situation più ala parte senestra e secondo la soa acuitade più cerca ala parte
destra, se reflete al polmon, in quella medema vacuitade è situado.
[5] Ma secondo el sito più declina ala parte destra, el suo mezo è inclinato manifestamente ala parte
senestra. E etiamdio in quello luogo è uno velame nervoso, el qual è de<l>a generation del
diafragma e è tessudo de nervi e vene grande e pizole, si como è ensteso el diagfragma, e parte
divide el pecto per mezo secondo longeza. Ma siché una parte se divide da l'altra manifestamente e
continuasse questo velame, che divide el polmon per mezo el pecto con li xii spondili de dredo del
pecto, e non fa questa division per altro se non perché, se aduna mitade del polmon advignisse
alcuno accidente, che la natura con l'altra mitade in la atration de l'aere e aspiration se posesse
aiutar.
[6] E fo provision naturale per la nobilità dela operation de questa virtù e per la soa necessità del
primo spondil del pecto e otavo de tuti li spondili. Comenzando dal principio dela nuca vegnano li
nervi sensibili e motivi del peto e torace, deli quali li muscoli del dito peto si componeno.
13
5
10
15
20
25
30

[7] E tu die saver questo ch'è li muscoli e li nervi motivi voluntariamente, e questi veneno dal vi e
vii paro nervi del cerebro e etiamdio dala nucha. Alcuni sono motivi per la natura dela composition
delo dito torace.
[8] E questo fi saputo per la condition del apopletico, in lo quale lo torace se move in l'hora dela
incisione e non se move el peto in quela hora, per la virtude vegnendo dal cerebro, conciosia che in
quela hora el cerebro se trova tuto opilato, siché la virtude, e con li spiriti de l'anima, e deli nervi
non possono destendere. Ma le vene vegnando dal panicolo, che divide el peto per mezo, che
vegneno dal nutrimento del peto, sono li rami del secondo ramo minore dela vena granda, la qual ha
el nascimento in lo gobo del figado; el qual ramo vien dal diafragma e dal diafragma vien questo
panicolo che divide el peto per mezo secondo longeza, e viene con (p.145) queste altre vene dal
terzo ramo dele vene permesticade in la orecchia destra del dito core.
[9] Ma quelle, le quale vieneno dal terzo al panicolo e al pecto, vengono per ramification de uno
ramo diviso dala artaria mazor, la qual nasce in la senestra orechia del cor e passa ramificando
ciascuna vena, acioché le membre, le quale de alcuna vena fi nutride dale artarie che passano soto
quelle, fi vivificade e reservade.
[10] Tu die savere che tute le artarie manifeste le qual vengono a nutrire e vivificare le membre del
pecto e del torace e specialmente in le parte de fora, vano secondo l'andar dele coste e deli ossi del
peto, over del torace, e specialmente li nervi grande che vengono ala composition deli muscoli del
pecto, che hano el nascimento dala nuca overo dali spondili del pecto.
[11] Apare adonca manifestamente como e in che modo se deno taiar le posteme in questi logi, e
como in quelli se deno far li cauterii se'l serà necessario. Perché se avien che questa operatione sia
fata secondo l'andar dele coste per lo più, e cossì non sera alcuno ingano in lesion del nervo
secondo el suo contrario andar, la qual cossa è molto bona e utele per li infermi e finalmente per li
medesi [medici] rendono etiamdio tale incision fate secondo l'andar de questi membri dela cicatrice
e più veloce, conveniente secondo la forma deli membri si como manifestamente apare.
Capitulo iiii dela nothomia e figura del ventre de fuora, dela boca del stomeco infin ale anche
e ali spondili de questa parte.
[1] Driedo le coste in la parte denanci sie la pele de fora, che copre el stomego e li budeli, e
14
5
10
15
20
25
30

continuase con la malitia infin a l'osso del petencio [os femoris]. E <s/f>ase questo loco tuto mole
in fina a quela parte e fi chiamada questa pele defora ventre. Soto questa pele fi ordenadi li muscoli
necessarii a questi logi e sono viii per numero. E za nui diremo dela compositione de quelli. Dredo
questi muscoli in la parte dentro fi ordenado uno panicolo rugoso che contien el cibo e li budeli per
la rotura del panicolo rugoso, el quale se chiama sifac.
[2] Advien el descendere del cibo ala borsa deli testicoli e fi fato alcuna fiada solamente eminentia.
[3] Lo petenegio per lo descendere al desoto e in quela fiada sanno li medesi che la rotura del sifac
non è molto grande, la qual fi curada de lezier con impiastro e con riposso e con lo zitarse sopra la
spina con lo corpo in suso. Soto questo sifac se mete l'osso del petenegio fato a modo de mezo
circolo. Se non che in la parte de sotto ha una eminentia e fi ligado con le anche in lo inguinaio,
aciò che elo faza distantia, aciò che'l sostegna queli loci da ligamento over ligamenti, sotto lo quale
e in lo quale molto ample sono artarie e vene. Sopra quello che merita la soa mesura è questo corpo
nervoso venoso e artarioso. Cossì componudo fi apelado el membro del homo id est el
malmenchion, in capo del qual'è carne molto sensibile coverto de pele, aciò che la sia defesa dali
nocumenti extrinseci e aciò che per lo fregare de quella sopra el capo dela verga e per lo movimento
inanci e in dredo de quella pele sopra el <capo> dela verga mazor delectation s'aquista nel coito e
per tal fregar la sperma meio se manda fora e li vaseli dela sperma, per lo passar dela verga, induta
per lo mover dela pele sopra quello, el sperma meio manda fora e cerca ale parte de fora del sifac.
(p. 146) Poi descendano dui canali deli quali, quando se defendano li focili, dentro se generano le
tunice deli testicoli, in lo quale li diti testicoli fi contegnudi. E vengono conzò a la parte deli
testicoli dale parte de soto rami de vene, le quale descendono da le rene per molte maniere involti, e
da carne glandulosa e bianca fi comprendude. Se converte in sangue e in quelle vene in tanto che
receva forma de bianco in quella fiada. E questa carne manda questo ali testicoli e fi fato in quello
logo el sperma perfeto in quello logo. Poi se genera doi forami, li quali vano ala verga dela qual se
fa el drizar. Quando se sgonfa, e li forami grossi de quella son pieni de ventositade, e le soe vene de
humiditade, e le soe artarie de spirito e de calore e fi movesti li diti vasel de sperma da la
moltitudine del sperma e de la acuitade de quella e non cessa tal movimento infin che'l dito sperma
non fi cazado fora.
[4] Ma del panicolo defora, quando el se destende secondo lo logo del petenegio e del didimo, sopra
li canali li quali vegnano al sifac, fi fato la borsa de fora deli testicoli.
15
5
10
15
20
25
30

[5] Ma in la femina in logo dela verga fo el colo dela matrice. E la dita matrice fo nervosa, aciò che
la se potesse destendere e amplar in l'hora del parto, quando sera necessario. E ha conzò dui
aidamenti, li quali se chiamano corni. E soto questi aidamenti ela ha testicoli pizoli e largi. El suo
colo per comparation ali testicoli se a modo d'una verga volta. El capo del colo in l'hora de mandar
fora el sperma, toca li testicoli e queli move, aciò che meglio geti el sperma ala concavitade dela
matrice. E l'altro capo del colo si sporza ala vulva dela femina. In quello entra in la vulva e in lo
colo dela matrice e l'hora del <co>ito la verga del hom. Se lega propriamente la matrice dentro el
budelo e la vesiga per propria unione. E se più longa dela vesiga e sta ligado con le anche e con la
spina con ligamenti largi e non streti, aciò che la se possa movere e amplare in l'hora del parto over
dela conception. Dredo el fine de xii coste e deli soi spondili in la parte de dredo ordenadi v
spondili dele rene, e continuasse in la parte desoto verso la coda con l'osso ultimo, el qual osso de
iii ossi oculti per sir componudo, li quali se asomeiano quasi ali spondili in figura; al qual osso
ultimo el osso cartilaginoso dela coda se continua; el qual de tre parte se contiene. E' la soa terza
ultima cartilaginosa. E semplicemente da ciaschaduno forame de questi spondili nasce un nervo.
Dal osso dela coda solamente esce un nervo, perché'l non ha se non un forame, e li nervi li quali
vengono da questo v spondili vengono ala composition deli viii muscoli del ventre de fora.
[6] E le vene dela vena mazor che descende per dui rami dove sono le rene, al'altra parte de quella
vena mazor separada dal figado over li forami, vengono per lo dosso e per la parte de fora a
nutrimento de quelli membri e deli muscoli del ventre.
[7] E dala artaria mazor discendando dal diafragma, vengono rami a questa parte de fora e a questi
viii muscoli dal ventre, li quali vivificano in queli logi e scaldano dentro. A questa concavitade sono
ligadi tuti li membri nutritivi. E soto li spondili sie uno membro nervoso, texto de muscoli, de nervi
e de vene grande e artarie, e movesse per movimento de inspiration e de respiration, divide li
nutritivi da li spirituali e fi chiamado diafragma. E tien lo logo del core che ventoleza in questa
operatione. E quando in questo membro fi impiagado, si per la soa composition como per la soa
operation, (p.147) utele e necessaria, continua, fi zudegado la soa piaga incurabile e mortal
simplicemente la qual cosa è più. Soto el diagfragma in la parte destra naturalmente è logato el
figato, al qual è ligada la redesela, la qual è radise de tute le vene dentro e de fuora e ha in la soa
concavitade in mezo el chisto del fiele, overo el sachelo de la colora, dal quale dui vas<e>li, over
doi canali, fi separadi, l'uno deli quali parte la colora a confortar le cosse digestive in lo stomego, e
l'altro porta la colora ali budeli, acioché la explusiva129 sia confortada e la viscositade sia removesta
129expulsiva nell'edizione del 1486
16
5
10
15
20
25
30

da le fece.
[8] Ma in la parte senestra fi logada la spienza, e ligase con el figado. E la dita spienza per debite
vie manda de queste superfluitade a la boca del stomego aciò che la conforti l'apetito e al<g>una
parte de quella manda a confortare la retentiva in li budeli e stomego. In mezo de questi membri el
stomego de quella parte de sopra è streta e la soa dentro molto ampla. E terminase la soa parte de
soto in lo logo del ombilico e fi chi<a>mado primo vaselo, in lo quale la natura a la prima digestion
complisse e fa con lo fondo del dito stomego, in lo qual principalmente finisse la dig<e>stion. E
continuasse li budeli, li quali secondo una visibile differentia sono vi. Al primo de liquali è el
duodeno perché la soa longeza è'l secondo numero deli xii polici.
[9] Ma dredo questo sie el dezuno e fi chiamado cossì perché sempre se trova vacuo e in questo,
specialmente in lo duodeno e in lo fondo del stomego, sono insise le vene miseraice, per la qual el
figado traze la puritade del sangue del cibo digesto a si. E questi membri la dita putredine, zoè
puritade, caza al figado. E col dezuno se continua il colon ver el budelo sotil. Dredo questo fi
ordenado el monocolo e fi dito cossì perché el non è forado seno da una parte. Con questo se
continua colon over el budelo gobo. Con el gobo se continua longano e dritamente, va su per alguni
spondili de le rene e finisse in lo culo. E circondano el forame del dito culo v vene grande, ale quale
el figado e la spienza cazano molto sangue melanconico. Quando s'apreno queste vene, fano
morene sopra questo budelo in l'hom e verso el petenegio e in la femina verso la matrice, cioè sopra
la boca dela matrice. Verso el petenegio è logada la vesiga, la qual vesiga sie vaselo de l'orina e sie
nervosa. El suo colo sie carnoso per la mazor parte e ha in fin due tuniche sono, in quelle vene e
artarie menude, dale quale ela aquista nutrimento e vita. E passa el suo colo sotto l'osso del
petenegio e sotiliasse in l'osso de quelo a le part<e> de fora e fase la via de quella a modo de una
vena granda in l'homo e entra in la compositione de la verga per mezo. E per quella parte esce
l'orina.
[10] Sono adoncha in la verga de l'homo dui forame; almen uno per lo qual se manda fora l'orina, e
questo se continua al colo de la vesiga, e l'altro per lo qual se manda fora el spermo, e questo se
continua con li vasali del sperma. E fi fati questi doi forami l'uno in la carne de la vesiga. Vero è che
alguni disse che in quello logo sie el terzo forame, per lo quale la natura in lo sono manda fora el
sperma e sie differente da li altri.
[11] Ma quello da mi non è stato cognosciuto. In la vesica dela femina non se require e questo
17
5
10
15
20
25
30

perché el è molto curto. El suo sperma per questa via e modo non fi cazado fora. E è streto e per la
soa curteza la natura è possente per cazer fora ogni superfluitade e contegnudo in quella, dela qual
genera grossa e soti<l>e. Infin deli xii spondili dele coste e sopra el primo spondile (p.148) dele
rene, è alogade le dove [due] rene in la parte dentro del corpo. Del destro è più a lato el senestro da
le concavitade, deli quali se divideno dui canali e descendeno zoso, infin che li se conzonzeno ala
gonela dela vesigha de fora, e dredo questo entrano in lo colo de la vesiga e destendano e forano
l'altra gonela dela vesiga. E per questa vien secondo questo modo passa l'orina dele rene a la vesiga.
E fi chiamade queste vie pori virilides. El è manifesto che l'andar deli nervi che vengono dali
spondili dele rene e le artarie, vano per la mazor parte in lo ventre defora e in l'anguinaia secondo la
pieta de questi luoghi e perzò el è buono la incisione, che le posteme de questi luogi procedano
secondo quella pieta e rugation. E li cauterii etiamdio secondo quello modo dieno sir fato in questo
luogo.
Capitolo quinto de la nothomia e figura de l'ancha, del dedo grosso dela gamba, del pé e deli
dedi e de le membre permagnando in questi.
[1] L'ossi de l'anche sono ii, cioè uno in la parte destra e uno in la parte senestra e ciaschaduno de
queli in la soa parte se continua con l'osso ultimo de la spina, el quale se compone de tre ossi, over
parte le qual sotto simele a li spondili dele rene. E in quella parte l'osso de l'ancha a uno cartilagine
con una largeza e in l'altra extremitade elo ha una grosseza manifesta, in la qual el bossolo de l'anca
se continua, over entra la extremitade redonda de l'osso dela cossa, la qual se chiama vertebro. E fi
ligado questo logo con ligamenti forti insensibili. E in mezo del <b>ossolo sie uno ligamento, el
qual amezando fi ligado al vertebro o col bossolo, el qual ligamento, quando se rompe, over
destruze, quando l'osso esce dal logo, avenga che dal logo sia restaurado la zontura, non dura in lo
logo; ma salta fora e non fi curado in soa vita che elo non zotischa. El segno dela molification de
quelo ligamento sie, che quando el vertrebro se restaura perfectamente, che la restauration non dura
e non se forma; ma sempre se salta fora. Dredo lo bossolo fi ordenado l'osso dela cossa, el qual sie
uno osso medoloso, de fora gobo, dentro cavado, del qual la extremitade desopra intra in lo bossolo
de l'ancha e è molto rotondo e ligase si como noi disessemo. E in quelo logo se volze in l'hora del
movimento de la gamba del pede la cossa.
[2] Ma l'altra estremità de soto intra in lo bossolo del mazor deli focili dela gamba. E in quelo logo
se continua con li doi focili dela gola e fi ligado con forti ligamenti insensibili e questo fa in
ciaschaduno nodo, aciò che né per fregamento, né per movimento de membri, li membri sentisseno
18
5
10
15
20
25
30

algun nocimento e fi desse offeso.
[3] Sopra questa giontura, la qual è in lo zenochio, fi sopramesso un osso rotondo cartilaginoso, el
qual fi chiamado da alguni mala over rotula. Soto el zenochio fi ordenadi li ossi de la gamba, li
quali sono medolosi. Continuasse segondo longheza infin al calcagno quasi permeschiadamente e fi
chiamadi li doi focili de la gamba.
[4] Ma el mazor è più longo e'l più grosso e fi chiamado el focil de soto.
[5] Ma el menor è sotile, el qual sie più curto e fi chiamado el focil desopra. E è quelo el qual fa la
schiena dela gamba. Questi doi ossi anno in la fin in le parte desoto dui azonzimenti. E continuasse
con <l'>osso del calcagno e conzonzese l'osso, el qual se chiama sub a queli ossi, cioè a l'osso del
calcagno e a la navicola e a sub.
[6] La rason del pe se conzonze, la qual secondo alcuni se compone de (p.149) iii ossi e secondo
alcuni de iiii. E questa sententia sie più vera, zoè le iiii. La raseta del pé se continua al petene, el
qual è componudo de v ossi; ali quali ossi el petene del pé se continua li ossi deli didi del pé, e
sono xiiii per numero, perché in ciascadun dido del pé sono iii ossi. Nel dido grosso, in lo qual sono
altro che doi, perché non bisogna de grande movimento e non è cosa necessaria per la figura deli
didi quando se piegano perché cotali didi non require cotal figura.
[7] Ma in lo dido grosso dela man fo necessario e perciò el dido grosso dela man [h]a tri ossi.
[8] Sono adonca si come apare li ossi de tuto el pé con l'ancha da una parte, trentauno. Dali forami,
dali cinque spondili e dal forame ultimo de l'ultimo osso se divideno li nervi, li quali fi ramificadi e
vengono a la parte de dredo a l'anca secondo una longeza, e dano sentimento e movimento a queli
lochi e mesedase con ligamenti e con la carne. E dredo quello loco se fa el muscolo in la cossa
granda, el qual se sparze quasi per tuta la cossa dal qual se sparteno, da una parte e da l'altra, over
extremitade dele corde, movando le parte desoto e desopra, specialmente del zenochio e dela gamba
e fi manifestade due gran corde movando le parte de soto e desopra. E soto el zenochio etiamdio
moveno instesa la gamba, retrazando e destendando e tuti questi nervi con li muscoli e ligamenti
vano secondo la longeza de la cossa e de la gamba.
[9] Fi fato etiamdio dali rami de questi nervi, che vengono dali forami deli spondili, dele vene, de
19
5
10
15
20
25
30

l'ultimo osso, muscoli grandi e pizoli in la gamba, dele extremitade deli quali naseno corde, le qual
moveno li membri desopra del zenochio e li membri desoto del pé e li didi. E fi fate per lo zenochio
de quela in la schena de la gamba alcune composition de nervi e de muscoli nobile per natura; li
quali nervi over muscoli per la soa infeltration, quando fi impiagadi over fi ponti, portano li
nocimenti ale soe radixe el dolor in tal mainera che'l medico per alcuno inzegno non li pò dar
remedio che lo infermo non mora. E perciò le piage de questi lochi sono timorose. Li rami dele
vene se parteno dal ramo mazor dela vena, che ha el nascimento dal figado. E li rami dele artarie si
parteno dele artarie che vengono dal ramo mazor dela orechia destra de osso cor del driafragma,
descendono per lo dosso e mesedase insieme con quelle vene e vengono a le inguinaie e l'anca e
descendono con li nervi e muscoli secondo longeza, infin ala extremitade de li didi. E de tute queste
cose fi fata la pele de li membri esteriori e sensibile e fi nutrida e vivificada.
[10] Apare adonca manifestamente como la incision dele posteme de questi lochi se dieno taiar
secondo la longeza dele cosse e dele gambe, como sopra l'anca secondo longeza deli spondili dele
rene se die far la incision e non secondo la longeza del corpo. E li cauterii de questi lochi in quello
medemo modo se die far secondo l'andar deli membri.
(Qui finisse el quarto libro e comenza el quinto.)
[...]
20
5
10
15
20